Prendendo in esame due sistemi posti a tutela dei soggetti conviventi con uno stato di invalidità rilevante, si intende dimostrare che le rispettive misure previste dalla normativa vigente determinano una discriminazione non ragionevole, quasi oscura. Le prestazioni in questione sono: l’invalidità civile e l’assegno ordinario di invalidità.
Una breve premessa è necessaria, quantomeno per rendere chiaro il contesto ai lettori meno esperti nel settore. La prima (tecnicamente invciv) è un’indennità di natura assistenziale riconosciuta a quelle categorie di istanti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di lavoro o servizio. In questo caso, nell’assenza di qualsiasi presupposto assicurativo presente o passato, viene garantito un trattamento economico in misura fissa per tredici mensilità all’anno e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
La seconda (l’assegno ordinario di invalidità) è una prestazione previdenziale che, ai sensi della L. 222/84, spetta (anch’essa per tredici mensilità) ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria in presenza di una riduzione della capacità lavorativa in riferimento alle proprie mansioni, o settore lavorativo più in generale. Ebbene, passando alle somme erogate e ai requisiti richiesti, l’invalidità civile prevede l’assegnazione di 290 euro al mese a fronte di una percentuale di invalidità almeno del 74%; il pagamento cessa qualora il beneficiario abbia un reddito superiore a 4.800 euro, oppure più alto di 16.500 se invalido totale (100%).
Diversamente, l’assegno ordinario di invalidità consiste in una vera e propria pensione, dunque di importo quantomeno pari al trattamento minimo (500 euro), la cui corresponsione è accordata nel caso in cui la commissione medica attesti almeno il 66% di invalidità; il pagamento, in questo caso, non svanisce al cospetto di altri redditi, ma subisce soltanto una riduzione che può ammontare al 25% se si superano i 26 mila euro, al 50% se il reddito è maggiore di 32.600 euro. Riguardo il requisito contributivo richiesto, sono sufficienti cinque anni di contributi, di cui almeno tre proprio negli ultimi cinque anni. Per tutto il periodo di percezione dell’assegno, l’intestatario si vedrà attribuiti anche i contributi figurativi validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
L’invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. La Costituzione italiana (art. 38) si pone a difesa del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, a tal proposito garantendo il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Dev’essere tutelata la dignità umana e l’attenzione maggiore non può che rivolgersi a coloro i quali, a causa di minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci o abbiano difficoltà di svolgere l’attività lavorativa.
Il problema che si intende affrontare in questo studio riguarda la diversa considerazione di casi clinici identici fondata esclusivamente su una prerogativa contributiva quasi trascurabile, ma in grado di materializzare la discrepanza abissale tra gli strumenti utilizzati per farvi fronte. Com’è evidente, infatti, la situazione di disparità tra le due prestazioni (una assistenziale e l’altra previdenziale) non può che essere il primo aspetto ad attirare l’attenzione. Perché mai uno status invalidante globale del 74% debba dare diritto a 290 euro al mese (precludendo di fatto quasi del tutto la possibilità di lavorare, considerato il limite di reddito troppo basso da rispettare), mentre un’invalidità prettamente “lavorativa” del 66% (a fronte, come possibile, di soli cinque anni di contributi) consente di percepire una cifra nettamente più consistente (almeno 500 euro al mese, senza neppure menzionare l’accredito figurativo per il periodo di riferimento e la possibilità di ricevere anche il sussidio di assistenza), accordando comunque la possibilità di lavorare? Guarda caso, quella che oggi è l’invciv, introdotta per la prima volta con la Legge n. 118 del 30 marzo 1971, originariamente prevedeva, quale requisito, la riduzione in una percentuale pari ai due terzi (cioè superiore al 66%). Solo successivamente, col Decreto Legislativo n. 509 del 1988 (in vigore dal 12 marzo 1992), tale percentuale di invalidità è stata portata all’attuale 74% e ciò a riprova del fatto che in effetti qualcosa non torna. Bisognerebbe quindi riconsiderare se non altro la quota di invalidità richiesta al fine di ripristinare un livello di giustizia accettabile.
La discriminazione portata avanti dall’applicazione della disciplina di questi due istituti nelle rispettive forme dell’assistenza e della previdenza non può più essere tollerata. In relazione alla circostanza in cui l’Inps provveda all’erogazione di entrambe le indennità potrebbe essere di aiuto fornire un esempio a paragone: è come se un soggetto già titolare di pensione chiedesse e si vedesse riconosciuto il diritto a percepire, in aggiunta, anche l’assegno sociale. La perplessità più grande resta però la diversa percentuale minima pretesa dalla legge per giudicare in merito alla tutela dell’invalido. Uno scarto rilevante che, semmai dovesse essere proprio utilizzato, dovrebbe essere applicato al contrario, ovvero il 66% per l’invciv ed il 74% per l’assegno ordinario.

















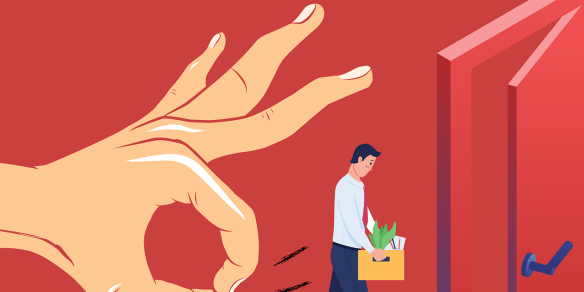


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento