Che cosa dice la Costituzione Italiana vigente a proposito dell’ordinamento giudiziario e della magistratura? È davvero urgente una riforma separatista delle carriere dei magistrati? Sarebbe bene procedere con legge costituzionale o con legge ordinaria?
Indice
1. Il profilo costituzionale della questione (artt. 101 e 104 Cost.)
Le norme costituzionali fondamentali sono contenute nella Parte II, Ordinamento della Repubblica, Titolo IV, La Magistratura, Sezione I, Ordinamento giurisdizionale, e Sezione II, Norme sulla giurisdizione, della Costituzione.
L’articolo 101 Cost. esordisce con una distinzione: dall’intero corpo della magistratura si enuclea un sottoinsieme categoriale, laddove al secondo comma si specifica che: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge“. Dunque un rapporto di genere a specie tra magistrati e giudici: solo questi ultimi, e non tutti i magistrati, sono quindi subordinati unicamente alla legge. Alle altre categorie di magistrati non si estende tale connotato costituzionale.
L’articolo 104 Cost. definisce la magistratura “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e risulta istituito un Consiglio Superiore della Magistratura (c.d. CSM).
Da ciò si desume che:
- l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario formano un’endiadi giuridica;
- le decisioni assunte dalla magistratura nell’esercizio delle proprie funzioni non possono essere assunte, annullate o modificate né dal potere legislativo né dal potere esecutivo (indipendenza funzionale);
- tra la magistratura e gli altri organi dello Stato non può stabilirsi un rapporto di interdipendenza organica, ad esempio: gerarchia, coordinamento, direzione, e così via.
- l’autonomia e l’indipendenza si esercitano mediante l’istituzione di un Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura (art.105 Cost.)
All’articolo 105 Cost. viene inserito un elenco a numero chiuso di competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Le prerogative rispondono al principio di tassatività e di nominatività. Esse riguardano: le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
È importante segnalare alcuni punti qualificanti dell’articolo in esame:
- tali competenze del CSM sono regolate, come specificato dalla disposizione, dalle norme sull’ordinamento giudiziario, dunque non sono svolte in modo arbitrario dai componenti consiliari;
- la norma costituzionale forma un combinato disposto con l’art. 102 Cost., il quale afferma che “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”;
- autonomia e indipendenza dell’ordine della magistratura sono declinate in forma puntuale tramite l’attribuzione di specifiche tutele corporative ad uno speciale organo collegiale proprio della magistratura;
- il Presidente della Repubblica, posto a capo del collegio (art. 104 Cost.), è chiamato a regolare la necessaria attività relazionale dell’assemblea con gli altri organi dello Stato. Si cerca così di trovare un punto di equilibrio, un bilanciamento, tra necessità di autonomia e indipendenza della magistratura e intenzione di non trasformare l’ordine della magistratura in una corporazione chiusa;
- la volontà costituzionale di apertura del Consiglio Superiore della Magistratura verso elementi esterni all’ordine, è rimarcata anche dall’elezione dei c.d. membri non togati del CSM (art. 104 Cost.).
L’autonomia e l’indipendenza del singolo magistrato vengono poi assicurate anche tramite la nomina per concorso, perciò escludendo in linea generale il metodo elettivo di accessoalla carica pubblica.
3. Altre garanzie costituzionali
L’articolo 107 Cost. merita un approfondimento particolare e va esaminato con attenzione.
In esso è scritto che “i magistrati sono inamovibili” e che “non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso“.
Tale disposizione funge da ulteriore guarentigia del magistrato e costituisce una difesa forte del suo operato; essa definisce un potente combinato disposto con l’art. 105 Cost. descritto sopra.
L’art. 107 Cost. è peculiare anche per un’altra ragione. Per la prima volta viene menzionata all’interno del testo costituzionale la figura del pubblico ministero. Dopo aver sancito che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni“, la norma introduce questa nuova specie di ‘magistrato non-giudice’, asserendo che “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario“.
Da cui si desume brevemente che:
1. i magistrati si dividono in due categorie principali: i giudici e i pubblici ministeri;
2. esiste una differenziazione funzionale specifica tra queste due classi;
3. stante tale alterità, viene prevista una normativa ordinaria ad hoc per le garanzie proprie del pubblico ministero, differente da quella stabilita per il magistrato giudicante.
L’articolo 107 Cost. prosegue nominando un membro dell’esecutivo, il Ministro della giustizia, il quale ha la facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei confronti di un magistrato.
Giova evidenziare la salienza di tale riferimento, poiché il rappresentante del Ministero di Giustizia è il solo esponente del Governo, congiuntamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, ad essere menzionato dalla Costituzione Italiana. Egli è altresì responsabile de “l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia“, ad eccezione delle specifiche competenze riservate al Consiglio Superiore della Magistratura.
L’art. 108 Cost. ribadisce che “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge“, ribadendo dunque indirettamente il significato circoscritto del sostantivo ‘autonomia’ riferitoalla magistratura e allargando il novero di coloro ai quali deve essere garantita l’indipendenza pur se “estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia“. A titolo di esempio, si pensi al giudice popolare della Corte d’Assise. Non si fa invece alcun cenno alla autonomia, essendo questa una caratteristica organica intrinseca all’ordine giudiziario in rapporto agli altri enti potestativi statali, non una proprietà dell’individuo membro pro tempore dell’ordinamento medesimo. Invero, il magistrato deve interpretare o applicare la legge dello Stato, non la propria. È eteronomo nella funzione, ancorché autonomo nell’agire, per definizione.
L’art. 111 Cost. a conferma di quanto appena asserito dichiara difatti che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge“.
L’art. 112 Cost. sanziona l’obbligo di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. Esso è un corollario del principio di uguaglianza formale (art. 3 Cost.), valevole come ulteriore presidio di garanzia di indipendenza e imparzialità dell’attività accusatoria verso il potere legislativo e il potere esecutivo (artt. 97-98 Cost.).
3. Conclusioni
Enrico Berti scrive nel suo “Profilo di Aristotele” che il filosofo di Stagira “certamente è assertore del principio secondo cui «la funzione spiega l’organo»“.
La Costituzione Italiana vigente esprime con chiarezza lessicale la diversità, interna alla magistratura, tra giudice e pubblico ministero.
A tale trasparenza nominalistica non corrisponde tuttavia un’adeguata chiarezza semantica e concettuale, poiché non si comprende né chi sono né che funzioni svolgano, i magistrati. Dalla nebulosità iniziale si stagliano conseguentemente le ipostasi umbratili del giudice e del pubblico ministero, oscure e sfocate.
Sarebbe utile in questo senso, tra i molteplici vaneggiamenti riformatori in corso da sempre, elaborare un sillabo generale, agile e sintetico, delle definizioni adoperate nel testo costituzionale. Un preambolo completo delle nozioni, dei lemmi, dei vocaboli impiegati nella Legge fondamentale dello Stato italiano.
Tuttavia, stante che omnium rerum necesse est ordinem esse diversum, è perlomeno opportuno cercar di mettere ordine tra i variegati istituti costituzionali presenti, allo scopo di chiarirne il più possibile il contenuto precettivo.
Orbene, dal momento che lex tam dixit quam voluit, ciò che la legge vuole lo dice, allora si arguisce che l’attuale Costituzione Italiana valuta in forma e con modalità differenti il ruolo del giudice da quello del pubblico ministero, pur essendo ambedue appartenenti alla magistratura.
Basti riflettere sul fatto che mentre il pubblico ministero è portatore di un potere attivo, il giudice detiene un potere reattivo: il primo può azionarsi sua sponte, il secondo si anima solo se sollecitato.
Ritornando all’intuizione aristotelica, nasce allora spontanea una domanda: a chi giova trattare in modo uguale ambiti, funzioni e strutture differenti?
Nei giorni della commemorazione di Giovanni Falcone appare utile riportare quanto disse il magistrato a Mario Pirani, nel corso di una delle sue ultime interviste: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’ obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di paragiudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’ azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’ Esecutivo. E’ veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del Pm con questioni istituzionali totalmente distinte.”
Ricordiamo a tal proposito che “la giustizia è amministrata in nome del popolo” (art. 101 Cost.), e non di convenienze castali, di consorterie, o di interessi particolari di matrice sindacale. Ciò si evince ad esempio all’art. 106 Cost., laddove al secondo e terzo comma si afferma che: “La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (la norma, ancora una volta, non coinvolge i pubblici ministeri, n.d.r).
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori“.
Si rammenti altresì che la configurazione costituzionale dell’amministrazione della giustizia quale elemento di chiusura del circuito democratico non implica impermeabilità o intangibilità, come sancito in più luoghi della Costituzione. Inoltre l’amministrazione della giustizia non coincide con il sentimento della giustizia popolare, il quale pertiene alla sfera etica, ed è cangiante nel tempo e mutevole nello spazio al pari di qualsiasi norma sociale.
Sul profilo tendenzialmente aperto del CSM medesimo si rinvia poi a quanto già scritto in precedenza.
Un avvertimento conclusivo.
La dottrina della separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) postula che il potere di creare le leggi, il potere di applicarle e il potere di giudicare i conflitti di esecuzione, siano distribuiti tra organi diversi.
In via preliminare sarebbe dunque necessario valutare se le funzioni tipiche del pubblico ministero rientrino maggiormente nel potere giudiziario o in quello esecutivo. Si rifletta sul dato di realtà, peraltro ben presentato da Giovanni Falcone, che svolgere diligentemente un’indagine, costruire un impianto accusatorio efficace e gestire la fase esecutiva di una pena sono operazioni assai distanti dall’essere in grado di giudicare rettamente un caso giudiziario. La capacità di giudizio partecipa di certo del potere giudiziario; è molto dubbio, di converso, che sia possibile ricondurre la perizia investigativa nei confini propri della tecnica giurisdizionale.
Inoltre, come ricorda Montesquieu, l’autore del principio della separazione dei poteri, è essenziale che “il potere freni il potere“. Il corollario immediato di tale assunto è che nessun potere può essere assoluto e illimitato, perciò non può esistere un ordine giudiziario svincolato dai controlli e dai contrappesi posti dagli altri due poteri. Si inferisce quindi come siano fuorvianti e maliziose espressioni quali “autogoverno della magistratura”. Se vi fosse realmente un potere autogestito, esso si porrebbe in palese contrasto con quanto appena delineato. Dunque, enunciazioni giornalistiche dannose e ingannevoli, poiché estranee alla lettera e allo spirito della Costituzione Italiana.
Anziché ammirare con occhi devoti i combattimenti fra galli che vengono diffusi attraverso i media, sarebbe perciò preferibile impiegare il proprio tempo di vita per studiare, apprendere e, possibilmente, realizzare, le norme costituzionali.
A maggior ragione in un periodo storico in cui la fiducia nelle istituzioni in generale, e nella magistratura in particolare, ha raggiunto livelli di allarme.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia.
Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!


















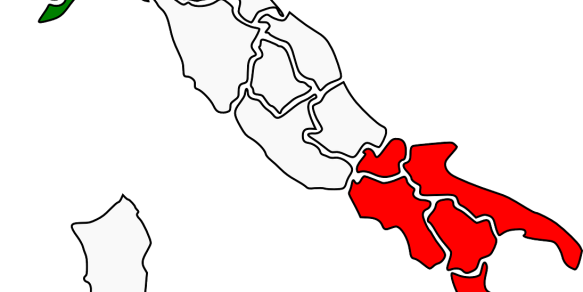


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento