Il codice penale italiano, all’articolo 15, adotta il criterio di specialità quale metro risolutivo di un concorso apparente di norme. Il principio trova applicazione anche con riferimento alle componenti accessorie, posto che le disposizioni di cui agli artt. 68 e 84 informano le correlazioni tra gli elementi eventuali del reato nei medesimi termini previsti dall’art.15 c.p. Speculare è la previsione dell’art.9, l. n.689 del 1981, che adotta lo stesso criterio per disciplinare il concorso tra norma penale e violazione amministrativa.
Rapporto di specialità
L’operatività del rapporto di specialità presuppone che trovi applicazione soltanto la norma che contenga tutti gli elementi costitutivi di un’altra disposizione generale, con l’aggiunta di un contenuto ulteriore, specializzante, sul presupposto indefettibile che ambo le prescrizioni regolino la stessa materia. La mancanza di una definizione normativa del concetto di “stessa materia” ha condotto la dottrina a fornire interpretazioni non univoche, orientate a valorizzare la concreta situazione di fatto o l’identità del bene giuridico tutelato. In giurisprudenza è largamente dominante il ricorso ad un criterio di tipo logico-formale, incentrato su un confronto strutturale tra le fattispecie.
Il rapporto di specialità può descriversi come un rapporto di continenza strutturale fra due norme, nel quale tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie generale sono contenuti in un’altra fattispecie, la quale presenta a sua volta uno o più elementi specializzanti, per aggiunta o specificazione. La norma generale avrà una portata più ampia rispetto alla norma speciale, ma il rapporto tra le due sarà tale per cui, ove la seconda venisse a mancare, il fatto sarà riconducibile nella prima (c.d. specialità unilaterale). Il criterio di specialità si estende anche ai casi di specialità bilaterale o reciproca, nei quali ciascuna norma è al contempo generale e speciale, poiché entrambe presentano accanto ad un nucleo di elementi comuni ulteriori elementi specifici e generici rispetto ai corrispondenti dell’altra.
Ulteriore questione, controversa in giurisprudenza, concerne la possibilità che al criterio di specialità siano affiancati altri criteri, desumibili dall’inciso conclusivo del primo comma dell’art. 15 c.p. “salvo che sia altrimenti stabilito”. Da tale indicazione si trae il principio generale secondo cui, ove si escluda il concorso apparente, è possibile derogare alla regola del concorso di reati solo quando la legge contenga espresse clausole di riserva, le quali, inserite nella singola disposizione, impongano testualmente l’applicazione di una sola norma incriminatrice prevalente che si individua seguendo una logica diversa da quella di specialità.
Sul punto occorre richiamare un diverso indirizzo che tende ad ampliare il concorso apparente di norme alle figure dell’assorbimento, della consunzione, dell’ante-fatto o post-fatto non punibile. Tali classificazioni, fondate su criteri del tutto incerti quali l’identità del bene giuridico tutelato o la maggiore o minore intensità dell’offesa, non trovano conferma normativa e risultano di incerta definizione, in quanto prive di sicure basi ricostruttive Nella prospettiva di un apprezzamento di valore del fatto concreto, anche in mancanza di un’espressa clausola di riserva, si è ritenuto configurabile un concorso apparente in ipotesi di sussidiarietà tacita; queste ultime caratterizzate da livelli crescenti di offesa allo stesso bene giuridico, con conseguente applicazione della sola previsione che contempla l’offesa di maggiore gravità.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite, a far corso dalla pronuncia Tiezzi del 2001, è stabilmente fondata sul criterio di specialità quale unico principio legalmente previsto in tema di concorso apparente (art.15 c.p.), escludendo che possano trovare applicazione altri criteri valutativi. Negli ultimi anni si è posta l’esigenza di valutare se il divieto del bis in idem sostanziale meriti un complessivo ripensamento alla luce delle indicazioni fornite dall’art. 4 Prot. 7 CEDU (Grande camera, 4 marzo 2014 Stevens contro Italia, 15 novembre 2016 A e B contro Norvegia) e dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dai principi del giusto processo espressi dall’art.111 Cost. Le indicazioni sovranazionali, infatti, operano un costante riferimento ad una comparazione concreta e complessiva delle fattispecie che parrebbe estendere i rigorosi confini posti dall’art.15 del codice penale.
Tali previsioni, tuttavia, assumono la funzione di limite processuale e non sostanziale, secondo la stessa lettura dell’art.649 c.p. offerta dalla Corte Costituzionale (n.200 del 2016). Nella specie, esse vietano di sottoporre ad accertamento due volte un soggetto per un medesimo fatto storico (idem factum), ponendo in comparazione quanto concretamente oggetto di imputazione in un precedente giudizio (azione, evento ed elemento psicologico) ed il fatto contestato in un diverso giudizio. Acquisita la funzione processuale di tale limite, nulla vieta che la regolamentazione sostanziale del fatto possa essere descritta in più di una disposizione incriminatrice, con conseguente applicazione dei criteri stabiliti dall’art.15 c.p. (fatto giuridico).
Rapporti tra art. 323 e 479 c.p.
La disciplina dell’abuso di ufficio è stata oggetto, negli anni, di una duplice riforma: dapprima, con legge 86 del 1990 e, successivamente, con legge n. 234/97. Le modifiche apportate con il primo intervento hanno riguardato, essenzialmente, l’introduzione del requisito dell’ingiustizia del vantaggio o del danno per il quale il pubblico ufficiale agisce, distinguendo tra la più grave previsione dell’abuso compiuto per conseguire un vantaggio di natura patrimoniale rispetto alla meno grave ipotesi di abuso mosso dall’esclusiva volontà di arrecare danno. Più profondo e radicale risulta l’intervento operato nel 1997, che ha tracciato il testo tuttora vigente.
Il Legislatore, mediante tale riforma, ha inteso sanare un’evidente frizione con il principio di tassatività. La formulazione previgente dell’art.323 c.p., infatti, era incentrata genericamente sull’ “abuso dell’ufficio”, senza alcuna indicazione in ordine al parametro mediante il quale stabilire detto abuso, rimettendo di fatto al giudice l’individuazione di ciò che concretamente poteva considerarsi penalmente rilevante. Ne derivava un vero e proprio sindacato penale sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con evidenti riflessi sul piano della separazione dei poteri.
Lo scopo della riforma del ’97 era quindi quello di rimediare ai problemi sorti dalla imperfetta formulazione della norma con l’obiettivo di garantire maggiore tassatività alla incriminazione. Si è così assistito ad uno stravolgimento della fattispecie: da reato di pericolo a dolo specifico e a consumazione anticipata, a reato di evento, a dolo intenzionale, che si perfeziona con la realizzazione del vantaggio o del danno. Questi ultimi elementi devono cadere nel fuoco della volizione dell’agente, con esclusione del dolo diretto o eventuale. E’ stata inoltre rimossa la distinzione, in termini di trattamento sanzionatorio, tra abuso “affaristico” (volto ad attribuire un vantaggio patrimoniale) ed abuso semplicemente prevaricatore; è stato infine introdotto un parametro alla stregua del quale valutare l’abusività della condotta (la violazione di legge o regolamento), riallineando quindi il delitto in esame al principio di tassatività, con specifico riferimento al profilo della precisione normativa. Da ultimo, il Legislatore, nell’ambito di una più ampia riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione operata mediante legge n. 190/2012, ha aggravato il trattamento sanzionatorio dell’abuso d’ufficio.
Volume consigliato




















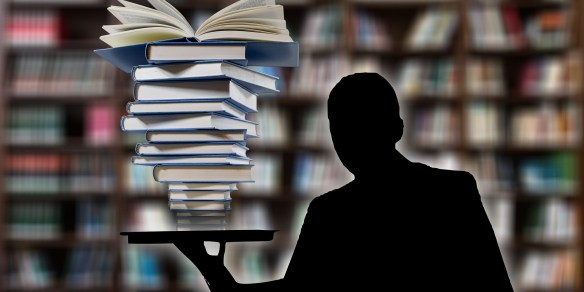
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento