E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.
Le argomentazioni prospettate nell’ordinanza di rimessione
Con ordinanza del 17 marzo 2017 (reg. ord. n. 113 del 2017), la Corte d’appello di Trieste sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Le questioni erano state sollevate nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto una fattispecie di detenzione di circa cento grammi di cocaina, occultati all’interno di tre condensatori per computer, contenuti all’interno di un pacco proveniente dall’Argentina.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto che la sostanza stupefacente fosse destinata in via prevalente alla cessione a terzi, così escludendo, tenuto conto della quantità di tale sostanza sequestrata e di altri elementi di contesto, la possibilità di inquadrare il fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
In esito a giudizio abbreviato, l’imputato è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e 14.000 euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della diminuente per il rito.
L’ordinanza precisava che il difensore dell’imputato, pur non contestando la responsabilità penale per il fatto ascritto, ne aveva chiesto la riqualificazione, ai sensi del citato art. 73, comma 5 e, in via subordinata, permanendo la qualificazione giuridica del fatto di cui all’imputazione, poneva in dubbio la legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa privata, a sua volta, si doleva del fatto come tale disposizione preveda oggi, all’esito di una tortuosa evoluzione normativa, un trattamento sanzionatorio con limite edittale minimo di otto anni di reclusione pari al doppio del massimo previsto per il reato minore posto che, a seguito della sentenza n. 32 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, aveva ripreso applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate con le disposizioni dichiarate incostituzionali così dando luogo a una grave incoerenza sistematica con i commi 5 e 5-bis.
L’ordinanza, quindi, alla luce di ciò, riferiva che il difensore dell’imputato, proprio sul presupposto che detto trattamento edittale è «rivissuto per effetto dell’intervento della Corte costituzionale in un contesto normativo affatto diverso», aveva eccepito, sulla scorta di analoghi argomenti già posti a sostegno della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Rovereto il 3 marzo 2016 (reg. ord. n. 100 del 2016), l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.
Su tali basi, la Corte d’appello triestina, a sua volta, aveva ritenuto come sussistessero i presupposti per sollevare le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui detta disposizione prevede – a seguito della sentenza n. 32 del 2014 – la pena minima edittale di otto anni di reclusione.
In punto di rilevanza, la Corte rimettente affermava di condividere la qualificazione giuridica del fatto-reato data dal giudice di primo grado corrispondente al delitto di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 ostando alla sua sussumibilità nell’ambito della cosiddetta «lieve entità» una serie di elementi, quali: la quantità di sostanza stupefacente (quasi cento grammi netti di cocaina), rivelatasi, all’analisi tossicologica, dotata di elevata percentuale di purezza (57%) e idonea al confezionamento di ben 375 dosi; le circostanze del traffico, involgente fornitori d’oltre oceano, con modalità di trasferimento pianificate per impedire il rinvenimento dello stupefacente; la condotta dell’imputato, che, dopo essersi procurato, appena un mese prima, oltre cento grammi di cocaina (benché di peggiore qualità), accettava di ricevere una nuova consistente fornitura; il rinvenimento nella sua abitazione di 3.700 euro in contanti, verosimilmente non riconducibili a guadagni e risparmi.
In punto di non manifesta infondatezza, la Corte rimettente rilevava il contrasto della norma censurata in relazione a distinti parametri costituzionali.
In primo luogo, l’ordinanza denunciava una violazione del principio della riserva di legge in materia penale, di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e, a tal fine, richiamandosi all’ordinanza della Corte di cassazione, sezione sesta penale, del 12 gennaio 2017, con cui la Suprema Corte aveva a sua volta sollevato un’analoga questione di legittimità costituzionale (decisa da questa Corte con ordinanza n. 184 del 2017 nel senso della manifesta inammissibilità), la Corte d’appello rimettente rilevava che, proprio in virtù del citato principio della riserva di legge, gli interventi in materia penale, volti ad ampliare le fattispecie di reato o a inasprire le sanzioni, appartengono al monopolio esclusivo del legislatore di modo che in tali casi non vi sarebbe spazio di azione per sentenze manipolative in malam partem della Corte costituzionale e da ciò se ne faceva derivare la questione di legittimità costituzionale sul vigente art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, volta a ripristinare il più mite trattamento sanzionatorio, già introdotto nel 2006, da sei a venti anni di reclusione.
In secondo luogo, la Corte rimettente evidenziava il difetto di ragionevolezza della dosimetria della pena prevista dal vigente art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 che sarebbe emeesa nel raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto per il fatto di lieve entità (da sei mesi a quattro anni di reclusione) dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e con quello previsto per le cosiddette «droghe leggere» (da due a sei anni di reclusione) dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il giudice rimettente evidenziava a tal riguardo che, nonostante la linea di demarcazione «naturalistica» tra le fattispecie «ordinaria» e «lieve» sia talvolta non netta, il «confine sanzionatorio» dell’una e dell’altra incriminazione è invece troppo e, quindi, irragionevolmente, distante (intercorrendo ben quattro anni di pena detentiva fra il minimo dell’una e il massimo dell’altra) e, pertanto, il trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso tra le fattispecie che si pongono sul confine tra l’ipotesi lieve e l’ipotesi ordinaria determina un rapporto non ragionevole con il disvalore della condotta.
Su tali basi era opinione del giudice rimettente che il riscontrato iato sanzionatorio, fra le raffrontate fattispecie, «ordinaria» e «lieve», fosse del tutto irragionevole e in quanto tale oggettivamente contrastante con l’art. 3 Cost., anche tenuto conto della sussistenza nell’ordinamento di ulteriori norme, quale può essere la disposizione punitiva del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5) o quella riguardante le droghe “leggere” (art. 73, comma 4) che possono offrire la grandezza predefinita che consente alla Corte costituzionale di rimediare all’irragionevole commisurazione della pena.
Connesso a quanto appena esposto era l’ultimo motivo denunciato dalla Corte rimettente ossia il contrasto del trattamento sanzionatorio attualmente previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 «con il principio di proporzionalità e il principio di colpevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, riconducibile al disposto degli artt. 3 e 27 Cost.».
A tal fine, l’ordinanza richiamava, da un lato, la sentenza della Consulta n. 236 del 2016 secondo cui «l’art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», dall’altro, anche le pronunce sempre della Corte costituzionale n. 251 del 2012 e n. 341 del 1994 onde sostenere che la pena, per definirsi giusta e, così, svolgere la funzione rieducativa verso cui deve tendere in applicazione dell’art. 27 Cost., va adeguata all’effettiva responsabilità penale, in modo da assicurare la piena proporzionalità fra offesa, da una parte, e qualità e quantità della sanzione, dall’altra sicché una pena ingiustificatamente aspra tradirebbe, al contempo, il principio di proporzionalità della pena, sancito dall’art. 3 Cost., e quello della finalità rieducativa della stessa, posto dal richiamato art. 27 Cost.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l’ordinanza di rimessione ribadiva come nell’ordinamento fossero rinvenibili misure della pena che consentono alla Corte di emendare i vizi della disposizione censurata senza sovrapporsi al ruolo del Parlamento e chiedeva di rispristinare il trattamento sanzionatorio già introdotto nel 2006 in modo da ridurre il minimo edittale da otto a sei anni di reclusione.
La richiesta formulata dal Presidente del Consiglio
Con atto depositato il 26 settembre 2017, interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2017, secondo cui alla denunciata incongruenza normativa può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime.
A differenza di quanto opinato dal giudice a quo, l’interveniente riteneva come non potesse ritenersi che l’unica soluzione all’uopo idonea sia quella di rispristinare il trattamento sanzionatorio già introdotto nel 2006, così riducendo il minimo edittale da otto a sei anni di reclusione e, pertanto, ravvisata la necessità di rispettare il primato delle valutazioni del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri concludeva chiedendo l’inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Volume consigliato
La responsabilità amministrativa degli entiIl modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese. Damiano Marinelli, Vincenzo Apa, Giovanni Caruso, Piercarlo Felice | 2019 Maggioli Editore 25.00 € 20.00 € |
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta
La Consulta osservava prima di tutto come la questione sollevata in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. non fosse ammissibile in quanto, per un verso, detta questione, consistendo in una censura degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, di cui, ad avviso del giudice delle leggi, costituiva un improprio tentativo di impugnazione, era inammissibile dato che «[c]ontro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione» (art. 137, terzo comma, Cost.; ex multis, sentenza n. 29 del 1998, ordinanze n. 184 del 2017, n. 261 del 2016, n. 108 del 2001, n. 461 del 1999, n. 220 del 1998, n. 7 del 1991, n. 203, n. 93 e n. 27 del 1990, n. 77 del 1981), per altro verso, non trovava riscontro nella giurisprudenza costituzionale l’assunto da cui muove il giudice rimettente per cui la riserva di legge di cui all’art. 25 Cost. precluderebbe in radice alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire in materia penale con effetti meno favorevoli atteso che la giustizia costituzionale, come ribadito anche recentemente (sentenze n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018), ammette in particolari situazioni interventi con possibili effetti in malam partem in materia penale (sentenze n. 32 e n. 5 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006) restando semmai da verificare l’ampiezza e i limiti dell’ammissibilità di tali interventi nei singoli casi fermo restando che, se certamente il principio della riserva di legge di cui all’art. 25 Cost. rimette al legislatore «la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare» (sentenza n. 5 del 2014), siffatto principio, però, non esclude che, in sede di diritto vivente, possa assumersi decisioni il cui effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla semplice rimozione di disposizioni costituzionalmente illegittime atteso che, in tal caso, l’effetto in malam partem è ammissibile in quanto esso è una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma costituzionalmente illegittima la cui caducazione determina l’automatica riespansione di altra norma dettata dallo stesso legislatore (sentenza n. 236 del 2018).
Si osservava oltre tutto come la Consulta, se con la sentenza n. 32 del 2014, nel dichiararsi l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, per vizi procedimentali relativi all’art. 77, secondo comma, Cost., In esito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del suddetto decreto-legge, si era ripreso l’applicazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con effetti in parte più miti, e in parte più severi, è altrettanto vero che i giudici di legittimità costituzionale, in quello occasione, si erano limitati a rimuovere dall’ordinamento le disposizioni costituzionalmente illegittime sottoposte al suo esame nello svolgimento del compito assegnatole dall’art. 134 Cost. mentre la conseguente configurazione del trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti era stato il frutto di precedenti scelte del legislatore che erano tornate ad avere applicazione dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014 e che erano poi state modificate con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego dei medicinali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto il massimo edittale della pena prevista per i fatti lievi e ha apportato ulteriori molteplici adattamenti alla normativa, conseguenti alla citata sentenza n. 32 del 2014.
Per quanto invece attiene le ulteriori censure, esaminate congiuntamente, vale a dire quelle concernenti l’irragionevolezza e la sproporzione del trattamento sanzionatorio, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la Corte faceva presente che se era vero che si fosse sempre pronunciata nel senso della inammissibilità delle questioni che sono state ripetutamente sollevate in riferimento all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (sentenze n. 179 del 2017, n. 148 e n. 23 del 2016; ordinanza n. 184 del 2017), era altrettanto vero che le ragioni che avevano finora ostacolato l’esame nel merito di casi di questo tipo, non fossero stimate sussistenti nel caso di specie.
E infatti, osservano i giudici di legittimità costituzionale nella decisione qui in esame, nelle sentenze n. 148 e n. 23 del 2016, le questioni erano state dichiarate inammissibili per una pluralità di vizi delle ordinanze di rimessione, tra i quali l’indeterminatezza del petitum e la mancata individuazione di un trattamento sanzionatorio alternativo a quello in vigore, che consentisse alla Consulta di sanare i vizi di costituzionalità lamentati così come, da una parte, nell’ordinanza n. 184 del 2017 erano state ravvisate negli atti introduttivi molteplici ragioni di inammissibilità connesse a vizi di rilevanza, a incompletezza della ricostruzione del quadro normativo, ad aspetti di contraddittorietà della motivazione, al tentativo di impugnare una pronuncia della Corte in violazione dell’art. 137, terzo comma, Cost. e alla conseguente pretesa di far rivivere la disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, per vizi del procedimento legislativo ex art. 77 Cost., dall’altra, nella sentenza n. 179 del 2017, si riteneva di non poter esaminare nel merito le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo esame, perché i giudici rimettenti non avevano individuato “soluzioni costituzionalmente obbligate” idonee a rimediare al vulnus costituzionale denunciato atteso che, in quel caso, a fronte della richiesta avanzata alla Corte costituzionale di colmare il divario sanzionatorio tra le due fattispecie di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 73, parificando il minimo edittale previsto per il fatto non lieve al massimo edittale previsto per il fatto lieve, si escludeva che dovesse «ritenersi imposto, dal punto di vista costituzionale, che a continuità dell’offesa debba necessariamente corrispondere una continuità di risposta sanzionatoria» (sentenza n. 179 del 2017), ben potendo sussistere «spazi di discrezionalità discontinua» nel trattamento sanzionatorio sicché la richiesta di reductio ad legitimitatem del censurato comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, attraverso la parificazione del minimo edittale per il fatto non lieve da esso previsto al massimo edittale (quattro anni di reclusione ed euro 10329,00 di multa) comminato per il fatto lieve di cui al successivo comma 5, non poteva ritenersi costituzionalmente obbligata.
Una volta rilevato ciò, si osservava come anche l’eccezione di inammissibilità sollevata in questo giudizio si basasse su ragioni connesse all’assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, ma si rivelava infondata alla luce degli approdi cui è giunta la più recente giurisprudenza costituzionale relativa all’ampiezza e ai limiti dell’intervento della Corte costituzionale sulla misura delle sanzioni penali stabilite dal legislatore, sviluppatasi segnatamente a partire dalla sentenza n. 236 del 2016; si notava in particolare che, con la recente sentenza n. 233 del 2018, la Consulta, dopo aver ribadito che le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano anzitutto al legislatore, aveva precisato che non sussistono ostacoli al suo intervento quando le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l’individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da «ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze» (in tal senso richiamando la sentenza n. 236 del 2016) così come la sentenza n. 222 del 2018, di poco precedente, aveva già ritenuto che, al fine di consentire l’intervento correttivo della Corte costituzionale, non è necessario che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che il «sistema nel suo complesso offra alla Corte “precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti” (sentenza n. 236 del 2016)», ancorché non “costituzionalmente obbligate”, «che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima».
Pertanto, una volta chiarito che non spetta alla Corte costituzionale determinare autonomamente la misura della pena (sentenza n. 148 del 2016), si ribadiva come l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che riguardano l’entità della punizione risultasse condizionata non tanto dalla presenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all’interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore (sentenza n. 233 del 2018) posto che, nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale, incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore.
Tal che, alla luce di tali principi, si affermava come le questioni prospettate dalla Corte d’appello di Trieste superassero il vaglio di ammissibilità avendo individuato nell’ordinamento quale soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata, l’abbassamento del minimo edittale per il fatto previsto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 da otto a sei anni, misura a suo tempo prevista dall’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 e tuttora in vigore, come pena massima, ai sensi del comma 4 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per la fattispecie ordinaria delle droghe “leggere” di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del citato d.l. n. 36 del 2014, come convertito.
Posto ciò, la Corte costituzionale considerava le questione fondate nel merito alla luce delle seguenti considerazioni.
Si rilevava prima di tutto come la stessa Consulta avesse già avuto modo di evidenziare che la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo «ha raggiunto un’ampiezza tale da determinare un’anomalia sanzionatoria» (sentenza n. 179 del 2017) all’esito di una articolata evoluzione legislativa e giurisprudenziale così descritta in questa stessa pronuncia nei seguenti termini: “L’originario art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 differenziava il trattamento sanzionatorio dei reati aventi ad oggetto le droghe “pesanti” (puniti al comma 1 con la reclusione da otto a venti anni e con la multa) rispetto a quello dei reati aventi ad oggetto le droghe “leggere” (puniti al comma 4 con la reclusione da due a sei anni e con la multa). La stessa distinzione tra droghe “pesanti” e “leggere” era riproposta anche per i fatti di lieve entità, in relazione ai quali il comma 5 del medesimo art. 73 stabiliva un’attenuante ad effetto speciale cosiddetta autonoma o indipendente, che puniva con la reclusione da uno a sei anni i fatti concernenti le droghe “pesanti” e da sei mesi a quattro anni quelli relativi alle droghe “leggere” oltre alle rispettive sanzioni pecuniarie.
Il d.l. n. 272 del 2005, con l’art. 4-bis (poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 32 del 2014), aveva soppresso la distinzione fondata sul tipo di sostanza stupefacente, comminando la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa per i fatti non lievi, nonché la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa per i casi in cui fosse applicabile l’attenuante del fatto di lieve entità. Con l’art. 2, comma 1, lettera a), del successivo decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, è stato sostituito il comma 5 dell’art. 73, trasformando la circostanza attenuante del fatto di lieve entità in fattispecie autonoma di reato e riducendo il limite edittale massimo della pena detentiva da sei a cinque anni di reclusione. Tale modifica non è stata intaccata dalla sentenza n. 32 del 2014, a seguito della quale hanno ripreso vigore le disposizioni dell’art. 73 nella originaria formulazione. Infine, il legislatore è tornato nuovamente sulla materia, con il d.l. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 2014, che tra l’altro, all’art. 1, comma 24-ter, lettera a), ha ulteriormente diminuito il massimo edittale della pena prevista per il fatto di lieve entità, fissandolo nella misura di anni quattro di reclusione oltre la multa”.
Una volta terminato questo excursus normativo, il giudice delle leggi osservava come, proprio a seguito di questa stratificazione di interventi legislativi e giurisprudenziali, si era progressivamente scavata la lamentata profonda frattura che separa il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità da quello del fatto lieve, senza che il legislatore avesse provveduto a colmarla nonostante i gravi inconvenienti applicativi che essa può determinare sebbene, come fatto presente in questa stessa pronuncia, era stato pressante invito rivolto al legislatore affinché procedesse «rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990», anche in considerazione «dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti» (sentenza n. 179 del 2017).
A fronte di ciò, si faceva al contempo presente che, anche se il costante orientamento della Corte di cassazione sia nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (ex multis, da ultimo, Corte di cassazione, sezione settima penale, ordinanza 24 gennaio-12 febbraio 2019, n. 6621; Corte di cassazione, sezione settima penale, ordinanza 20 dicembre 2018-24 gennaio 2019, n. 3350; Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 13 dicembre 2018-18 gennaio 2019, n. 2312), indubitabilmente molti casi si collocassero in una “zona grigia”, al confine fra le due fattispecie di reato, il che, ad avviso della Corte, rendeva non giustificabile l’ulteriore permanenza di un così vasto iato sanzionatorio, evidentemente sproporzionato sol che si consideri che il minimo edittale del fatto di non lieve entità è pari al doppio del massimo edittale del fatto lieve.
Da ciò se ne faceva discendere come l’ampiezza del divario sanzionatorio condizioni inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto (ritenuta doverosa da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 settembre – 9 novembre 2018, n. 51063) con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte.
Dunque, alla luce del pericolo che si potessero verificare “sperequazioni punitive” di questo genere, la Consulta riteneva come fossero violati i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., oltre che il principio di rieducazione della pena di cui all’art. 27 Cost. dato che, come chiaramente affermato dalla medesima Corte costituzionale ancora di recente nella sentenza n. 222 del 2018, allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994), e ciò proprio perchè i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. «esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017) in vista del «progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l’essenza della finalità rieducativa» della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del 2018).
Da ciò se ne faceva inferire come, al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali, fosse di ostacolo l’espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere.
Una volta terminata questa complessa e articolata disamina giuridica, i giudici di legittimità costituzionale ritenevano all’uopo necessario intervenire nel caso di specie, nel senso di accogliere le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nei termini in cui erano state prospettate dal giudice rimettente, il quale chiedeva che fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni, anziché di sei anni di reclusione.
Si evidenziava a tal proposito come la misura della pena individuata dal rimettente, benché non costituzionalmente obbligata, non fosse tuttavia arbitraria ben potendosi essa ricavare da previsioni già rinvenibili nell’ordinamento, specificamente nel settore della disciplina sanzionatoria dei reati in materia di stupefacenti, e dunque collocandosi in tale ambito in modo coerente alla logica perseguita dal legislatore, e ciò in ragione del fatto che, da un lato, il giudice rimettente traeva l’indicazione della misura della pena minima per i fatti non lievi anzitutto dalla previsione introdotta con l’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 per i medesimi fatti, che ancora conserva viva traccia applicativa nell’ordinamento in considerazione degli effetti non retroattivi della sentenza n. 32 del 2014, dall’altro, sei anni è la pena massima – a cui pure fa riferimento l’ordinanza di rimessione – prevista dal vigente comma 4 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti di non lieve entità aventi ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal richiamato art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’altro lato ancora, sempre in sei anni il legislatore aveva altresì individuato la pena massima per i fatti di lieve entità concernenti le droghe “pesanti”, vigente il testo originario del d.P.R. n. 309 del 1990, misura mantenuta come limite massimo della pena per i fatti lievi anche dal successivo d.l. n. 272 del 2005 che pure aveva eliminato dal comma 5 la distinzione tra droghe “pesanti” e droghe “leggere”.
Ad avviso della Consulta, in altre parole, la pena di sei anni è stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti “di confine” che, nell’articolato e complesso sistema punitivo dei reati connessi al traffico di stupefacenti, si pongono al margine inferiore delle categorie di reati più gravi o a quello superiore della categoria dei reati meno gravi e pertanto, ad avviso della Corte, in tale contesto, è appropriata la richiesta di ridurre a sei anni di reclusione la pena minima per i fatti di non lieve entità di cui al comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 al fine di porre rimedio ai vizi di illegittimità costituzionale denunciati avendo il giudice rimettente individuato – secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale più recente – una previsione sanzionatoria già rinvenibile nell’ordinamento che, trasposta all’interno della norma censurata, si situa coerentemente lungo la dorsale sanzionatoria prevista dai vari commi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e rispetta la logica della disciplina voluta dal legislatore (sentenza n. 233 del 2018).
La Corte costituzionale, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.
Conclusioni
La sentenza è condivisibile in quanto il frutto di un complesso e articolato ragionamento giuridico.
In particolare, nell’affermarsi l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che riguardano l’entità della punizione risultasse condizionata non tanto dalla presenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all’interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, difatti, si consente alla Consulta di verificare se la determinazione legislativa di un quantum sanzionatorio in ordine ad uno specifico illecito penale sia conforme o meno ai valori costituzionali anche in’assenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata.
Premesso ciò, la Corte costituzionale ha adeguatamente argomentato (mediante una corretta interpretazione (anche di natura storica) delle norme oggetto del suo intervento nonché un’adeguata disamina della giurisprudenza costituzionale maggiormente rilevante ai fini della soluzione della questione ad ella proposta) sia sul perché il minimo edittale per il reato di cui all’art. 73, c. 1, d.P.R. n. 309/1990 fosse eccessivo, sia perché una sua riduzione a 6 anni (anziché 8) consentisse il rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., oltre che il principio di rieducazione della pena di cui all’art. 27 Cost..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, dunque, si ribadisce, non può che essere positivo.



















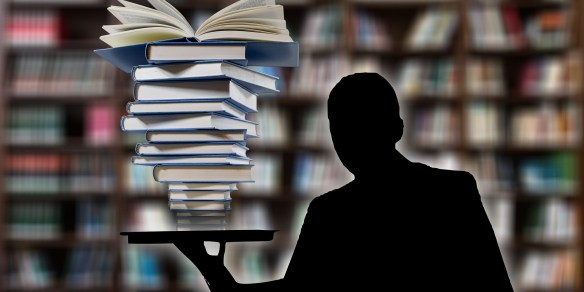


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento