***
La legge 125 del 1991 segna una tappa fondamentale nel cammino intrapreso dalle donne verso la parità di trattamento e l’uguaglianza dei diritti. Il legislatore si discosta nettamente dall’esperienza passata, da quelle leggi degli anni ’70 costruite su un concetto classico di eguaglianza formale, orientate a contenere la rilevanza dell’identità sessuale nella disciplina del lavoro femminile più che a valorizzarla.
In un ordine di vedute completamente opposto, la legge 125 diviene invece fautrice dell’uguaglianza sostanziale e dei valori su cui si fondano gli articoli 3 e 37 della Costituzione, promuovendo la realizzazione di un modello bidirezionale, allo stesso tempo paritario e protettivo. Da qui l’adozione di trattamenti differenziati per sesso, proprio con lo scopo di rimuovere anacronistiche disparità tra lavoratori e lavoratrici; una forma di intervento diretta a ripristinare l’uguaglianza nelle condizioni di partenza, concretizzando la parità di chance nell’accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa. Due sono gli elementi sui piatti della bilancia: la promozione dell’uguaglianza da un lato e la tutela della differenza dall’altro; diversi sono i mezzi ed i soggetti cui è affidata la ricerca ed il mantenimento dell’equilibrio tra i due valori.
Attivi sul fronte delle pari opportunità sono: istituzioni pubbliche, datori di lavoro pubblici e privati, sindacati, associazioni femminili, lavoratori e lavoratrici stesse. Per assicurare il rispetto delle previsioni normative si è peraltro provveduto alla istituzione di un “Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”, al quale si affianca l’opera dei Consiglieri di parità presenti a livello centrale, regionale e provinciale. Una discussione a parte, tra i soggetti impegnati nella rimozione delle discriminazioni sessuali, merita di essere fatta in relazione al ruolo assunto dalle Pubbliche Amministrazioni. Solo queste infatti non rientrano nel novero dei “promotori volontari” dei piani di azioni positive, costituendo una categoria a sé, per la quale il legislatore ha previsto l’obbligo (e quindi non più la semplice possibilità) di adottare detti programmi. La previsione di un “modello obbligatorio” costituisce una peculiarità dell’ordinamento italiano che si discosta in tal modo dalle tendenze comunitarie, favorevoli ad interventi di natura esclusivamente volontario-consensuale. Si comprende allora perché questa scelta abbia suscitato forti perplessità, alimentate ulteriormente da uno scetticismo di fondo relativo alle potenzialità applicative del modello; la legge, infatti, a fronte della disciplina enunciata, non appresta un meccanismo sanzionatorio specifico per il caso di mancata attuazione delle disposizioni.
L’espressione “azioni positive” non nasce nel nostro ordinamento, ma è mutuata dall’esperienza statunitense, ricollegandosi alle “affirmative actions”: interventi di politica governativa finalizzati alla concessione di benefici a coloro che, a causa dell’appartenenza ad un gruppo specifico, fossero vittime di discriminazioni. Negli anni ’70, sull’esempio americano, il concetto di “azione positiva” ha fatto il suo ingresso anche nell’esperienza giuridica europea, attraverso la predisposizione di speciali programmi d’azione per la promozione delle pari opportunità. Per quello che più direttamente ci riguarda, il sistema giuridico italiano non fornisce una nozione legale di “azioni positive” avendo preferito la strada di una definizione funzionale attraverso il riferimento agli scopi da perseguire (articolo 1).
In generale, tali azioni possono essere identificate come misure concrete, dirette ad assicurare alle donne pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico, combattendo le forme di discriminazioni dirette e indirette di cui sono sempre state vittime e consentendo la predisposizione di un ambiente e di condizioni di lavoro ad esse favorevoli. Più in dettaglio le due finalità essenziali che giustificano la promozione delle azioni positive sono individuate nell’articolo di apertura del testo legislativo, redatto in maniera così dettagliata e ben articolata da costituire da solo il fulcro e il parametro interpretativo di tutte le altre disposizioni in esame. Al 1° comma esso fa riferimento alla necessità, da un lato, di “favorire l’occupazione femminile”, dall’altro di garantire “l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”. Tutti gli altri scopi, elencati nella seconda parte dell’articolo stesso, non sono poi altro che un’ulteriore precisazione di questi due obiettivi fondamentali.
Con la legge 125 viene ad affinarsi ulteriormente il concetto di “discriminazione” essendo identificato non più solo come “qualsiasi atto”, ma anche come “qualsiasi comportamento” che produca un effetto pregiudizievole, discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso (articolo 4, comma 1). Più opportuno è sembrato oggi ripiegare su una nozione “oggettiva” di discriminazione, per la quale l’elemento caratterizzante è costituito dal nesso funzionale (e non più psicologico) tra la condotta del datore di lavoro e l’effetto prodotto.
La maggiore cura prestata alla definizione del concetto in esame si rinviene anche nella precisazione del significato di discriminazione indiretta, relativo ad “ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno e dell’altro sesso e riguardino i requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa” (articolo 4, comma 2). Si tratta di un trattamento discriminatorio più sottile, che ricorre in tutti i casi in cui l’autore della condotta pregiudizievole, pur non violando apparentemente il principio di parità di trattamento, adotta tuttavia dei criteri di scelta destinati di fatto ad incidere in modo diverso e non imparziale su lavoratori e lavoratrici. Unica eccezione al divieto si ha nell’ipotesi in cui i criteri pregiudizievoli adottati dal datore di lavoro riguardino “requisiti essenziali” allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il riconoscimento di tale circostanza, il cui onere probatorio è ovviamente a carico del datore di lavoro stesso, esclude l’antigiuridicità del trattamento, anche se da esso derivino svantaggi proporzionalmente maggiori per i lavoratori di uno dei due sessi. In questa sua nuova veste, il divieto di discriminazione, si pone in un’ottica più estesa rispetto all’esperienza passata, che abbraccia la tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona.
L’ampliamento di prospettive che caratterizza la legge in esame si riscontra anche nella vasta gamma di azioni positive proponibili in base alla normativa, giacché di esse non viene data una definizione analitica ma, al contrario, si preferisce lasciare spazio ad una formula aperta, adatta alle più diverse tipologie di intervento.
Le misure individuate nell’articolo 1, di natura risarcitoria o promozionale, non possono quindi per nessuna ragione essere pensate come un numerus clausus, un aspetto sicuramente positivo che fa delle stesse uno strumento di intervento plasmabile in base alle esigenze di volta in volta considerate.
Oggetto di pesanti critiche è invece l’apparato sanzionatorio, giudicato piuttosto debole rispetto agli obiettivi che la legge si propone di realizzare. A fronte del mancato rispetto della normativa paritaria è previsto, in capo al giudice, il potere di promuovere l’adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, fissando un termine per la definizione dello stesso (articolo 4, comma 7). Per gli imprenditori che usufruiscano di benefici pubblici o abbiano stipulato contratti di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche si è inoltre sancito che “ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori” possa comportare la revoca del privilegio goduto o addirittura l’interdizione “da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto” (articolo 4, comma 9). Siamo sicuramente di fronte a misure repressive innovative se confrontate con quelle offerte dalla legge 903; a ben guardare, però, si tratta ancora di interventi di carattere puramente afflittivo, non implicanti alcuna garanzia restitutoria.
D’altra parte bisogna anche riconoscere il forte impatto avuto sulla disciplina del lavoro dalla prevista inversione del principio generale in materia di onere della prova espresso dall’articolo 2697 del Codice Civile. Sulla scia dei cambiamenti già intervenuti in altri Paesi europei ed in considerazione delle oggettive difficoltà, per la lavoratrice ricorrente in giudizio, di fornire la prova dell’atto discriminatorio subito, si è posto a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare che la disparità di trattamento sia dovuta a motivi non ricollegabili ad intenti discriminatori (articolo 4, comma 5). Ciò non significa che la lavoratrice che agisca in giudizio sia completamente esonerata dal dimostrare la fondatezza delle proprie pretese. Suo compito sarà infatti quello di allegare alla domanda di tutela “elementi di fatto”, precisi e concordanti, riguardanti tutta una serie di eventi del rapporto di lavoro, idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti discriminatori.
Altro profilo innovativo sul versante processuale attiene alla presenza, accanto alla classica azione di tipo individuale (già disciplinata dall’articolo 15 della legge n.903) anche di un’azione di tipo collettivo, proponibile su ricorso del Consigliere di parità regionale. Il concetto di “discriminazione collettiva” accolto dalla norma a tale proposito si riferisce all’atto o comportamento discriminatorio adottato dal datore di lavoro e lesivo dell’interesse di più lavoratori, anche qualora questi non fossero “individuabili in modo immediato e diretto” (articolo 4, comma 6°).
Uno sguardo d’insieme alla legge 125/1991 ci da la misura di quanti importanti cambiamenti essa abbia portato in tema di pari opportunità. Ovviamente, una valutazione corretta dell’intervento legislativo, non può prescindere dalla considerazione delle condizioni economiche, culturali e di costume in cui versa il Paese. Per quanto la legge possa avere introdotto strumenti validi ed efficaci, tali da segnare una svolta rispetto alle normative preesistenti, bisogna pur sempre fare i conti con un sistema economico piuttosto fragile e regolato da un’idea di flessibilità (a garanzia di una produttività e concorrenzialità a livello nazionale) che a volte mal si relaziona con le azioni positive (essendo esse, in un certo senso, un elemento di “rigidità” nel mercato del lavoro). Agli aspetti positivi si accompagnano tutta una serie di limiti che richiedono ulteriori cambiamenti, peraltro già in parte apportati dal D.lgs. 196/2000 (con il quale si è provveduto alla ridefinizione di compiti, collocazione organica e criteri di nomina del consigliere di parità, con un notevole potenziamento delle sue funzioni).
Essere donna ha significato per secoli essere inferiori, essere “diverse” nell’accezione negativa del termine. Solo in tempi relativamente recenti esse hanno tentato di costruire nuove identità negando ruoli prestabiliti e stereotipi consolidati delle società maschiliste. Se correttamente impiegati, i mezzi forniti dalla legge 125, costituiscono valida garanzia, oltre che della repressione di pratiche discriminatorie, anche della promozione dei comportamenti sociali coerenti con l’obiettivo delle pari opportunità. Alla luce di quanto detto, obiettivo fondamentale non è quello della completa omologazione del lavoro femminile a quello maschile, bensì, all’opposto quello più complesso della “valorizzazione delle differenze” e della promozione delle potenzialità delle donne, senza d’altro canto, costituire privilegi che risultino discriminatori per gli uomini.
Dorotea Politano

















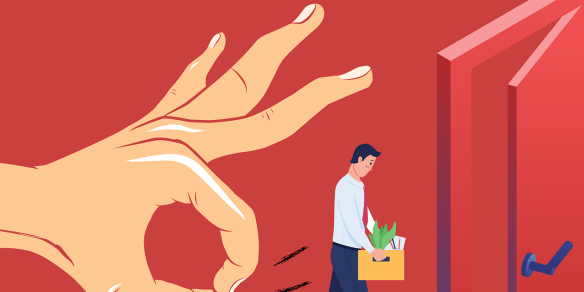


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento