Riferimenti normativi: art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e art. 45 c.p.
Precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. III, 11 ottobre 2019, n. 41943; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 16163; Cass., Sez. III, 06 luglio 2018, n. 52971.
Il Fatto
Con sentenza del 4 ottobre 2018 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del 1° dicembre 2014 del Tribunale di Rieti, riduceva ad anni uno la durata delle pene accessorie, relative all’incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione e all’interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, eliminando la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’estinzione del debito tributario e confermando nel resto la sentenza impugnata, a carico di un imputato, legale rappresentante di una società di capitali, condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, stante l’omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dell’anno 2010.
Avverso il predetto provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione.
Volume consigliato
Le doglianze
Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dedotta carenza dell’elemento soggettivo del reato. Sosteneva di avere infatti adoperato ogni possibile risorsa al fine di non incorrere nell’illecito contestato tramite il pagamento dei dipendenti, la salvaguardia della prosecuzione aziendale, nonché l’adesione alle procedure conciliative per il pagamento del debito all’erario.
In specie, il ricorrente aveva fornito prova della non imputabilità in ragione della crisi di liquidità, nonché dell’impossibilità di fronteggiare la crisi tramite il ricorso a misure anche sfavorevoli.
Il ricorrente affermava infatti che la situazione di crisi aziendale, dovuta peraltro alla mancata riscossione di ingenti crediti, non gli aveva consentito di adempiere nei tempi dovuti agli obblighi contributivi; con ciò prefigurandosi, da un lato, una situazione di forza maggiore idonea ad escludere l’attribuibilità a questi della condotta omissiva e, dall’altro lato, a ravvisare il difetto del prescritto coefficiente psicologico. Secondo la previsione contenuta nell’art. 45 c.p., infatti, “”non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.
Le valutazioni della Suprema Corte
I giudici preliminarmente illustravano il consolidato significato giuridico assegnato al “caso fortuito” e alla “forza maggiore” e rilevavano la prospettazione difensiva, secondo cui la situazione di crisi di impresa avrebbe impedito, in termini di una assoluta impossibilità, di adempiere agli obblighi nei confronti del Fisco, impedimento che il giudice di merito avrebbe dovuto apprezzare.
I giudici, tuttavia, escludevano siffatta situazione di impossibilità.
Veniva quindi anzitutto appurata la circostanza dell’avvenuto pagamento, alla scadenza mensile della relativa obbligazione retributiva, dello stipendio ai dipendenti; segno, evidentemente, che la crisi di liquidità non era affatto assoluta e che, pertanto, l’impresa non si trovava in quella situazione di impossibilità di compiere scelte alternative, ovvero nella condizione di una condotta (omissiva) irresistibilmente coartata verso un determinato risultato o effetto, ossia il mancato pagamento del debito fiscale. Ciò che, pertanto, consentirebbe di rilevare la palese insussistenza, nella specie, di una situazione di “forza maggiore”.
Invero la corresponsione, ogni mese, delle retribuzioni, non consentiva – proseguivano i giudici – di dimostrare la dedotta situazione di impossibilità di adempimento delle ulteriori obbligazioni pubbliche alla scadenza. Sicché la condizione di assoluta illiquidità non risultava dimostrata nella sua reale efficienza causale rispetto alla condotta omissiva.
In particolare, veniva precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad allo stesso non imputabili.
In definitiva, la forza maggiore che esclude la coscienza e volontà della condotta è la vis cui resisti non potest, a causa della quale l’uomo non agit sed agitur.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte – precisava la III sezione –, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell’evento, mai quale causa concorrente di esso; essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando, e non può quindi ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente.
Gli ermellini, dunque, davano atto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso, sì che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l’inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
Dirimente per la Suprema Corte il dato secondo cui, il ricorrente operava altre scelte imprenditoriali, in ogni caso scegliendo i creditori da soddisfare e comunque disegnando la scaletta dei propri impegni economici secondo necessità aziendale e non secondo gli obblighi di legge. In tal modo collocandosi al di fuori del perimetro della forza maggiore ed integrando sicuramente l’elemento soggettivo del reato.
Considerazioni conclusive
In ordine al delitto di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 28 marzo 2013, n. 37424, ha operato una rilevantissima apertura all’esclusione della punibilità penale, ammettendo che può essere invocata dal contribuente la crisi di liquidità allorquando si dimostri che questa non sia dipesa da un’inadeguata organizzazione delle risorse disponibili.
I più saldi principi di diritto a proposito della c.d. crisi di liquidità – che escluderebbe la punibilità, essendo insussistente l’elemento psicologico del reato – sono oggi fissati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 42127, secondo cui «per escludere il dolo, è indispensabile che il contribuente dimostri che gli sia stato impossibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie all’adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo esperito tutte le possibili azioni, comprese quelle svantaggiose per il proprio patrimonio personale, tese a recuperare le somme necessarie a estinguere il debito erariale, senza esservi riuscito per ragioni a lui non imputabili e, comunque, indipendenti dalla sua volontà».
Ebbene, una recentissima pronuncia – che si rifà ad un consolidato orientamento – aveva già affrontato il tema dell’imprenditore che, seguendo un ordine di priorità, aveva dato precedenza al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti rispetto al versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale[1]. La scelta veniva tuttavia ritenuta arbitraria. I giudici di legittimità avevano infatti rappresentato che è onere del datore ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento dei debiti erariali, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime.
La sentenza in commento, in definitiva, si colloca nel medesimo solco interpretativo già segnato dalle precedenti e ribadisce che l’imprenditore posto difronte alla scelta alternativa di pagare gli stipendi o le imposte dovute deve preferire il soddisfacimento del credito vantato dall’Erario: in caso contrario non potrà essere invocata la causa di non punibilità, rappresentando il pagamento degli stipendi il segno che il contribuente non ha esperito tutte le possibili azioni, comprese quelle svantaggiose, dirette a recuperare le somme necessarie a estinguere il debito erariale.
Volume consigliato
|
|
[1] Cfr. Cass., Sez. III, 11 ottobre 2019, n. 41934.




















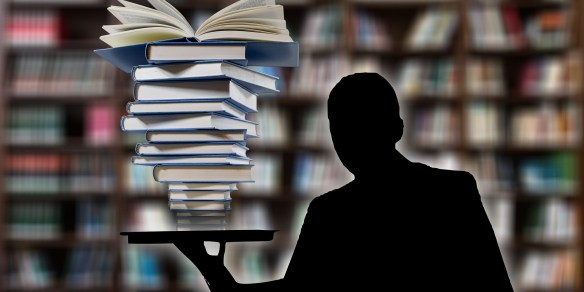
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento