La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.15401 del 20 luglio 2020, si è pronunciata sulla interpretazione della nozione di licenziamento di cui all’art. 24 della Legge 223/1991, includendo nella stessa anche le risoluzioni consensuali sottoscritte in caso di rifiuto di un trasferimento.
Come è noto, l’art. 24 della Legge 223/1991 prescrive l’attivazione della articolata procedura di licenziamento collettivo allorquando le “imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, […] in conseguenza di una riduzione o trasformazione della attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia”.
Sino alla pronuncia in esame, l’orientamento prevalente della giurisprudenza considerava rilevanti, ai fini del computo di cui alla citata norma, solo ipotesi di licenziamento intese in senso tecnico, quali manifestazioni unilaterali della volontà del datore di lavoro, escludendo – conseguentemente – ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto determinata dalla volontà del lavoratore (dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti), anche ove tali cessazioni del rapporto di lavoro fossero riconducibili ad una operazione di riduzione del personale[1].
Oggi, invece, la Cassazione amplia la nozione di licenziamento, introducendo, come detto, tra le ipotesi rilevanti ai fini della disciplina sui licenziamenti collettivi, anche le risoluzioni consensuali, precisando però che le stesse devono essere determinate da una modifica unilaterale da parte del datore di lavoro di un elemento sostanziale del contratto, a svantaggio del lavoratore e per ragioni non inerenti a comportamenti di quest’ultimo e, in questo, ispirandosi ai principi che sul punto si sono formati nel tempo ad opera della legislazione e della giurisprudenza comunitaria.
L’ordinanza in esame ha sollevato non pochi dubbi di interpretazione, che hanno sviluppato un acceso dibattito sin dalla sua pubblicazione.
Volume consigliato
Il licenziamento nel settore privato
Con un approccio per quesiti e problemi, si offre una panoramica della normativa in tema di licenziamenti nei rapporti di lavoro privato, le cui disposizioni si sono stratificate e sovrapposte nel tempo in relazione alla natura e alle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, al settore, alla qualifica, alla data di assunzione, alla data di licenziamento, al tipo di rapporto, creando un sistema difficilmente intellegibile per l’operatore. Verrà illustrato come distinguere il licenziamento dalle ipotesi affini, quale forma deve rivestire e per quali motivi si può legittimamente licenziare, con quale procedura e con quale tempistica; come impugnare un licenziamento, attraverso quali adempimenti da compiere prima del giudizio e come evitare le decadenze di legge, come impostare un ricorso avverso un licenziamento illegittimo e quali sono le caratteristiche del rito da seguire. Saranno passati in rassegna i principali vizi che possono affliggere l’atto espulsivo, indicato con quali mezzi dimostrarne la sussistenza, come si riparte l’onere della prova, e, in parallelo, quale tutela è stata accordata dal legislatore al lavoratore nelle diverse e sofferte fasi evolutive della disciplina della materia (legge n. 604/1966, legge n. 300/1970, legge n. 92/2012, D.Lgs. n. 23/2015,D.L. n. 87/2018 ed altre): in particolare, in quali casi viene accordata la reintegra nel posto di lavoro e in quali casi è disposto il risarcimento del danno, nonché le diverse modalità per la sua quantificazione. Per ciascun argomento verrà dato conto dello stato della giurisprudenza sulle principali problematiche solle- vate dalla normativa, anche con riferimento al diritto dell’Unione Europea.Maria Giulia Cosentino Magistrato ordinario, prima ancora avvocato, funzionario del Ministero delle Finanze, borsista al primo corso concorso per dirigenti pubblici della S.N.A.; oggi giudice del lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e dal 2016 giudice tributario componente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Fra il 2012 e il 2016 è stata componente del Comitato Pari Opportunità del Distretto e della Commissione per gli esami di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato. Dopo l’ingresso in magistratura, dal 2001 al 2004 è stata giudice civile a La Spezia; dal 2004 al 2010, fuori ruolo, ha ricoperto l’incarico di giurista esperto per la semplificazione normativa ed amministrativa presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 2008 al 2010, anche Vice Capo del Settore Legislativo per il Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo; dal 2010 al 2017 giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma. Autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto del lavoro; diritto del pubblico impiego; pari opportunità nella pubblica amministrazione; semplificazione normativa; diritto dell’ambiente e dell’energia.
Maria Giulia Cosentino | 2019 Maggioli Editore
22.00 € 17.60 €
Per comprendere meglio la decisione della Suprema Corte, occorre analizzare il caso oggetto del giudizio e, sul punto, vale la pena soffermarsi ad esaminare la Corte d’Appello di Milano 7 aprile 2017, che alla pronuncia in commento ha condotto.
La fattispecie, ovviamente, è relativa ad un’impugnativa di licenziamento, che, nelle fasi di merito del giudizio, è stato ripetutamente dichiarato legittimo, in assenza di prova della violazione della Legge 223/1991 e, segnatamente, del computo delle cessazioni dei rapporti di lavoro ai fini dell’applicabilità della relativa procedura.
In particolare, il licenziamento oggetto di causa era avvenuto il 19 maggio 2014, mentre il recesso pretesamente non considerato era avvenuto il 31 gennaio 2014. Nell’arco temporale di riferimento, la citata Corte d’Appello milanese aveva verificato che, nei 120 giorni antecedenti il licenziamento oggetto di causa era intervenuto un solo ulteriore licenziamento per soppressione del posto di un dirigente, mentre nell’arco dei 120 giorni successivi, erano intervenuti due licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ed erano stati risolti, mediante accordo all’esito della procedura di conciliazione ex art.7 Legge 60471966, due rapporti di lavoro, in ragione del rifiuto dei dipendenti ad accettare un trasferimento dovuto a soppressione del posto di lavoro.
La Corte, quindi, ha escluso che tali due ultime cessazioni potessero rientrare nel computo dovuto ai fini dell’applicabilità della procedura del licenziamento collettivo, in quanto – come peraltro sostenuto sino alla pronuncia che qui si commenta – ciò che è richiesto dalla norma (art. 24 Legge 223/1991) è un licenziamento in senso stretto, che trovi la sua matrice giustificativa in un motivo oggettivo, ovvero nella riduzione o trasformazione della forza lavoro, e, in quest’ottica, non potevano avere alcuna rilevanza le risoluzioni consensuali derivanti dalla mancata accettazione di un trasferimento proposto.
In ogni caso, osserva altresì la Corte, il licenziamento sarebbe legittimo anche attribuendo rilevanza alle due cessazioni citate, in quanto il limite numerico richiesto dalla disciplina non sarebbe stato comunque superato, posto che le altre cessazioni intervenute sarebbero da ascriversi a dimissioni o a licenziamenti con differente causale, certamente non riconducibili alla nozione di licenziamento in senso tecnico richiesta.
Il ricorrente ha impugnato la suddetta decisione di appello ricorrendo in Cassazione e ribadendo, per quanto qui interessa, le doglianze in merito alla violazione dell’art.24 Legge 223/1991 in punto computo dei licenziamenti effettuati, sostenendo in particolare che la risoluzione del rapporto intervenuta a seguito del rifiuto del dipendente al trasferimento rientrerebbe nella nozione di “licenziamento” rilevante ai fini dell’applicazione della procedura collettiva, visti altresì i principi comunitari in materia e di cui alla Direttiva 98/59 CE, così come interpretata da alcune pronunce della Corte di Giustizia UE.
La Corte di Cassazione, accogliendo integralmente il suddetto motivo di gravame, ha ritenuto di dover superare il proprio orientamento sino ad allora granitico ed ha conseguentemente affermato che “rientra nella nozione di “licenziamento” il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo”.
Secondo la Cassazione, il precedente orientamento che interpretava la nozione di “licenziamento” in senso tecnico non sarebbe più condivisibile alla luce dei principi comunitari espressi in materia di procedure di mobilità e, in particolare, contrasterebbe con l’art.1, paragrafo 1, primo comma, lett.a) della Direttiva 98/59/CE del 28 luglio 1998 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi), nonché con l’interpretazione che della suddetta Direttiva è stata fornita dalla Corte di Giustizia UE nella decisione 11 novembre 2014 (causa C-422/14).
L’art. 1, comma primo, lettera a) della Direttiva 98/59/CE, che ha codificato le precedenti direttive in materia di licenziamenti collettivi, dispone in particolare che, ai fini della sua applicazione, «per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore», con indicazione del numero dei licenziamenti effettuati, a scelta degli Stati membri, in base ad alcuni criteri, numerici e temporali prestabiliti. Il secondo comma sempre dell’art. 1 prevede, poi, che «Per il calcolo del numero dei licenziamenti previsti nel primo comma, lettera a), sono assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque».
La Corte di Giustizia UE, invece, nella causa C-422/2014 ( v. in particolare i punti da 50 a 54), ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla interpretazione della Direttiva sopra citata.
Il caso esaminato dalla Corte europea – è importante sottolinearlo per le ragioni che meglio illustreremo in seguito – riguarda una fattispecie relativa alla cessazione di un rapporto di lavoro di diritto spagnolo, imputabile alla modifica unilaterale apportata dal datore di lavoro a un elemento sostanziale ed essenziale del contratto di lavoro, che era stata imposta unilateralmente dal datore di lavoro per ragioni di ordine economico e produttivo (e quindi non inerenti alla persona della lavoratrice medesima), e aveva condotto, a fronte della sua mancata accettazione, alla risoluzione del contratto accompagnata dal versamento di un’indennità, calcolata sulla stessa base di quelle dovute in caso di licenziamento illegittimo.
Con specifico riferimento alla nozione di licenziamento, quindi, la Corte di Giustizia Europea precisa che nella Direttiva 98/59 essa non è espressamente definita, in quanto, secondo anche l’obiettivo perseguito dalla Direttiva medesima, quella di “licenziamento” è una nozione di diritto degli Stati membri che non può essere definita mediante il rinvio alle legislazioni dei singoli Stati. Ciò in quanto “qualsiasi normativa nazionale o di interpretazione di detta nozione che conduca a ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, la risoluzione del contratto di lavoro non costituisca un “licenziamento” […] altererebbe l’ambito di applicazione di detta direttiva, privandola così della sua piena efficacia”. Con la conseguenza che, conclude la Corte di Giustizia europea, essa “deve essere interpretata nel senso che il fatto che il datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di “licenziamento” di cui all’art.1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) della medesima direttiva”[2].
Tale essendo il panorama normativo e giurisprudenziale, le domande sorte a seguito della pubblicazione della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sono state molteplici.
Prima fra tutte, a quale fattispecie risolutiva la Cassazione ha voluto riferirsi? E tra esse, quali sono quelle rilevanti ai fini del calcolo della soglia numerica minima dei cinque licenziamenti di cui alla Legge 223/1991?
In proposito, non si può non evidenziare che la giurisprudenza ha prima d’ora confermato come la cessazione di un rapporto di lavoro per rifiuto di un trasferimento sia un’ipotesi riconducibile, a determinate condizioni, a ragioni di natura oggettiva e, pertanto, astrattamente, essa potrebbe essere ricompresa nel computo dei “licenziamenti” rilevanti ai fini dell’applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, ove il trasferimento derivi dal mutamento della sede aziendale nell’ambito di un processo di riorganizzazione, “il rifiuto del lavoratore al trasferimento presso la nuova sede di lavoro rende legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo”[3].
Non solo. Proprio con riferimento alle risoluzioni consensuali intervenute a seguito del rifiuto al trasferimento ad altra sede (se distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici), l’’INPS ha espressamente riconosciuto che alcuni effetti di una risoluzione consensuale, in determinati casi, possono essere i medesimi di un licenziamento individuale per ragioni economiche (cfr. messaggio n. 369/2018 e circolare n. 108/2006). In tali casi, infatti, in virtù della natura non volontaria di siffatte cessazioni, l’ente previdenziale riconosce la possibilità per i lavoratori coinvolti di accedere ai trattamenti di disoccupazione, spettanti, di regola, in caso di “disoccupazione involontaria” derivante da un licenziamento per ragioni oggettive.
Ciò nonostante, la pronuncia della Suprema Corte in esame, sul punto, è lacunosa, non chiarendo affatto la natura dell’accordo risolutivo preso in esame. Il che, ha suscitato forti perplessità in ragione della possibile interpretazione estensiva che si può dare oggi al concetto di licenziamento, la cui rilevanza della relativa fattispecie parrebbe essere lasciata alla valutazione discrezionale dell’organo giudicante, con tutte le conseguenti ricadute che si possono avere in termini di certezza del diritto.
Oltre, infatti, alle risoluzioni consensuali analizzate nel caso di specie, parrebbe possibile includere anche tutte le cessazioni (perfino le dimissioni) causate da un’iniziativa del datore di lavoro, giungendo – in estrema ipotesi – ad includere anche atti del tutto diversi da un caso di licenziamento, se giustificate da una modifica peggiorativa del rapporto di lavoro, proveniente da iniziativa del datore di lavoro.
E’ stato altresì evidenziato che la fattispecie presa in considerazione della Corte di Giustizia del 2015, richiamata dalla pronuncia in esame, riguardava nello specifico la riduzione della retribuzione in maniera stabile, comportante – come tale – la modifica (in pejus) di un elemento essenziale del rapporto di lavoro, non accettata dal lavoratore perché imposta; mentre il trasferimento di sede oggetto dall’ordinanza di Cassazione rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, del tutto legittimo se sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come previsto dall’art.2103 c.c. e, come tale, si tratterebbe di ipotesi non assimilabile al licenziamento.
Ancora una volta, sul punto, la decisione della Corte di Cassazione in esame appare lacunosa e comunque non adeguatamente approfondita: gli Ermellini, infatti, non si sono preoccupati né di verificare quale fosse la volontà della lavoratrice (trasferita) di risolvere il rapporto di lavoro – che, pertanto, è stata ritenuta del tutto irrilevante ai fini che ci occupano – né tanto meno le ragioni poste alla base del trasferimento medesimo e, quindi, l’eventuale riconducibilità di tale provvedimento alla medesima “operazione” di riduzione della forza lavoro che aveva determinato il licenziamento impugnato e oggetto dell’esame della Corte.
Quid iuris per (tentare) di uscire dall’empasse? Quali fattispecie in conclusione occorre tenere in considerazione?
Per rispondere al quesito, probabilmente occorre tenere presente prima di tutto che, nella prospettiva della giurisprudenza comunitaria, il licenziamento è visto quale fenomeno socio economico non come atto contrattuale. Con ogni conseguenza che ciò comporta, prima di tutto dal punto di vista dell’onere probatorio, che, nella specie, parrebbe essere molto più gravoso, in quanto richiede un’indagine sull’intento fraudolento posto in essere, piuttosto che limitarsi ad incasellare il recesso nella dimensione meramente contrattuale.
Inoltre, rispetto ad una giurisprudenza che sino ad oggi ha individuato il licenziamento, anche collettivo, quale mero atto unilaterale del datore di lavoro, oggi si fa strada una definizione di licenziamento c.d. indiretto, caratterizzato da tre elementi: a) deve trattarsi di cessazione del rapporto derivante da ragioni non inerenti la persona del lavoratore; b) deve essere disposta (rectius: decisa) unilateralmente dal datore di lavoro; c) deve essere relativa alla modifica di un elemento essenziale del contratto.
Ovviamente, alcune riflessioni in termini di rilevanza della modifica, nonchè della liceità o meno della stessa, si pongono, a questo punto, doverose. E, in proposito, ancora una volta la giurisprudenza comunitaria ci fornisce alcune indicazioni, delle quali non possiamo non tenere conto.
La sentenza della Corte di Giustizia, 21 settembre 2017, in causa C-429/16, ad esempio, ha deciso un caso di diritto polacco, simile a quello spagnolo oggetto della sentenza del 2015 già citata, dove la riduzione del 15% della retribuzione proposta al lavoratore, ancora una volta in ragione della crisi aziendale era, però, temporanea ed ha conseguentemente stabilito che “il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica non sostanziale di un elemento essenziale del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona di tale lavoratore o a una modifica sostanziale di un elemento non essenziale di detto contratto per ragioni non inerenti alla persona di tale lavoratore non può essere qualificato come «licenziamento» ai sensi della citata direttiva”. Secondo la Corte, infatti, il carattere temporaneo della riduzione del 15% della retribuzione diminuirebbe sensibilmente la portata della modifica del contratto di lavoro prevista, che potrebbe, anche, non essere considerata una modifica sostanziale, e così rimettendo la conseguente valutazione sul punto al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie[4].
A ciò vanno aggiunte le fattispecie c.d. “assimilate”, che si distinguono dal licenziamento tout court per la presenza del consenso del lavoratore, ma che non rientrano nel computo numerico perché, attesa la presenza del consenso del lavoratore, ai sensi della Direttiva 98/52 ne sono espressamente escluse.
Conclusioni
In conclusione, attesa l’incompleta, e forse a tratti anche un po’ frettolosa, indagine svolta dai giudici della Cassazione riguardo la fattispecie concreta nella decisione in esame, si possono ipotizzare le ipotesi che con maggiore probabilità possiamo oggi far rientrare nella nozione di “licenziamento” rilevante ai fini dell’applicabilità della procedura di cui alla Legge 223/1991, anche alla luce dei principi comunitari che abbiamo sin qui analizzato.
In proposito, oltre ovviamente ai licenziamenti in senso tecnico, forse non deve sorprendere la possibilità (presa in esame probabilmente anche dalla Cassazione che qui si commenta) di far rientrare nelle fattispecie rilevanti gli accordi resi a seguito della procedura di conciliazione di cui all’art,7 L.604/66 – atteso il susseguirsi degli eventi che conduce all’accordo risolutorio, assimilabile ad un licenziamento – cui aggiungere le risoluzioni consensuali rese a latere di una procedura di licenziamento collettivo, in caso di mancata accettazione dei relativi accordi da parte dei lavoratori.
Si potrebbe anche considerare la fattispecie, oggi prevista dal nuovo testo dell’art. 2103 c.c., che consente al datore di lavoro, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, di assegnare il lavoratore a mansioni relative ad un livello di inquadramento immediatamente inferiore, che potrebbero non essere accettate, con conseguenti dimissioni ed eventuale accordo di risoluzione consensuale del rapporto. Lo stesso dicasi nell’ipotesi di soppressione del posto di lavoro e della proposta, non accettata dal lavoratore, di una nuova mansione in adempimento dell’obbligo di repéchage.
Potrebbe altresì rientrare la proposta di una variazione, per collocazione o riduzione, dell’orario di lavoro, ovvero ancora il caso di dimissioni per giusta causa a seguito di un provvedimento di trasferimento illegittimo (in quanto disposto oltre il limite chilometrico previsto dal CCNL), come pure le risoluzioni consensuali stipulate a seguito della mancata accettazione del lavoratore di un provvedimento di trasferimento legittimo, in quanto reso entro il limite chilometrico previsto contrattualmente.
Non è da escludere, infine, la fattispecie delle dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. determinate, ad esempio, dal mancato pagamento delle retribuzioni in conseguenza di una crisi aziendale o da una modifica contrattuale imposta dal datore di lavoro, sempre per motivi economici, e non accettata dal lavoratore. E ciò anche in ragione dell’orientamento espresso prima d’ora dalla Corte Costituzionale, la quale ha in un proprio obiter dictum, ha considerato rilevante, in un caso simile, la mancanza della libera scelta del lavoratore nel rassegnare le dimissioni, in quanto sostanzialmente indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della impossibilità della prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto[5].
E’ evidente, pertanto, come la valutazione delle modifiche di elementi essenziali al rapporto di lavoro, ancorché legittime e purché espressione di un obbligo gravante sul datore di lavoro (e ciò, evidentemente, anche in un’ottica di adempimento del repéchage), nonché l’individuazione delle concrete fattispecie ai fine del computo rilevante per l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo qualora le suddette modifiche sostanziali non siano accettate dal lavoratore, hanno un impatto rilevante (e forse anche chiarificatore) della decisione della Cassazione in esame e il discrimine sta tutto in tali valutazioni.
Ciò senza considerare che, in questo momento storico, la suddetta decisione sta certamente avendo un considerevole impatto in relazione alla gestione degli esuberi del personale, considerato che, atteso il blocco dei licenziamenti in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria in corso, frequente è il ricorso alle risoluzioni consensuali, posto che l’art. 14 D.L. 104/20 (c.d. Decreto “Agosto”) esclude tale fattispecie di cessazione del rapporto dalla sospensione dei licenziamenti ex lege, purché esse siano basate su “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale [e] limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.
Risoluzioni che, alla luce del mutato licenziamento giurisprudenziale, potrebbero essere ritenute incluse nel computo dei licenziamenti rilevanti ai fini dell’applicabilità della procedura richiesta per i licenziamenti collettivi. Il che impone, come da più commentatori già osservato, un maggiore grado di prudenza nelle conseguenti valutazioni e determinazioni, specie quando il blocco dei licenziamenti sarà cessato.
Volume consigliato
Il licenziamento nel settore privato
Con un approccio per quesiti e problemi, si offre una panoramica della normativa in tema di licenziamenti nei rapporti di lavoro privato, le cui disposizioni si sono stratificate e sovrapposte nel tempo in relazione alla natura e alle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, al settore, alla qualifica, alla data di assunzione, alla data di licenziamento, al tipo di rapporto, creando un sistema difficilmente intellegibile per l’operatore. Verrà illustrato come distinguere il licenziamento dalle ipotesi affini, quale forma deve rivestire e per quali motivi si può legittimamente licenziare, con quale procedura e con quale tempistica; come impugnare un licenziamento, attraverso quali adempimenti da compiere prima del giudizio e come evitare le decadenze di legge, come impostare un ricorso avverso un licenziamento illegittimo e quali sono le caratteristiche del rito da seguire. Saranno passati in rassegna i principali vizi che possono affliggere l’atto espulsivo, indicato con quali mezzi dimostrarne la sussistenza, come si riparte l’onere della prova, e, in parallelo, quale tutela è stata accordata dal legislatore al lavoratore nelle diverse e sofferte fasi evolutive della disciplina della materia (legge n. 604/1966, legge n. 300/1970, legge n. 92/2012, D.Lgs. n. 23/2015,D.L. n. 87/2018 ed altre): in particolare, in quali casi viene accordata la reintegra nel posto di lavoro e in quali casi è disposto il risarcimento del danno, nonché le diverse modalità per la sua quantificazione. Per ciascun argomento verrà dato conto dello stato della giurisprudenza sulle principali problematiche solle- vate dalla normativa, anche con riferimento al diritto dell’Unione Europea.Maria Giulia Cosentino Magistrato ordinario, prima ancora avvocato, funzionario del Ministero delle Finanze, borsista al primo corso concorso per dirigenti pubblici della S.N.A.; oggi giudice del lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e dal 2016 giudice tributario componente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Fra il 2012 e il 2016 è stata componente del Comitato Pari Opportunità del Distretto e della Commissione per gli esami di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato. Dopo l’ingresso in magistratura, dal 2001 al 2004 è stata giudice civile a La Spezia; dal 2004 al 2010, fuori ruolo, ha ricoperto l’incarico di giurista esperto per la semplificazione normativa ed amministrativa presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 2008 al 2010, anche Vice Capo del Settore Legislativo per il Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo; dal 2010 al 2017 giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma. Autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto del lavoro; diritto del pubblico impiego; pari opportunità nella pubblica amministrazione; semplificazione normativa; diritto dell’ambiente e dell’energia.
Maria Giulia Cosentino | 2019 Maggioli Editore
22.00 € 17.60 €
Note
[1] In tal senso Cass. Civ., Sez. Lavoro, 25 ottobre 200 n.14079; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 22 febbraio 2006 n.3866; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 22 gennaio 2007 n.1334; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 29 marzo 2010 n.7519
[2] Nello stesso senso si sono espresse, sempre in ambito europeo, anche CGUE 12 ottobre 2004 n.C-55/02, consultabile su Foro Italiano 2204, IV, 606; CGUE 7 settembre 2005, causa da C-187/05 a C-190/05, ivi, 2007, IV,270
[3] Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 novembre 2013, n.25615
[4] La pronuncia della CGUE citata si può leggere in LG, 2018, 337. Nello senso di ritenere non configurabile un licenziamento indiretto si è espressa anche CGUE 21 settembre 2017, in causa C- 149/16 in tema di modifica del calcolo del premio di anzianità.
[5] Si veda in proposito Corte Cost., 22 giugno 2002 n.269, consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it


















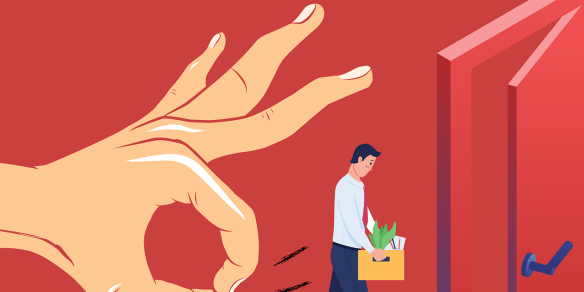


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento