Inquadramento della fattispecie demansionamento
Con il termine “demansionamento” si indica l’adibizione del lavoratore a mansioni ricomprese in un livello di inquadramento (genericamente inferiore) rispetto a quello pattuito all’interno del contratto individuale di lavoro o a quello corrispondente alle mansioni da ultimo svolte.
Fino al 24 giugno 2015, il demansionamento era considerato illegittimo, allorquando posto in essere in violazione del “principio dell’equivalenza” previsto dall’ art.2103, comma 1, c.c. (nella formulazione in allora vigente), in virtù del quale il datore aveva la facoltà di adibire il lavoratore non soltanto alle mansioni di assunzione, ma anche a quelle equivalenti alle “ultime effettivamente svolte”, ovverosia quelle previste dalla qualifica e riconducibili a quel preciso contratto, che il lavoratore stava effettivamente prestando al momento dell’esercizio del potere di mutamento del datore di lavoro, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
La suddetta disciplina ha subito un radicale mutamento ad opera dall’ art.3 D. Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore, per l’appunto, il 25 giugno 2015.
Il nuovo primo comma dell’art. 2103 c.c. stabilisce oggi infatti che: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” (demansionamento c.d. orizzontale).
Il criterio dell’”equivalenza delle mansioni”, presente nella precedente formulazione, è quindi oggi sostituito, ad opera della riforma, dal riferimento più puntuale alle “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento”, laddove la nozione “livello di inquadramento” raggruppa una serie di specifici profili professionali che sono individuati in base alle caratteristiche della prestazione di lavoro e di dati ambientali e/o sociali e il riferimento alla “categoria legale” di inquadramento rimanda alla prescrizione di cui all’art. 2095 c.c., secondo il quale “i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (…)”.
Sempre secondo il nuovo art.2103 c.c., l’esercizio datoriale del potere dello jus variandi in peius (c.d. demansionamento verticale) sarebbe legittimo in tre ipotesi specifiche, e segnatamente:
- nel caso in cui la modifica di assetti organizzativi aziendali incida sulla posizione del lavoratore (art. 2103, comma 2, c.c.). In questa ipotesi il demansionamento è un effetto della determinazione unilaterale del datore di lavoro, che prescinde da una pattuizione con il lavoratore, ma presuppone la sussistenza di una sorta di giustificato motivo oggettivo, per motivi ricollegabili alla gestione dell’impresa;
- nel caso di previsione da parte del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro (art. 2103, comma 4, c.c.);
- nel caso di previsione da parte di un accordo individuale di modifica delle mansioni stipulato nelle c.d. sedi protette, che risponda all’interesse del lavoratore: alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle proprie condizioni di vita (art. 2103, comma 6, c.c.).
Le suddette tre ipotesi sono tutte accomunate dal fatto che, per rendere possibile l’assegnazione a mansioni inferiori, è necessaria la sussistenza della causa che le giustifica e richiedono tutte la forma scritta quale forma di comunicazione al lavoratore (art. 2103, comma 8, c.c.); viceversa si differenziano per il fatto che le fattispecie ex 2° e 4° comma, comportano un demansionamento di un solo livello inferiore a parità di categoria legale, nonché il mantenimento del trattamento retributivo goduto in precedenza, e sono frutto dell’esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro; mentre quelle che trovano il proprio fondamento nel 6° comma possono determinare un mutamento in peius anche oltre il limite del livello di inquadramento inferiore, per esse non è prevista la conservazione del trattamento corrispettivo, ed infine derivano da accordi individuali.
E’, infine, dedicato alla cd. mobilità verticale verso mansioni superiori il nuovo comma 7 dell’art. 2103 c.c., che prevede testualmente che: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
E’ evidente, già da questa sintetica premessa che, con la nuova formulazione dell’art. 2103 cod. civ., si è verificato un cambiamento significativo in materia di flessibilità interna dell’organizzazione del lavoro. Scopo della riforma, infatti, è stato quello di dilatare il perimetro delle mansioni esigibili per realizzare l’obiettivo di aumentare la flessibilità interna del lavoratore. In tal modo, si è assistito ad un ampliamento e ad una legittimazione del potere in capo al datore di lavoro di modificare unilateralmente la prestazione lavorativa, soprattutto quando egli sia costretto ad attuare dei cambiamenti nell’organizzazione e nell’attività produttiva della propria azienda.
Volume consigliato
Lavoro e crisi d’impresa
Il lavoro quale elemento cardine dell’ordinamento italiano non trovava adeguato spazio, né tutela nel sistema complesso delle procedure concorsuali. Il d.lgs. n. 14/2019, che ha profondamente riformato la materia concorsuale e introdotto il “Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” prevede, per la prima volta, una disciplina ad hoc per i rapporti di lavoro dipendente. L’opera si propone di analizzare l’evoluzione della rilevanza che la tutela del lavoro dipendente, ma non solo, ha assunto nella disciplina concorsuale, fondata finora prevalentemente sulla tutela del diritto di credito. La ricerca e la rilevanza di soluzioni conservative, alternative alla liquidazione dell’impresa, l’introduzione di sistemi di allerta tali da assicurare un tempestivo e più proficuo intervento nella gestione della crisi rappresenta la chiave di volta nell’individuazione di punti di contatto tra due materie che, finora, sono state delineate quali due rette parallele dirette al perseguimento di obiettivi diametralmente opposti. Questa una delle linee fondamentali della riforma che viene compiutamente illustrata comunque nella prospettiva della sua entrata in vigore. Mariaelena Belvisoaffronta il tema della tutela del lavoro nella crisi d’impresa con una tesi di laurea in Giurisprudenza, dal titolo “Diritto del lavoro e diritto fallimentare: prospettive di dialogo”, votata con lode, presso l’Università LUMSA di Roma. Approfondisce tale tematica anche durante il tirocinio svolto, dal 2017 al 2019, presso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
Mariaelena Belviso | 2020 Maggioli Editore
29.00 € 23.20 €
La tutela risarcitoria nel caso di esercizio di jus variandi illegittimo.
Uno dei problemi più delicati in materia di demansionamento ha riguardato (e riguarda in parte ancora oggi) la tutela risarcitoria, cioè il riconoscimento al lavoratore di un diritto al risarcimento del danno collegato a un uso illegittimo del potere datoriale di modifica delle mansioni. L’abuso dell’utilizzo del potere datoriale, infatti, ha fatto sì che da tempo i Giudici si siano posti il problema di assicurare al lavoratore una tutela anche giurisdizionale allorquando penalizzato dalle scelte datoriali.
Già nel 1992 la Cassazione, decidendo una controversia promossa da un dipendente isolato in seguito alla “lottizzazione politica” dell’azienda presso cui era adibito, riconosceva al lavoratore demansionato un diritto al risarcimento del danno subito, vedendo nella dequalificazione una “compromissione peggiorativa della c.d. capacità di concorrenza dell’individuo rispetto agli altri soggetti nei rapporti sociali ed economici” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 dicembre 1992, n.13299). In quell’occasione la Corte ha riconosciuto al lavoratore, prima ancora che un danno alla professionalità, una lesione alla sua personalità, ai sensi dell’art. 2 della Carta Costituzionale, riconoscendo altresì, conseguentemente, il diritto al risarcimento del relativo danno.
Il principio della tutela della dignità professionale e personale del lavoratore sono stati ribaditi e rafforzati da pronunce giurisprudenziali successive, fino a configurarsi come uno degli oggetti primari della tutela accordata al prestatore di lavoro: secondo la giurisprudenza, infatti, la violazione dell’art. 2103 c.c. è idonea a dar luogo ad una lesione del “fondamentale diritto al lavoro, inteso come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché immagine della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificata dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza”; tale modus operandi produce “una lesione di un bene immateriale per eccellenza qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 maggio 2006, n. 11430).
E’ ormai opinione prevalente, a livello giurisprudenziale e dottrinale, che la responsabilità da demansionamento del datore di lavoro rientri nel novero della responsabilità contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 c.c., da intendersi come inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. In proposito, le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “deve ritenersi proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato, mentre si può ritenere proposta l’azione di responsabilità contrattuale quando la domanda di risarcimento del danno sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una puntuale obbligazione contrattuale” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 maggio 2004 n.8438).
Le tipologie di danni risarcibili: patrimoniali e non patrimoniali.
Ma se la configurazione della responsabilità datoriale come contrattuale appare ormai chiara, e da ciò discende l’esonero del lavoratore dall’onere della prova dell’imputabilità dell’inadempimento, l’aspetto che invece suscita non pochi problemi è quello relativo alla quantificazione del risarcimento, date le numerose figure di danni risarcibili, individuate dalla giurisprudenza.
In tema di danno da esercizio illegittimo del potere dello jus variandi, già la Corte Costituzionale aveva affermato che “dalla violazione da parte del datore dell’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest’ultimo danni di vario genere, danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramento all’interno o all’esterno dell’azienda; danni alla persona ed alla sua dignità, particolarmente gravi nell’ipotesi, non di scuola, in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha diritto si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione , sicché egli riceve la retribuzione senza fornire alcun corrispettivo; danni alla salute fisica e psichica.” (Corte Costituzionale, 6 aprile 2004 n.113), e così anticipando, di fatto, quelle che saranno le conclusioni cui giungerà, solo pochi anni dopo, la Corte di Cassazione.
Si legge infatti nella pronuncia a Sezioni Unite del 24 marzo 2006 n.6572, che “dall’inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l’una con l’altra” e così pronunciando ponendo l’accento sulla configurazione del danno esistenziale, definito più precisamente quale lesione “all’identità professionale sul luogo di lavoro, all’immagine o alla vita di relazione, o comunque come quel pregiudizio al diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli art. 1 e 2 Cost” (ibidem).
Oltre all’individuazione di questo tipo di danno, all’interno della predetta pronuncia del 2006, vengono menzionati anche danni quelli aventi contenuto patrimoniale, tra cui in primo luogo il danno professionale, che può presentarsi nella realtà in varie forme, quali l’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore, la mancata acquisizione di una maggiore capacità, il pregiudizio subito per perdita di chance o di ulteriori possibilità di guadagno (su cui torneremo più diffusamente infra). In tale categoria di danno professionale parrebbe inoltre rientrare anche il danno biologico, che si configura tutte le volte in cui è riscontrabile una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore medicalmente accertabile.
Con la propria successiva sentenza, sempre a Sezioni Unite, dell’11 novembre 2008, n. 26972, la Cassazione ha invece scelto di suddividere la categoria dei danni risarcibili con una più semplice distinzione tra danno professionale a contenuto patrimoniale e quello a contenuto non patrimoniale, definendo il primo in continuità con quanto stabilito dal precedente suo intervento, e pertanto quale pregiudizio derivante dall’obsolescenza della capacità professionale acquisita o dalla perdita di ulteriori possibilità di guadagno o di carriera, laddove, in relazione al danno non patrimoniale, è invece affermato trattarsi di una “categoria ampia e onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile individuare ulteriori sottocategorie, se non con finalità puramente descrittiva”.
Oltre a far chiarezza sul punto, la sentenza del 2008 ha il merito di evidenziare come si fossero in allora formati due orientamenti contrapposti in tema di danno non patrimoniale, l’uno – come visto – favorevole alla configurabilità come categoria autonoma del danno esistenziale, inteso come un pregiudizio attinente alla sfera del fare reddittuale, l’altro invece contrario ad esso, ponendo un punto fermo sulla questione e, pertanto, ritenendo di dover privilegiare il filone secondo il quale il danno esistenziale non rappresenta altro che una voce della più ampia categoria di danno non patrimoniale.
Conseguentemente, precisa sempre la Cassazione nella medesima pronuncia richiamata, anche il danno morale “non individua un’autonoma sottocategoria, ma descrive un tipo di pregiudizio non patrimoniale, costituito dalla sofferenza soggettiva causata dal reato”, indipendentemente dalla sua intensità e durata nel tempo. Parimenti dicasi per il danno biologico, qualificato come una lesione all’integrità psico-fisica del soggetto, di carattere temporaneo o permanente, suscettibile di accertamento medico legale, che ha conseguenze negative sulla vita quotidiana della persona e sulle sue capacità dinamico relazionali.
Detto in altri termini, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ancora di attualità, i suddetti tipi di danno (esistenziale, morale e biologico) non devono più essere liquidati separatamente (evitando così, peraltro, il rischio di una duplicazione di indennizzi riconoscibili), ma rappresentano differenti aspetti del danno non patrimoniale, nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi attinenti alla persona non connotati da natura economica, il cui riconoscimento e quantificazione terranno conto delle varie voci di cui si compone.
In estrema sintesi, è pertanto oggi possibile affermare che i tipi di danni che potrebbero conseguire al demansionamento sono fondamentalmente di due tipi: di contenuto patrimoniale e non patrimoniale. Rappresenta danno del primo tipo il danno professionale (perdita di chance), e sono invece danni del secondo e unitario genere, il danno morale soggettivo, il danno esistenziale e quello biologico.
Occorre tuttavia precisare che, nel corso del tempo, la giurisprudenza, anche attraverso la valorizzazione dell’art. 2087 cod. civ., abbia arricchito la fattispecie del danno non patrimoniale, in particolare nella specie del danno esistenziale, pur permanendo nelle decisioni l’assenza di rilevanza autonoma dello stesso. Certamente, come autorevole dottrina ha anche evidenziato[1], non possiamo non osservare come l’avvento del Jobs Act abbia influito sulla tematica in questione, riducendo ovviamente i casi di risarcimento di tale categoria di danno in conseguenza dell’introduzione, con il novellato art. 2103 cod. civ., di fattispecie di demansionamento “legittimo”, ed in particolare a seguito del venir meno della regola dell’equivalenza legata alla professionalità acquisita dal lavoratore nella mobilità orizzontale.
In particolare: il danno professionale a contenuto patrimoniale e il danno da perdita di chance.
Il danno professionale a contenuto patrimoniale incide direttamente sulla capacità reddituale del prestatore di lavoro e consta fondamentalmente di due ipotesi. La prima, facilmente intuitiva, riguarda il caso in cui il soggetto sia stato privato della propria capacità professionale acquisita o dell’eventuale mancata acquisizione di una diversa capacità del medesimo valore (cioè relativa a mansioni inquadrate nello stesso livello).
Così, a titolo esemplificativo, la Corte di cassazione ha recentemente affermato che il pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore nonché di accrescimento di quella futura, si verifica tutte le volte in cui un lavoratore sia chiamato a svolgere un’attività soggetta ad una continua evoluzione e formazione e, quindi, caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale, destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio in un apprezzabile periodo di tempo (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 settembre 2016 n. 18405; Cassazione Civile, Sezione lavoro, 4 agosto 2017 n. 19600)
La seconda ipotesi di danno professionale riguarda, invece, la lesione al prestatore di lavoro derivante dalla cd. perdita di chance, vale a dire il mancato guadagno che lo stesso avrebbe potuto conseguire qualora avesse conservato le mansioni originarie, ovvero la perdita di ulteriori potenzialità occupazionali.
Negli anni ‘60, la giurisprudenza escludeva la risarcibilità del danno da perdita di chance, ritenendo che ad essere leso fosse solo un interesse di mero fatto. Era stata soprattutto la dottrina a sollevare dubbi in ordine alla risarcibilità di tale posta di danno, partendo dalla considerazione che la perdita di chance non avrebbe potuto dar luogo a un danno ingiusto, che secondo l’articolo 2043 c.c. sarebbe stato configurabile solo in caso di lesione di diritti soggettivi assoluti. Successivamente la giurisprudenza, soprattutto a partire dal gli anni ‘80, non ha più condiviso questo orientamento e ha iniziato ad ampliare l’area del danno risarcibile finendo con l’includervi anche la lesione degli interessi connessi alla perdita di chance.
Il percorso giurisprudenziale, invero, è stato lungo e non sempre lineare; inizialmente la Cassazione non riconosceva il diritto al risarcimento della perdita di una semplice aspettativa di ottenere un risultato futuro, solo successivamente ha ricompresa la perdita di chance nella categoria del lucro cessante, stabilendo la conseguente necessità di provare che dalla condotta datoriale fosse derivata la perdita di un vantaggio patrimoniale (prova, invero, assai complicata da fornire). È stato solo alla fine del 90 che il danno da perdita di chance è stato qualificato come danno patrimoniale futuro o emergente e che la perdita di chance è stata quindi ritenuta risarcibile di per sé, in quanto essa consistente nella perdita di “una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (tra le molte, Cassazione Civile, ordinanza 29 maggio 2018 n.13489).
In particolare, proprio con specifico riferimento al danno professionale da perdita di chance, è stato osservato che il pregiudizio per perdita di chance, il quale si identifica nella definitiva perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico, da valutarsi, peraltro ex ante, ovvero al momento dell’illecito, potrà essere configurato solo nell’ipotesi in cui il lavoratore dimostri quali aspettative (anche di carriera) siano state concretamente frustrate dal suo demansionamento.
Sul punto, si evidenzia una significativa decisione della Suprema Corte che, confermando la sentenza della Corte territoriale in ordine alla domanda di risarcimento del danno da parte di un lavoratore trasferito dal settore delle relazioni sindacali, di cui era referente, al dipartimento fondo pensioni, settore per nulla aderente alla sua pregressa competenza e professionalità, ha ravvisato un danno da perdita di chance sul presupposto causale che, se non fosse intervenuto il demansionamento, lo stesso lavoratore avrebbe acquisito l’esperienza e la maturità tale da poter conseguire la superiore qualifica di dirigente “per come era avvenuto per una significativa quota dei funzionari del suo grado a ridosso del periodo in considerazione” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 aprile 2012 n. 6110).
In un altro caso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il danno da perdita di chance a due lavoratrici alle quali era stata sottratta una posizione di responsabilità nei rispettivi settori di competenza, a causa dell’unificazione degli stessi e dell’assegnazione della titolarità del nuovo ambito ad un soggetto esterno. In particolare, con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità, una volta accertata la privazione illegittima della direzione di unità operativa, hanno osservato che “se è vero che la nuova posizione organizzativa era unica a seguito dell’accorpamento delle aree e che le aspiranti 9 erano due, sicché entrambe non avrebbero potuto contestualmente congiuntamente ricoprire la posizione organizzativa unica risultante dall’accorpamento, è anche vero che entrambe le lavoratrici avevano una chance (da ritenersi, in assenza di elementi di valutazione, in parti uguali) di poter conseguire la posizione organizzativa, ciò che naturalmente implica una percentuale di probabilità che comunque va riconosciuta, essendo certo che la posizione organizzativa, in assenza dell’illegittima nomina del terzo, sarebbe spettato ad una delle lavoratrici aspiranti” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 agosto 2014 n. 18207).
Ciò che è importante sottolineare che nelle suddette ipotesi di danno – come invero in tutte le ipotesi di richiesta del riconoscimento di un danno da demansionamento – esso non può considerarsi in re ipsa, ovvero immanente rispetto all’inadempimento del datore di lavoro, ma necessita di essere provato dal lavoratore, anche in via presuntiva.
Sin dalla richiamata pronuncia a Sezioni Unite del 2006, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che il danno da demansionamento richieda di essere specificatamente provato, unitamente al nesso di casualità che lo legherebbe all’ inadempimento datoriale (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 gennaio 2015 n.1327) e precisando che il prestatore ha il dovere di fornire una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio e, in fase istruttoria, di provare la sussistenza del danno e il conseguente, come detto, nesso di causalità (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 ottobre 2018 n.25071; Cassazione Civile 5 dicembre 2017 n.29047).
Da ultimo, con la recentissima pronuncia del 17 dicembre 2020 n.29012, la Cassazione, ancora in tema di danno da perdita di chance, dopo aver ribadito il principio generale secondo il quale “deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti un automatica perdita di chance ovvero di ulteriori possibilità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, a ciò conseguendo che, grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova, anche mediante presunzioni, dell’ulteriore danno risarcibile”, ha altresì precisato che “la perdita di chance configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzioni, e alla mancanza di tale prova non si può sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell’art.1226 cod. civ. atteso che l’applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l’esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno”.
Volume consigliato
Lavoro e crisi d’impresa
Il lavoro quale elemento cardine dell’ordinamento italiano non trovava adeguato spazio, né tutela nel sistema complesso delle procedure concorsuali. Il d.lgs. n. 14/2019, che ha profondamente riformato la materia concorsuale e introdotto il “Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” prevede, per la prima volta, una disciplina ad hoc per i rapporti di lavoro dipendente. L’opera si propone di analizzare l’evoluzione della rilevanza che la tutela del lavoro dipendente, ma non solo, ha assunto nella disciplina concorsuale, fondata finora prevalentemente sulla tutela del diritto di credito. La ricerca e la rilevanza di soluzioni conservative, alternative alla liquidazione dell’impresa, l’introduzione di sistemi di allerta tali da assicurare un tempestivo e più proficuo intervento nella gestione della crisi rappresenta la chiave di volta nell’individuazione di punti di contatto tra due materie che, finora, sono state delineate quali due rette parallele dirette al perseguimento di obiettivi diametralmente opposti. Questa una delle linee fondamentali della riforma che viene compiutamente illustrata comunque nella prospettiva della sua entrata in vigore. Mariaelena Belvisoaffronta il tema della tutela del lavoro nella crisi d’impresa con una tesi di laurea in Giurisprudenza, dal titolo “Diritto del lavoro e diritto fallimentare: prospettive di dialogo”, votata con lode, presso l’Università LUMSA di Roma. Approfondisce tale tematica anche durante il tirocinio svolto, dal 2017 al 2019, presso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
Mariaelena Belviso | 2020 Maggioli Editore
29.00 € 23.20 €
[1] Santoro Passarelli, Sulle categorie del diritto riformate, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, 2016, 288

















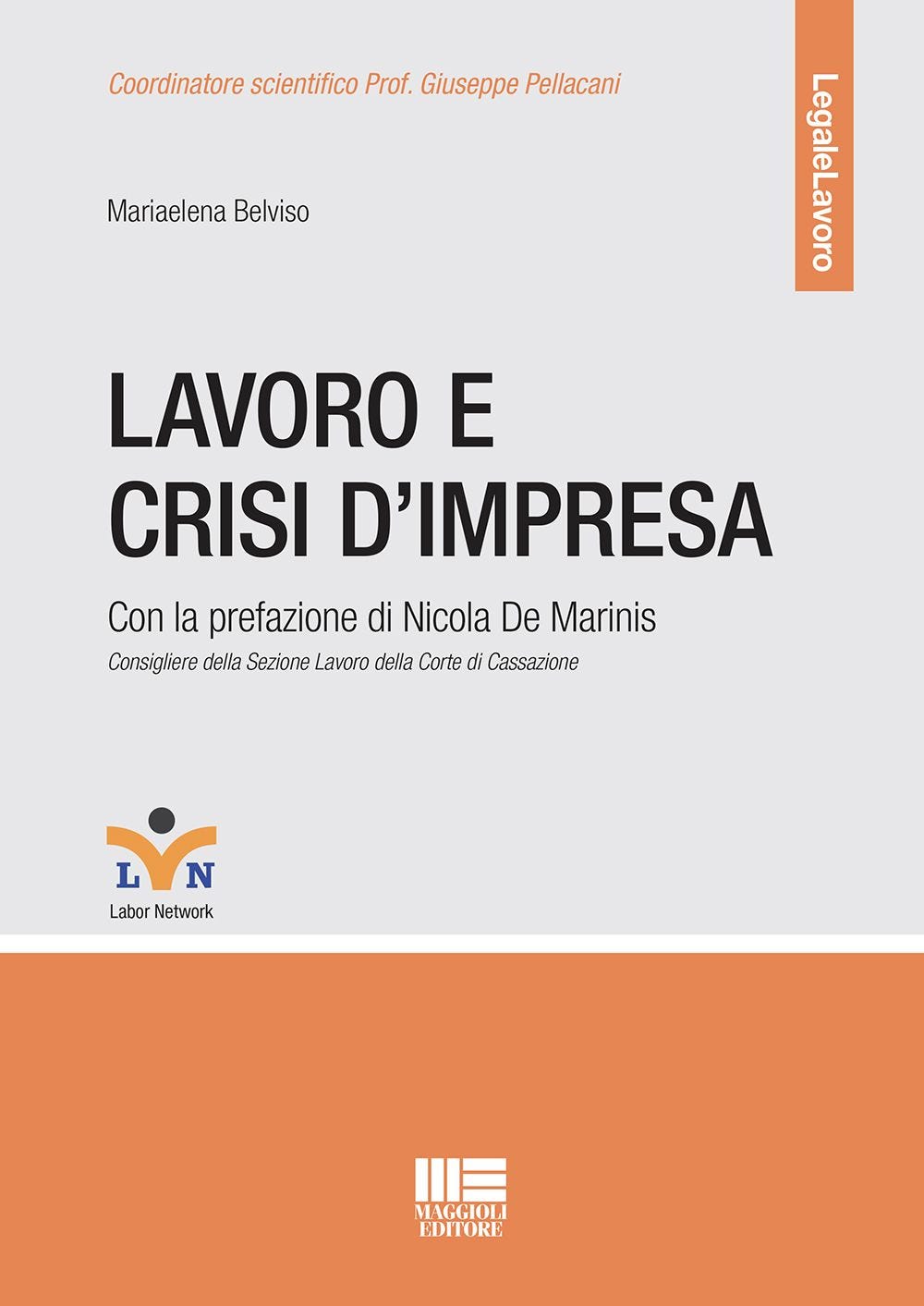

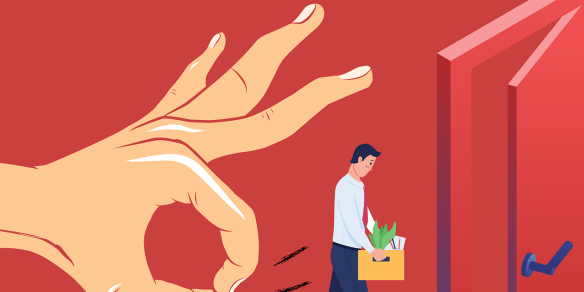


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento