Approfondimento sull’accelerazione del processo in appello nella riforma Cartabia, con riferimento agli istituti dell’avocazione e del concordato.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale
Indice
1. Accelerazione dell’appello nella riforma Cartabia: introduzione
Il sistema processuale di giudizio di secondo grado, nell’ottica della cosiddetta riforma Cartabia ed in particolare dei decreti attuativi che le hanno dato esecuzione, trova un suo punto focale nel novellato giudizio di appello sotto il duplice versante delle garanzie dell’imputato e della celerità del procedimento. Tanto si rinviene, innanzitutto, nel novellato articolo 601 c.p.p.: atti preliminari al giudizio. In tale sede processuale, il presidente del collegio giudicante, ordina preliminarmente, appunto, che l’imputato appellante sia citato senza ritardo; se invece vi è appello della pubblica accusa, l’ordine è rivolto altresì all’imputato non appellante. Allorquando la Corte disponga lo svolgimento dell’udienza nelle forme della partecipazione delle parti, anteriormente alla citazione degli imputati ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Il decreto in parola conterrà senz’altro l’indicazione delle forme decisorie: o pubblica udienza ovvero udienza camerale; quest’ultima nelle forme e coi modi dell’articolo 127 [1] c.p.p.
Tra i requisiti contenutistici del decreto di citazione per il giudizio di appello, spicca ora l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza; nel decreto vi sarà altresì l’indicazione del giudice competente e quella relativa al procedimento in camera di consiglio de plano,salvo che l’imputato o il suo difensore non chiedano la partecipazione all’udienza nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto.
Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello è notificato avviso ai difensori; avviso che deve, in sede di atti preliminari al giudizio, essere altresì comunicato al procuratore generale. In uno alla mancanza e/o insufficienza dell’indicazione dei requisiti essenziali del decreto di citazione a giudizio, comportano altresì nullità dell’atto preliminare in parola la non identificazione, in modo certo, dell’imputato e la mancanza dell’avvertimento al medesimo che non comparendo sarà giudicato in assenza.
Unitamente all’indicata novellazione il sistema processuale di gravame novellato in esecuzione della riforma Cartabia incentra però l’attenzione su due istituti in modo particolare: l’avocazione delle indagini preliminari e il cosiddetto atteggiamento d’appello, ossia il concordato.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo:
La Riforma Cartabia della giustizia penale
Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022
36.10 €
2. L’avocazione delle indagini
Il sistema dell’avocazione delle indagini preliminari è stato completamente rivoluzionato dalla riforma Cartabia; norma fondamentale del sistema in discorso è l’art.412 c.p.p. [2] che opera una vera e propria ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’istituto avocativo nella duplice direttiva della facoltatività dello stesso, giusto la discrezionalità del procuratore generale e dell’ampiezza dei casi e dei modi nei quali la stessa può essere esercitata.
Linfa vitale viene data alla fattispecie processuale in rassegna dal nuovo articolo 127 disp. att. c.p.p. Il testo dell’indicata disposizione dedicata alla comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, deriva da due novazioni legislative: oltre che quest’ultima, di cui al decreto legislativo nr.31/2024 di attuazione della riforma Cartabia, ancor prima l’articolo 127 è stato oggetto di modifica ad opera della legge 24 novembre 2023, nr.168 in tema di femminicidio.
La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la Corte di appello i dati, di cui diremo in appresso, inerenti a taluni specifici procedimenti, mediante raggruppamento in distinti elenchi riepilogativi. Innanzitutto procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2 c.p.p. [3], salvo che il P.M. abbia formulato richiesta di differimento ex articolo 415-ter cpv. c.p.p. [4]. In tale ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell’elenco riepilogativo solo in caso di rigetto della richiesta.
Tra i procedimenti da raggruppare in distinti elenchi riepilogativi, vi sono poi i procedimenti nei quali il P.M. non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini fissati ai sensi dell’art.415-ter commi 4 e 5 c.p.p. [5]. Il procuratore generale presso la Corte di appello, ogni tre mesi acquisisce, dalle procure della Repubblica del distretto di cui è il capo, i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’art.362-bis c.p.p. [6], e invia al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.
Sciogliamo adesso la riserva sui dati che le procure della Repubblica devono trasmettere al procuratore generale posto a capo del distretto. Per ciascuno dei procedimenti or ora indicati la segreteria del pubblico ministero di primo grado deve comunicare al procuratore generale – alla sua segreteria particolare – le oggettività di dati che qui di seguito indichiamo:
le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
il luogo di residenza, dimora o domicilio, della persona sottoposta alle indagini;
le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
il luogo di residenza, dimora o domicilio, della persona offesa;
i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa coi relativi recapiti;
il reato per cui si procede con l’indicazione delle norme di legge, che si assumono violate, nonché, liddove risulti, la data e il luogo del fatto.
Da quanto si è venuto dicendo in ordine alla comunicazione al P.G. presso la Corte di appello, delle notitie criminis, ben si comprende di come l’articolo 127 disp. att. c.p.p. sia il volano o, se si preferisce, l’organo propulsore dell’intera vicenda avocativa, avendo quale fine ultimo l’accelerazione dell’iter procedimentale a fronte di stati di inerzia investigativa ingiustificati.
3. Il concordato
L’istituto epigrafato nel titolo è il frutto di una rigorosa azione novellatrice che il legislatore attuativo della riforma Cartabia ha esitato con l’approvazione dei nuovi articoli 598-bis e 599-bis del Codice di procedura penale. Gli istituti di neo conio afferiscono rispettivamente alle decisioni in Camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti e al cosiddetto concordato, anche con rinuncia ai motivi di appello. Le decisioni ex articolo 598-bis c.p.p. divengono dunque la regola nel giudizio di secondo grado. La Corte provvede sull’appello in Camera di consiglio.
Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto all’art.127 c.p.p. [7] essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie, senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla Camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza e, il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art.545 c.p.p. [8].
Fermo quanto previsto dall’art.597 c.p.p. [9] l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e sulle memorie suindicate, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con talune delle pene sostitutive di cui all’art.53 della legge 24 novembre 1981, nr.689.
La Corte se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la Corte fissa un’apposita udienza non oltre sessanta giorni dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’art.545-bis comma 2 c.p.p. [10]. In tal caso il processo è sospeso. Salvo che la Corte disponga altrimenti, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.
L’appellante e in ogni caso l’imputato o il suo difensore, possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale.
La richiesta è irrevocabile ed è presentata a pena di decadenza nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, di cui si è detto in sede introduttiva, ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello.
La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore, allorquando essa è ammissibile, la Corte dispone che l’udienza si svolga in forme partecipate indicando se il processo da appello sarà deciso a seguito di pubblica udienza o di procedimento camerale. Il provvedimento è comunicato al PG e notificato ai difensori. La Corte in ogni caso dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti allorquando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a mente dell’articolo 603 c.p.p.
La vera novità della fattispecie sulle decisioni in Camera di consiglio senza la partecipazione delle parti si rinviene nei disposti di cui ai commi 4-bis e 4-ter della norma processuale in commento. In estrema sintesi nei casi di udienza partecipata il consenso alla sostituzione della pena detentiva, ci cui si è detto in precedenza, può essere espresso fino alla data dell’udienza.
Allorquando è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la Corte allorché ritiene ricorrenti i presupposti sostituisce la pena medesima. Laddove necessita di essere acquisito il consenso dell’imputato la Corte, depositato il dispositivo nei modi indicati, assegna all’imputato il perentorio termine di quindici giorni per l’espressione del consenso fissando l’udienza non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso scatta la sospensione processuale; se il consenso è acquisito all’udienza la Corte integra il dispositivo, altrimenti lo conferma. Quando pur essendo acquisito il consenso non è possibile decidere immediatamente i termini per il deposito della motivazione decorrono ad ogni effetto di legge dal deposito del dispositivo confermato o integrato.
Non basta. Anche il concordato ex articolo 599-bis c.p.p. si pone in linea con le ragioni giustificatrici di fondo della riforma Cartabia. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accogliento in tutto o in parte dei motivi di appello con rinuncia agli atri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, di cui si è detto in precedenza, il pubblico ministero e le parti private indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo; dichiarazione e rinuncia sono presentate nel termine decadenziale di quindici giorni ante udienza.
Nell’ipotesi di pena sostitutiva della pena detentiva, si applicano le disposizioni di cui al su scrutinato articolo 598-bis c.p.p. ma il consenso dell’imputato è espresso a pena di decadenza nel termine di quindici giorni prima dell’udienza. Allorquando procede nelle forme delle decisioni camerali senza la partecipazione delle parti, la Corte se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste indicando se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in Camera di consiglio. Il provvedimento è comunicato al P.G. e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte in udienza.
Quando procede con udienza pubblica o camerale, quest’ultima con la partecipazione delle parti, la Corte se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti dispone la prosecuzione del giudizio. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la Corte decide in modo difforme dall’accordo.
Il procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero dell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 53 c.p.p. [11]
4. Conclusioni
La trama normativa testè tracciata vuole offrire conto dello strumentario acceleratorio, ed in un certo qualsenso garantista, che il legislatore del 2024 ha ritenuto di imprimere al sistema processuale penale vigente [12]. Questa l’ottica per il tramite della quale vanno letti gli istituti dell’avocazione, delle decisioni camerali in appello senza la partecipazione delle parti e soprattutto del concordato, anche con rinuncia ai motivi di appello ex art.599-bis c.p.p.
Note
- [1]
C.p.p. art. 127. Procedimento in camera di consiglio. 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità. 6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2
- [2]
C.p.p. art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale. 1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L’avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 5, primo periodo. 2. Il procuratore generale, può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 409, comma 3. 2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.
- [3]
C.p.p. art. 407-bis. Inizio dell’azione penale. Forme e termini. […] 2. Il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2.
- [4]
C.p.p. art. 415-ter. Scadenza dei termini per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa. […] 2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate: a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca; c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell’articolo 12 o collegati ai sensi dell’articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall’articolo 407-bis, comma 2. […].
- [5]
C.p.p. art. 415-ter. Scadenza dei termini per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa. […] 4. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L’istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, deve essere notificato l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell’avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. 5. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, il procuratore generale presso la corte d’appello, se non dispone l’avocazione delle indagini ai sensi dell’articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando: a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata; b) è stata già presentata l’istanza di cui al comma 4.
- [6]
C.p.p. art. 362-bis. Misure urgenti di protezione della persona offesa. 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all’articolo 575, nell’ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. 2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l’applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari. 3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria.
- [7]
Si veda la nota nr.1 cit.
- [8]
C.p.p. art. 545. Pubblicazione della sentenza. 1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.
- [9]
C.p.p. art. 597. Cognizione del giudice di appello. 1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. 2. Quando appellante è il pubblico ministero: a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge; b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata; c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza. 3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. 4. In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. 5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale.
- [10]
C.p.p. art. 545-bis. Condanna a pena sostitutiva. […] 2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria. […]
- [11]
C.p.p. art. 53. Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione. 1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.
- [12]
Sul novellato sistema di diritto processuale italiano vigente ci sia consentito far riferimento al nostro manoscritto in bozze di prossima pubblicazione su Gazzetta Forense dove offriamo conto nel più minuto dettaglio della legislazione in materia processuale penale adottata in Italia con gli ultimi interventi normativi:” Il sistema penale e l’ordine giudiziario 4.0; profili generali e linee di tendenza. Note in margine ai decreti correttivi della riforma Cartabia”, Giapeto, Napoli.



















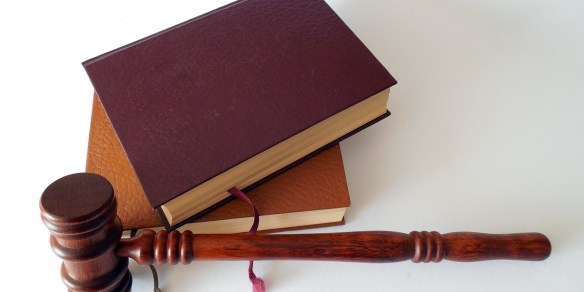


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento