Quando si esamina un contratto finanziario, si deve procedere prima di tutto ad un esame formale dei contratti, dopo di che procedere all’esame dei profili strettamente sostanziali che si posso semplificare in due: quello inerente la caratteristica del soggetto investitore; quello inerente la caratteristica del prodotto finanziario offerto e la relativa capacità di tale prodotto di raggiungere il fine promesso.
L’esame di tali profili potranno condurre il professionista a rilevare un vizio genetico del contratto da cui ne potrà derivare una nullità e dunque un mera ripetizione dell’indebito e del risarcimento danno per la mancata disponibilità del denaro investito, o una ipotesi di responsabilità contrattuale dalla quale potrà derivare un risarcimento danno.
Il contratto quadro
Il primo aspetto da prendere in considerazione è indubbiamente quello di verificare l’esistenza di un contratto quadro e la relativa sottoscrizione: dalla mancata sottoscrizione in forma scritta del contratto quadro deriva la nullità degli ordini di acquisto. Ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 23.07.1996 n. 415, riprodotto nell’ art.23 c. 1 D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
“La stipulazione del contratto quadro costituisce infatti, un necessario presupposto di validità dell’ordine, giacché gli obblighi informativi previsti dalla legge sono introdotti nel rapporto, ex art. 1374 c.c., mediante tale contratto, con la conseguenza che la mancata stipulazione in forma scritta del contratto quadro comporta la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa, giacché il contratto quadro costituisce il fondamento causale degli ordini impartiti dall’investitore all’intermediario finanziario i quali, pur se conclusi in forma scritta, sono nulli qualora non siano preceduti dalla stipulazione di un contratto quadro in forma scritta”[1] . L’obbligo di forma scritta[2] è altresì rinvenibile nell’art. 6 c. 1 lett. c) L. 1/1991 pertanto l’esistenza di un contratto quadro, non può essere provata per testi, presunzioni o confessione, né tramite documenti successivamente inviati nel corso del rapporto[3]; la mancanza del contratto quadro, inoltre non potrà essere sanata con successivo invio di documentazione all’investitore[4].
In effetti l’eventuale successivo sottoscrizione del contratto quadro non è in grado di sanare o convalidare un contratto nullo, sia che si tratti di contratto-quadro, che ordine di investimento poiché, come ha avuto modo di osservare parte della giurisprudenza di merito, la violazione va ben oltre il difetto di forma arrivando a violare norme imperative la cui ratio non può dirsi soddisfatta allorché il contratto quadro sopravvenga all’ordine di investimento[5].
Dall’art. 23 del TUF, si rileva inoltre la necessaria sottoscrizione di entrambe le parti negoziali[6], talché, la manifestazione di volontà di uno dei due contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell’altra parte, potendo la confessione supplire unicamente la carenza di forma ad probationem [7].
Sempre rimanendo alla forma del contratto, qualora la banca producesse una fotocopia del contratto quadro, in caso di disconoscimento di tale documento da parte dell’investitore, la banca, posta l’istanza di verificazione, potrà superare l’eccezione solamente producendo l’originale del contratto[8].
L’ art. 54 reg. Consob 5387/1991 prescrive che il termine minimo di cinque anni per la conservazione delle annotazioni relative alle operazioni effettuate, pur avendo natura amministrativa e dunque finalizzata a consentire l’attività ispettiva e di controllo delle autorità di vigilanza, non autorizza la distruzione della documentazione, laddove necessaria a provare l’avvenuta conclusione di un contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità: a nulla rileva, pertanto, l’impossibilità materiale per la banca convenuta in giudizio di produrre o fornire copia della documentazione relativa al contratto quadro di investimento che, dunque, deve essere dichiarato nullo[9].
In conclusione è utile ricordare la Cassazione civile, sez. II 05 febbraio 2013, n. 2736 – Pres. Oddo – Est. Giusti, che ha chiarito: Sebbene non sia tipizzato dal testo unico, il contratto di investimento si presta ad assurgere a forma giuridica di ogni investimento di natura finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u).
L’atipicità del contratto riflette la natura aperta ed atecnica di prodotto finanziario (come già evidenziato da questa Corte con riferimento alla disciplina recata dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, previgente art. 1: Sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10598), la quale, se da un lato costituisce la risposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, dall’altro risponde all’esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell’ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme innominate di prodotti finanziari.
Obbligo di informazione
Secondo la normativa in materia finanziaria, la banca è tenuta ad un duplice obbligo informativo di natura attiva e passiva.
Sotto il profilo attivo la banca ha l’obbligo di illustrare i rischi dell’operazione mentre sotto il profilo passivo, essa deve raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l’adeguatezza dell’operazione richiesta (in realtà sempre offerta) dal cliente.
In conseguenza di ciò, e a seguito di attenta valutazione da parte della banca, essa deve astenersi dall’eseguire le operazioni ove inadeguate per quel cliente: un caso ricorrente è dato dall’incongruenza tra la durata dell’investimento e l’età del risparmiatore.
La normativa in materia bancaria e finanziaria, pur qualificandosi come speciale, non resta estranea alla normativa generale della quale ne rappresenta una specificazione, per tale ragione occorre considerare sia le modalità di adempimento degli obblighi di cui al T.U.F. ed Reg. Consob, sia ai principi dettati dagli art. 1175 e 1375 c.c., correttezza professionale e buona fede che si dovrebbe esplicare da parte dell’intermediario con lo sconsigliare o addirittura impedire l’acquisto di proposti finanziari inadeguati al risparmiatore.
Una recente pronuncia delle S.U della Cassazione[10][11], ha chiarito che dal contratto quadro, cui può darsi il nome di contratto di intermediazione finanziaria, che la Cassazione stessa ha accostato alla figura del mandato, derivano obblighi e diritti reciproci dell’intermediario e del cliente.
Le operazioni che seguono al contratto quadro, quindi, e che l’intermediario compie per conto del cliente, pur essi da considerarsi atti di natura negoziale, costituiscono il momento attuativo del precedente contratto di intermediazione (contratto quadro appunto).
Come affermato dalla giurisprudenza appena citata, attiene alla fase pre-contrattuale l’obbligo di consegnare al cliente il documento informativo, ed attiene sempre a tale fase preliminare il dovere dell’intermediario di acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente, in modo tale da essere poi nelle condizioni di adeguare ad essa la successiva operatività. Si tratta di due concetti di derivazione anglosassone del c.d. divieto di churning e della c.d. suitability rule che impone all’intermediario di adottare tutte le cautele necessarie al fine di garantire l’adeguatezza della proposta finanziaria rispetto al profilo del cliente, e non solo[12].
Il divieto di churning e la c.d. suitability rule, rappresentano una garanzia nella formazione consapevole della volontà del soggetto che aderisce a determinate tipologie di contratti. In tal senso deve darsi altresì conto del contenuto della previsione di cui all’art. 29, l° co., del reg. CONSOB n. 11522, che impone agli intermediari di astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.
Dovere di informazione successivo alla stipulazione del contratto di intermediazione
I doveri d’informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto d’intermediazione in quanto finalizzati alla corretta esecuzione. In questa fase è dovere della banca di porre sempre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d’investimento o disinvestimento, nonchè di ogni altra circostanza necessaria a disporre con consapevolezza dette operazioni.
A fronte di ciò la banca deve comunicare per iscritto l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, come condizione per poter eseguire ugualmente l’operazione se autorizzata. Attengono poi al momento esecutivo i doveri di contenuto negativo posti a carico dell’intermediario vale a dire quelli di non consigliare e di non effettuare operazioni di frequenza o dimensione eccessiva rispetto alla situazione finanziaria del cliente.
Tale determinante requisito assume contenuti ancor più pregnanti allorquando si hanno di fronte risparmiatori di una certa età, età in cui è più difficile rendersi conto della complessità dell’investimento.
Così pure assume rilevanza la valutazione da parte delle principali agenzie di rating in merito al rischio di un determinato prodotto finanziario. Come correttamente osservato sia in dottrina che in giurisprudenza, il concetto di diligenza di cui all’art. 21, comma 1, lett. a) del TUF si riferisce alla “diligenza del buon professionista” e non a quella del “buon padre di famiglia”.
Pertanto, anche se non menzionata espressamente, la professionalità contrassegna la modalità di comportamento degli intermediari, precisando il significato della diligenza.
L’obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (art. 21, comma 1, lett. b) del TUF); l’obbligo di informarsi sulla situazione finanziaria dell’investitore, – c.d. know your customer rule – (art. 28, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob) e l’obbligo di astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione,- c.d. suitability rule – (art. 29, comma 1 del Regolamento Consob).
Grava indubbiamente sull’operatore l’obbligo di fornire al cliente indicazioni precise circa la pericolosità dell’investimento, anche con riguardo al rischio rimborso capitale, non potendosi ritenere assolto il dovere della banca sull’assolvimento degli obblighi suddetti, come naturale conseguenza della consegna all’investitore del c.d. documento sui rischi generali degli investimento in strumenti finanziari. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b) del regolamento Consob n. 11522/98, infatti, prima (…) dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento (…), gli intermediari autorizzati devono (…) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3[13].
Il documento in esame dovrebbe mettere l’investitore nelle condizioni di comprendere la natura e il grado di esposizione al rischio delle operazioni in strumenti finanziari.
Per raggiungere un obiettivo così ambizioso, la Consob, con un apprezzabile sforzo di semplificazione, sintetizza concetti complessi e sofisticati, (apparentemente) strumentali ad una miglior comprensione della dinamica delle operazioni nel mercato finanziario.
A titolo meramente esemplificativo, tramite il documento de quo, si insegna all’investitore neofita che il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico); inoltre, si mette in guardia lo stesso investitore del fatto che il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.
Ovvero che il rischio sistematico dei titoli di debito (…) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua (…).
È agevole comprendere come, nella maggior parte dei casi, l’investitore non professionale non abbia gli strumenti cognitivi per poter metabolizzare informazioni così complesse e, in particolare, per funzionalizzarle nell’elaborazione delle strategie di investimento.
“Rischio sistematico”, “rischio di cambio”, “divisa”, “opzioni di tipo americano” etc. sono termini che non appartengono al vocabolario dell’investitore comune, il quale, dinnanzi alla complessità attuale dell’ingegneria finanziaria, sente sempre più l’esigenza di investire nella fiducia della controparte, minimizzando i costi, soventi proibitivi, della “conoscenza”.L’obbligo dell’intermediario di consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari deve essere considerato esclusivamente come una delle tante tecniche utilizzate dall’ordinamento giuridico per colmare il gap informativo tra le parti; e non, quindi, come una “diabolica” presunzione di consapevolezza del risparmiatore. Siffatta chiave di lettura, accolta da una parte della giurisprudenza, conduce ad escludere che il mero rispetto da parte dell’intermediario dell’obbligo in questione trasformi – miracolosamente – il cliente non professionale in investitore consapevole, capace di tutelare da sé il proprio interesse e, in ultima analisi, in grado di assumersi i rischi dell’investimento compiuto.
L’adeguatezza
L’intermediario deve comunque assicurare all’investitore la propria assistenza e la propria guida nella scelta delle operazioni da compiere, anche al di là delle asettiche e standardizzate informazioni riportate nel documento.
In tale ottica viene in rilievo il concetto di adeguatezza delle informazioni che riecheggia all’art. all’art. 21, comma 1 lett. b) del TUF; il quale stabilisce, per l’appunto, che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli intermediari finanziari devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati in rapporto alle caratteristiche del risparmiatore.
Il concetto di adeguatezza delle informazioni, che trova la propria fonte nell’art. 11, punto 5 della direttiva n. 93/22/CEE, consente, infatti, a prescindere dalle aprioristiche specificazioni della Consob, valutazioni discrezionali circa la definizione degli obblighi informativi, rimesse in prima battuta all’intermediario e in secondo luogo all’interprete.
Vi è, quindi, spazio – anche in Italia – per un’interpretazione elastica della disciplina dell’informazione, in grado di evitare sia di circoscrivere l’informazione richiesta a quella prevista a livello regolamentare, sia di travolgere il cliente sotto un flusso magmatico e incontrollato di dati di ogni sorta, con conseguenti, inevitabili, effetti distorsivi.
In altri termini, il riferimento alle informazioni adeguate può essere utilizzato come strumento per rafforzare le regole informative previste a livello regolamentare e allo stesso tempo per attenuarne la rigidità.
Il concetto di adeguatezza costituisce infatti nel settore in esame l’anello di congiuntura con i principi generali, così che gli obblighi informativi possono far leva sul principio di buona fede oggettiva e di professionalità ed essere applicati con gradazioni e intensità diverse in tutte le fasi del rapporto tra le parti[14].
Il riferimento all’adeguatezza presuppone naturalmente che le informazioni debbano essere modellate dall’intermediario alla luce delle peculiarità del rapporto con il cliente, in guisa che, a seconda della controparte, l’operatore finanziario dovrà calibrare diversamente gli obblighi informativi, soddisfacendo le specifiche esigenze informative proprie del singolo rapporto.
L’obbligo dell’intermediario di mantenersi informato sulla situazione del cliente
Per orientamento delle Sezioni Unite, permane attuale durante l’intera fase esecutiva del rapporto, l’obbligo dell’intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi del cliente.
Tale obbligo si rinnova inoltre ogni qualvolta la natura o l’entità della singola operazione lo richieda in quanto la posizione del cliente deve essere vista sotto il profilo dinamico e non statico in quanto suscettibile di evolversi nel tempo.
E’ opinione di chi scrive che ogniqualvolta vengano prospettate violazione di doveri comportamentali che, in forza del contratto quadro e delle norme di settore, gravano sull’intermediario nell’esecuzione delle prestazioni alle quali egli è contrattualmente tenuto, possono ritenersi applicabili i generali principi in materia di responsabilità contrattuale, con la conseguente possibilità di pervenire, in presenza del presupposto di cui all’art. 1455 c.c. alla risoluzione del contratto per inadempimento oltre che al risarcimento del danno subito[15] finalizzato a consentire al contraente adempiente di conseguire la riparazione del pregiudizio patrimoniale non eliminabile attraverso le dovute restituzioni[16].
Per chi, come chi scrive, condivide la struttura bifasica di tale rapporto è ipotizzabile la risoluzione del contratto quadro, dal momento che gli obblighi di comportamento la cui violazione conduce al rimedio di cui all’art. 1453 ss. c.c. traggono origine da detto contratto perché, sebbene formalmente dettati da norme di legge o dal regolamento intermediario, sono pur sempre stati trasfusi in esso, o comunque sono divenuti parte integrante del regolamento contrattuale per via di integrazione ai sensi dell’art. 1374 c.c..
Ne consegue pertanto che la violazione dei predetti obblighi integri inadempimento del master agreement e ciò anche nel caso in cui tali standard di condotta siano funzionali alla conclusione dei contratti particolari o comunque delle operazioni di negoziazione attuative dei predetto contratto quadro[17].
Volume consigliato
Come difendere il contraente debole nel contenzioso bancarioQuesta nuovissima Opera è un’analisi operativa degli aspetti sostanziali e processuali della disciplina bancaria, alla luce della più recente giurisprudenza e delle ultime novità del settore sulla polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, il trattamento dell’usura sopravvenuta e la tutela della concorrenza e nullità contrattuale. Strumento indispensabile per il Professionista che deve affrontare le questioni più controverse, il testo esamina le fattispecie più comuni quali l’usura e l’anatocismo e quelle meno note ma di significativa importanza, in particolare i contratti di cessione del quinto, le clausole di chargeback, il prestito vitalizio ipotecario e il pegno mobiliare non possessorio.Il volume fornisce all’operatore del diritto, nella seconda e terza parte della trattazione, gli strumenti normativi ed operativi per una gestione efficace della controversia e per impostare la migliore strategia per la tutela del contraente debole in sede di giudizio, a partire dall’analisi del diritto bancario e diritto processuale bancario. Arricchisce la trattazione, l’accesso gratuito per 30 giorni alla piattaforma Diritto e Contenzioso Bancario DCB, il più innovativo strumento professionale per quanti operano in ambito bancario, una banca dati con news, pubblicazioni, normativa e giurisprudenza, che supporta il Professionista nella consultazione dei documenti e suggerisce i materiali collegati.Andrea Agnese, Avvocato in Milano con master in Giurista di Impresa. Andrea Agnese | 2018 Maggioli Editore 87.00 € 82.65 € |
Il conflitto di interesse
Come noto, l’art. 21, comma 1, lett. c) del TUF stabilisce che: Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono (…) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento.
Si tratta di una regola analoga a quella codificata a livello europeo nel documento del Committee of European Securities Regulators (noto come CESR) “Un regime europeo per la protezione dell’investitore: l’armonizzazione delle regole di condotta”[18].
Lo standard 5 stabilisce, infatti, che: Un’impresa di investimento deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché i conflitti di interesse tra la stessa ed i propri clienti siano identificati, e dunque eliminati o amministrati in modo tale da non pregiudicare l’interesse dei risparmiatori (…)[19].
Anche la Direttiva Europea del 21 aprile 2004, n. 39[20], che abroga la Direttiva 93/22/CEE, accoglie un’impostazione simile, cristallizzando definitivamente un orientamento di matrice anglo-americana[21], che si era da tempo imposto nel senso della International Organisation of Securities Commissions[22].
Regolamento n. 11522/98 “fa rientrare dalla finestra ciò che il legislatore ha fatto uscire dalla porta”.
In particolare il riferimento normativo è nell’art. 27, comma 2 del citato Regolamento il quale, per i servizi diversi dalla gestione di portafogli di investimento su base individuale, prevede che: gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione (…).
In altri termini, la Commissione introduce nuovamente nel nostro ordinamento giuridico la nota regola disclose or abstain, in base alla quale l’intermediario non deve operare nel caso di mero interesse nell’operazione (recte concorrenza), salvo espressa e specifica autorizzazione preventiva del cliente, messo a conoscenza della situazione.
Si tratta di una regola inefficiente, perché in un rapporto dinamico la verifica della natura e dell’estensione del conflitto e l’autorizzazione time by time incidono negativamente sull’esecuzione dell’incarico, oltre che formalista poiché l’investitore non sofisticato non avendo competenze specifiche nel settore finanziario non è comunque in grado di monitorare la “situazione”, e con l’escamotage del consenso-autorizzazione si accolla i costi di un’eventuale operazione potenzialmente dannosa, deresponsabilizzando l’operatore. Sul punto dunque non sembrano esserci dubbi.
In sintesi, a parere di chi scrive, il giudicante, dovrebbe applicare il principio della “supremazia del diritto comunitario”, sfuggendo dal neo-formalismo negoziale su cui si appunta, invece, la regolamentazione Consob ed accogliere un modello di gestione del conflitto che sposta la valutazione del comportamento dell’intermediario ex post, attraverso una difficile ma certamente più efficace analisi dell’”intenzione”[23].
In ordine al rilievo secondo cui l’istituto avrebbe comunque dovuto segnalare l’inadeguatezza dell’operazione ai sensi dell’art. 29 del regolamento sopra menzionato in applicazione della c.d. suitability rule, va preliminarmente osservato che l’intermediario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione anche ove i clienti abbiano rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28 I co. lett a) del regolamento Consob n. 11522/98 dovendo in tal caso tenere conto di tutte le informazioni comunque in suo possesso (ad esempio “età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato”: in tal senso vedasi comunicazione Consob n. DI/30396 del 21-4-2000 dettata in tema di trading on line): tanto si desume sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (cfr. artt. 1175 e 1176 II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) ma anche dal testo l’art. 29 del citato regolamento Consob che impone all’intermediario finanziario di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che lo stesso utilizzi ogni altra informazione disponibile anche diversa da quella fornita, ex art. 28 reg. cit., dai clienti, autorizzandolo solo in caso di conferma scritta dell’ordine d’acquisto a darvi (correttamente) esecuzione (la diversa regola contenuta nell’art. 19 co. V della direttiva europea 2004/39/CE del 21-4-2004 non può trovare applicazione al caso di specie sia ratione temporis sia perché le direttive non attuate – e purché ricorrano gli altri requisiti- non hanno efficacia nei rapporti interprivati: cfr. Cass. 25-2-2004 n. 3762; Corte Giust. CE 29-5-2004 n. 194).
Brevi considerazioni sul debito di valore
Con espressione « debito di valore » sono riscontrabile nella letteratura almeno due significati.
Il primo, decisamente complesso e articolato, si riferisce ai rapporti con il principio nominalistico e tipicamente è a sua volta scomponibile in due momenti: debito di valore quale obbligazione pecuniaria non soggetta alla disciplina dell’adempimento per il valore nominale; debito di valore quale obbligazione la cui prestazione pecuniaria è determinata e quindi dovuta in funzione del potere d’acquisto della moneta, anziché del suo valore nominale.
Il secondo significato è invece conseguenza della singolare “eterogenesi dei fini” [24] la cui ricostruzione dogmatica, si è evoluta nella direzione volta a sottrarre determinate ipotesi di obbligazione pecuniaria dall’ambito del principio nominalistico, significato adottato ben presto come fondamento teorico di una particolare tecnica di liquidazione del danno. In questa prospettiva, la locuzione « debito di valore » è intesa — in particolare dalla giurisprudenza — come espressione brachilogica di un modello per la liquidazione del danno.
Come si vede, i due significati sono fra loro affatto eterogenei, ora attingendo alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie, ora invece volgendosi all’oggetto del debito risarcitorio.
Partendo dall’esame della locuzione che prende a riferimento il principio nominalistico, subito si osserva che il debito di valore con l’obbligazione pecuniaria non soggetta alla regola del valore nominale — spesso ricorrente nella nostra giurisprudenza [25] — assume contorni indeterminati [26]: si tratta dunque di una nozione fondata sull’elemento negativo dell’estraneità al precetto dell’art. 1277, co. 1, c.c. [27] che confondela fattispecie con l’effetto.
Pare oramai evidente la limitata applicabilità del principio nominalistico. Invero l’affermazione di una categoria di obbligazioni pecuniarie estranee alla regola del valore nominale induce a metterne in discussione l’estensione, sollevando il problema sull’effettiva portata di una norma scorta — ora in modo esplicito esplicite [28], ora indirettamente [29]— come destinata a regolare in modo onnicomprensivo l’adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro.
Dal momento che esiste una pluralità di ipotesi, in cui il criterio di quantificazione della prestazione pecuniaria dovuta risulta differente da quello nominalistico, è utile, procedere una disamina delle disposizioni dalle quali poter trarre dei riferimenti.
Le fattispecie in questione — riconducibili nella loro varietà all’espressione sintetica l’art. 59 l. fall.: « crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori » — trovano la loro naturale collocazione nella norma dell’art. 1278 c.c., sul debito espresso in moneta non avente corso legale nello Stato; fuori dell’ambito codicistico si trovano, poi, analoghe norme quali gli artt. 47 l. camb. e 39 l. ass., nonché, ove richiamate nel titolo dell’obbligazione, dell’art. 6.1.9. Unidroit Principles of International Commercial Contracts e dell’art. 7:108 Principles of European Contract Law).
La previsione di cui all’art. 1278 c.c. in virtù del quale il debito può essere adempiuto con moneta legale « al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento», crea uno spartiacque rispetto al principio espresso dall’art. 1277 da cui si desume la regola del valore nominale, che, al contrario, presuppone la determinazione dell’importo dovuto in un momento anteriore a quello stabilito per il pagamento.
Analoghe disposizioni sono riscontrabili in altri luoghi del codice civile.
Senza pretesa di completezza si può far menzione:
- a) norme dettate in materia di debiti da rimborso da soddisfare mediante corresponsione di denaro (artt. 975, co. 1 e 3; 985, co. 1 e 2; 1150, co. 2 e 3; 1592, co. 1, c.c., in tema di miglioramenti e addizioni in favore, rispettivamente, dell’enfiteuta, dell’usufruttuario, del possessore di buona fede e del conduttore);
- b) norme relative a obbligazioni nelle quali il pagamento di una somma è alternativo alla restituzione in natura (artt. 995, co. 2; 1640, 1645, co. 1, 1818 c.c., in materia di prestazioni dovute, rispettivamente, al concedente del quasi usufrutto, al locatore, che abbia concesso in affitto un fondo rustico dotato di scorte morte o bestiame, e al mutuante);
- c) infine norme come gli artt. 563, co. 3 (sulla prestazione dovuta al legittimario dal terzo avente causa da acquirenti soggetti a azione di riduzione); 948, co. 1 (in materia di pagamento al proprietario rivendicante da parte del convenuto che dolo desiit possidere) [30], e 2037, co. 2, c.c. (sulla prestazione dovuta dall’accipiens di mala fede nel caso di perimento della cosa indebitamente ricevuta) [31].
Nell’ordinamento sono poi rinvenibili obbligazioni pecuniarie per cui, il principio nominalistico, viene a collidere con le disposizioni che la legge prevede per la prestazione necessaria all’esatto adempimento.
Il caso più evidente è rinvenibile nell’obbligazione alimentare da eseguire a mezzo di assegno (art. 443, co. 1, c.c.). La regola nominalistica, per cui l’importo dovuto al creditore al tempo del pagamento risulta identico a quello stabilito nel momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio, contrasta con la previsione ex art. 438, co. 2, c.c., che, al contrario, fissa nel bisogno di chi domanda gli alimenti e nelle « condizioni economiche di chi deve somministrarli» i parametri per la determinazione della somma dovuta al creditore: l’affermazione, quindi, del principio nominalistico come regola delle obbligazioni pecuniarie, scaricherebbe sull’alimentando il rischio connesso alle oscillazioni del potere d’acquisto della moneta, originando una disparità di trattamento, rispetto alla diversa ipotesi di adempimento dell’obbligo alimentare mediante accoglienza e mantenimento nella propria casa, che contraddice l’equivalenza fra i due modi di somministrazione degli alimenti normativamente sancita dall’art. 443, co. 1, c.c.
Considerazioni simili — seppur in assenza di una norma che esplicitamente individui l’oggetto dell’obbligazione — valgono, per il debito risarcitorio, rispetto al quale la necessità che la prestazione dovuta dal debitore ristori in modo il più possibile integrale il patrimonio del danneggiato è sempre stata percepita non rispondente ai principi generali in materia di danno, risultando nel contempo palesi le difformità di risultato che dall’eventuale applicazione del principio nominalistico sarebbero potute derivare [31]. Sicché si può sinteticamente osservare come in entrambi i casi (debito alimentare e debito risarcitorio) ci si trovi di fronte alla sovrapposizione di due norme nella disciplina di un’identica fattispecie: conflitto che indicazioni di teoria generale [32] suggeriscono di risolvere a livello interpretativo attraverso la limitazione dell’ambito di una fra le disposizioni coinvolte [33], nel caso di specie agevolmente identificabile con la previsione codicistica che pone il principio nominalistico.
Anche in questa prospettiva, pertanto, esistono obbligazioni pecuniarie alle quali l’art. 1277, co. 1, c.c. non si applica.
Da condividere, l’orientamento dottrinale secondo cui « il principio del valore nominale trova il suo presupposto nella determinazione quantitativa dell’oggetto della prestazione nei termini di una unità legale di misura monetaria », tale dovendosi considerare « l’ipotesi alla quale si fa capo nei debiti aventi per oggetto la prestazione di una determinata quantità di pezzi monetari senz’altra indicazione fuorché quella della loro appartenenza a un determinato ordinamento monetario » [34].
Quanto dedotto da Ascarelli, mette consente di delimitare gli spazi di operabilità del principio nominalistico: da un lato, è necessaria la determinazione della prestazione monetaria dovuta in un momento anteriore a quello stabilito per il pagamento; dall’altro, una quantificazione operata con esclusivo riferimento alla moneta legale, senza alcuna connessione con parametri destinati a variare nel periodo compreso fra la determinazione della prestazione monetaria e la sua esecuzione [35].
Al di fuori dei limiti enunciati, non può trovare applicazione una regola che stabilisce l’identità nel tempo della somma dovuta: se la prestazione è determinata all’epoca del pagamento o fino a questo momento essa è stabilita in riferimento ad un parametro variabile, un importo nominale destinato a rimanere immutato non è infatti logicamente ipotizzabile.
L’obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico può essere pertanto identificata con quella che ha per oggetto una prestazione monetaria liquida, ovvero la prestazione espressa in un importo nominale determinato in un momento anteriore a quello stabilito per il pagamento e con riferimento esclusivo all’unità monetaria di conto [36].
Il debito di valore è, dunque, un’obbligazione pecuniaria nella quale la prestazione è determinata in funzione del potere d’acquisto della moneta, anziché del suo valore nominale .
La questione, di origine prettamente dottrinale, tenta di costruire una categoria di obbligazioni pecuniarie contrapposta a quella dei debiti di denaro assoggettati al principio nominalistico, trova il suo autore in Ascarelli che nel corso di oltre un trentennio ha elaborato una costruzione dogmatica, di un debito pecuniario disciplinato da una regola valorista, molto dibattuta, seppur adottata (o meglio rapita) dalla giurisprudenza.
Nella formulazione definitiva della teoria ascarelliana, il debito di valore è un’obbligazione pecuniaria in senso proprio, in cui la « misurazione quantitativa della prestazione generica » avviene mediante il criterio del « potere patrimoniale astratto » (valore), giustificandosi il riferimento a tale criterio « nel contrasto che altrimenti si verificherebbe tra la natura dell’istituto e l’addossamento al creditore di rischi e vantaggi delle oscillazioni del potere d’acquisto della moneta quale invece ha luogo con qualunque altro criterio di determinazione della quantità della prestazione » [37].
Al pari delle obbligazioni pecuniarie regolate dal principio nominalistico, i debiti di valore sono determinati in una somma di denaro in un momento anteriore a quello stabilito per l’adempimento, non essendo anzi configurabili in assenza di una distinzione temporale fra individuazione (aestimatio) e liquidazione (taxatio) dell’importo dovuto[38].
La dottrina dei debiti di valore « fa capo alla distinzione fra due momenti (rispettivamente per la valutazione e per la liquidazione) e fa capo a questa distinzione proprio perché rifiuta la premessa implicita della dottrina tradizionale », secondo cui « un’espressione monetaria debba perciò stesso sempre intendersi come indicativa di un multiplo di un’unità di misura, e mai come indicativa di un potere d’acquisto »; pertanto « la dottrina dei debiti di valore vuole appunto commisurare (nelle ipotesi all’uopo identificabili) in un ‘‘valore’’ astratto quanto poi deve esser liquidato », distinguendo « espressioni monetarie che indichino un valore astratto e che perciò dovranno considerarsi identiche nel tempo solo in quanto ne continui identica la corrispondenza al potere d’acquisto originario e espressioni monetarie invece svincolate dalla persistenza della loro corrispondenza ad un determinato valore astratto » [39].
Il debito di valore costituisce quindi, un modello di liquidazione del danno.[40]
Tale conclusione, costituisce l’esito estremo del processo con cui la giurisprudenza ha recepito il modello dottrinale di cui si è trattato in un contesto generale in cui:
- a) le preoccupazioni sistematiche sono abbandonate in favore di un approccio casistico e spesso empirico [41] (al punto che la nozione di debito di valore, svuotata di ogni contenuto dogmatico, finisce in sostanza per ridursi a semplice medio logico per la rivalutazione della prestazione monetaria dovuta) e nel quale,
- b) i criteri formali impiegati per l’identificazione del debito di valore sono già detto detto [42], « estrinseci e periferici » rispetto alla reale individuazione dei parametri di riferimento, alla prassi giurisprudenziale non è stato necessario molto per trasformare il debito di valore da categoria di teoria generale dell’obbligazione pecuniaria in modello di liquidazione del danno patrimoniale.
Tale processo è avvenuta secondo un triplice profilo:
- prestazione tradotta in termini monetari in un momento anteriore alla liquidazione giudiziale e successivamente rivalutata, metodo esteso a qualsiasi debito risarcitorio in contraddizione con il rilievo secondo cui « nell’ipotesi di danni concretizzatisi nella perdita o nel danneggiamento di cose occorre far capo al prezzo al momento della sentenza » [43] e non, invece, alle oscillazioni del generale potere d’acquisto della moneta).
- Superamento da parte della giurisprudenza delle precisazioni dottrinali [44] dirette a distinguere i singoli momenti in cui procedere all’aestimatio della prestazione dovuta (in relazione al danno da risoluzione, alla perdita di reddito o al lucro cessante), per accedere a un modello che in modo generalizzato determina il pregiudizio risarcibile nel momento in cui l’evento dannoso si è verificato.
- Aggiunta, alla somma così quantificata, di un ulteriore importo, gli interessi «compensativi » volti a ristorare il danneggiato del pregiudizio patrimoniale patito fra il momento dell’evento lesivo e la determinazione giudiziale del risarcimento. Si è quindi delineato un procedimento di liquidazione del danno, applicabile indistintamente e articolato in tre momenti: quantificazione dell’importo dovuto con riferimento al tempo in cui si è verificato l’evento dannoso, rivalutazione all’epoca della liquidazione, aggiunta di interessi sul capitale così determinato, ferma in tal caso la possibilità di variare equitativamente il capitale di riferimento e il tasso di interesse [45].
Tralasciando la questione relativa alla assenza di un fondamento normativo che giustifichi l’automatica rivalutazione delle somme dovute è ora utile il carattere forfettario che il modello giurisprudenziale ha finito per attribuire alla liquidazione del danno.
La questione è particolarmente evidente nell’ipotesi in cui il pregiudizio patrimoniale da risarcire sia identificabile nella distruzione — fisica o economica [46] — di un bene ovvero nel suo mancato conseguimento
Quest’ultima ipotesi, infatti, accanto all’arbitraria distinzione fra momento della determinazione e momento di liquidazione del danno [47], il modus procedendi delle Corti è il seguente:
- a) sostituzione del saggio medio di inflazione al parametro di inflazione (o deflazione) proprio del bene danneggiato [48] e
- b) mancata valutazione del deterioramento che il bene avrebbe subito in ragione del suo uso, uso di cui occorre, invece, tener conto dal momento che l’attribuzione di interessi « compensativi » si giustifica propriamente in considerazione dell’impiego che il danneggiato avrebbe fatto del bene se questo non fosse stato distrutto [49].
Il carattere forfettario della liquidazione persiste — se pur in modo assai più modesto — anche nell’ipotesi di generica diminuzione patrimoniale. In effetti, nell’ipotesi di danno contrattuale, la rivalutazione automatica della somma contrasta con il limite della prevedibilità, addossando integralmente al danneggiante il rischio delle oscillazioni monetarie, con rilevanti conseguenze qualora nel periodo compreso fra l’evento dannoso e la liquidazione definitiva si verifichino improvvisi picchi inflazionistici.
Qualche affinamento sembra parimenti consentito dalla seconda componente del modello giurisprudenziale del debito di valore, relativa alla corresponsione degli interessi « compensativi ».
La materia, ha peraltro già ricevuto un decisivo contributo di chiarificazione dogmatica con l’intervento delle Sezioni unite del 1995 [50], affermando che l’attribuzione degli interessi costituisce uno strumento a cui il giudice può ricorrere nella liquidazione equitativa del danno da ritardato adempimento dell’obbligo risarcitorio. Con ciò, la Corte di legittimità, ha infatti posto fine a un’ambiguità protrattasi per molto tempo in ordine alla natura di tali somme: non prestazioni riconducibili alle tipologie di interessi disciplinate dal codice, quanto piuttosto « uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per risarcire il danneggiato » del pregiudizio patito « nel tempo intercorso tra la consumazione dell’illecito e la liquidazione del danno» [51], come tali soggette alla disciplina del risarcimento. Solo l’allegazione e la prova del danno consentono — nella nuova impostazione — il conseguimento degli interessi « compensativi»: è dunque, definitivamente superato risulta il più eclatante vizio del modello precedente che finiva — mediante l’equivoco riferimento agli interessi — per riconoscere il risarcimento anche in assenza di domanda o prova da parte del danneggiato [52].
Il risarcimento deve porre il danneggiato nella medesima posizione ove egli si sarebbe trovato in assenza del fatto lesivo, possa così essere riformulato nella terminologia della microeconomia: la prestazione risarcitoria deve ristabilire il danneggiato sulla medesima curva di indifferenza in cui egli si trovava prima dell’evento dannoso.
In presenza di un intervallo temporale (e nella specie: quando il momento dell’evento dannoso differisce da quello della liquidazione) occorre tuttavia precisare che l’indifferenza fra due situazioni risulta possibile solo in quanto essa venga espressa in funzione di quello che gli economisti chiamano « saggio di sostituzione intertemporale ».
Esprimendo in termini formali quello che è sempre stato intuito dalla tradizionale posizione giurisprudenziale secondo cui rivalutazione e interessi assolvono, nei debiti di valore, due funzioni differenti, si può pertanto affermare che l’indifferenza fra i valori nel tempo dipende dalla somma fra il tasso di inflazione p e il saggio di sostituzione intertemporale r, somma denominata « tasso di interesse nominale » (« I »), così che
I = p + r
Chiarito quindi che, in presenza di un intervallo temporale, l’indifferenza nella disponibilità di un bene (o di una somma di denaro) risulta dipendere dal tasso di interesse nominale, si può affermare che, per porre il danneggiato nella stessa posizione in cui egli si sarebbe trovato se l’evento lesivo non si fosse verificato, occorre:
- a) stimare l’ammontare del pregiudizio patrimoniale all’epoca dell’evento dannoso e
- b) aumentare l’importo così determinato dell’ulteriore somma che risulta applicando il tasso di interesse nominale per il periodo compreso fra il momento in cui il danno si è verificato e quello in cui la prestazione viene liquidata.
Emergono tuttavia elementi di contrasto.
In primo luogo: individuare come capitale di riferimento l’importo rivalutato, anziché quello stimato all’epoca dell’evento dannoso, comporta un aumento della base di computo cui applicare l’interesse nominale.
In secondo luogo , poiché per l’esplicita lettera dell’art. 1284, co. 1, c.c. il tasso legale di interesse comprende tanto il saggio di sostituzione intertemporale (sub specie di « rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ») quanto il tasso di inflazione (dovendo il decreto ministeriale fissare il tasso annuo « tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno » precedente), il modello giurisprudenziale — nei limiti in cui lascia aperta la possibilità di identificare il saggio di sostituzione intertemporale r con il tasso legale e, nel contempo, rivaluta l’importo nel periodo compreso fra evento dannoso e liquidazione — determina un arricchimento del danneggiato, pari alla componente del tasso legale destinata a coprire il sopravvenuto diminuito potere d’acquisto della moneta [53].
In tema di danno da distruzione o mancato conseguimento di un bene il problema risulta decisamente facilitato dalla previsione dell’art. 2058, co. 1, c.c.: dal momento che, normalmente, i beni presentano un valore d’uso per il loro titolare e formano oggetto di un mercato, la regola più elementare pare essere quella che —individua la somma dovuta al danneggiato nel « prezzo di sostituzione, quale risulta all’epoca della liquidazione e nel luogo in cui la vittima utilizzava il bene. Tale criterio subisce tuttavia alcuni temperamenti:
- a) nel caso in cui la sostituzione del bene comporti transaction costs particolarmente elevati [54], la previsione dell’art. 2058, co. 2, c.c. consente, infatti, al giudice di determinare la prestazione risarcitoria secondo criteri diversi dal costo di sostituzione;
- b) in virtù dell’art. 1227, co. 1, c.c., il danneggiato non può godere di un eventuale aumento dei prezzi correlato al suo indugio nell’agire ;
- c) nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, in presenza di un imprevedibile aumento dei prezzi l’art. 1225 c.c. esclude l’immediata riferibilità al costo di sostituzione, salvo il limite del dolo del debitore [55].
Quanto invece al pregiudizio patrimoniale consistente nella perdita o nel mancato acquisto di denaro, la prassi giurisprudenziale di automatica rivalutazione pare potersi più saldamente fondare come semplice conseguenza della regola per cui il risarcimento deve porre il danneggiato nella stessa situazione in cui egli si sarebbe trovato se il fatto lesivo non si fosse verificato.
Si consideri, in proposito, la residuale destinazione del denaro al consumo: il pregiudizio risarcibile risulta « pari alla maggior somma mediamente necessaria, tenuto conto degli aumenti di prezzo dei beni e dei servizi, a realizzare, in tempi diversi, la stessa utilità » [56], sicché per la sua compensazione basta adeguare la somma perduta o non conseguita in ragione del diminuito potere d’acquisto della moneta medio tempore intervenuto [57]: fermo — stante la vigenza dei principi generali in materia di risarcimento — il limite dell’imprevedibile entità dell’inflazione nei casi in cui l’art. 1225 c.c. trovi applicazione[58].
Si può peraltro ipotizzare che le somme perdute o non conseguite sarebbero state destinate a forme di investimento dalla redditività superiore al tasso di inflazione: in tal caso il problema risulta tuttavia interferire con quello degli interessi « compensativi», sicché quest’ultimo pare il contesto più adeguato per lo svolgimento della relativa trattazione.
Per il pregiudizio patrimoniale da distruzione o mancato conseguimento di un bene, la ricostruzione dogmatica si incentra sulla considerazione che, nel periodo compreso fra il fatto generatore di responsabilità e la liquidazione del danno, un pregiudizio patrimoniale può ritenersi normalmente ricorrere quando il bene presenti valore d’uso: pertanto, la dimostrazione dell’indisponibilità del bene e del suo valore d’uso bastano per considerare esistente il pregiudizio patrimoniale e, dunque, consentire il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Sulla base di queste premesse, il suggerimento tradizionale di ricorrere al mezzo tecnico degli interessi risulta del tutto condivisibile, configurando, appunto, una modalità per la liquidazione equitativa del danno. Ciò posto, rimane peraltro da precisare il criterio con cui determinare il capitale di riferimento e il tasso di interesse applicabile, potendosi a tal fine ricorrere alla nozione di interesse nominale.
In particolare:
- a) la considerazione che l’interesse nominale si applica all’importo del danno quantificato al momento dell’evento dannoso induce, anzitutto, a computare gli interessi sul costo di sostituzione determinato con riferimento a quest’ultimo momento (e non invece, come avviene nel modello giurisprudenziale, su tale somma progressivamente rivalutata). In termini matematici si può affermare che D = C (1 + I), dove D è la prestazione risarcitoria, C il costo di sostituzione all’epoca del danno e I il tasso di interesse nominale. Ricordando che I = p + r, dove p è il tasso di inflazione ed r il saggio di sostituzione intertemporale, l’equazione precedente può allora essere così riformulata: D = C (1 + p + r) = C + Cp + Cr. Ora, poichè il costo di sostituzione al tempo della liquidazione è pari al costo di sostituzione all’epoca dell’evento dannoso maggiorato in relazione al tasso di inflazione e dunque a C + Cp, una volta che questo sia stato attribuito la prestazione risarcitoria risulta completa attraverso l’attribuzione di Cr, vale a dire del costo di sostituzione all’epoca dell’evento dannoso moltiplicato per il saggio di sostituzione intertemporale.;
- b) la presenza del saggio di sostituzione temporale come componente dell’interesse nominale, suggerisce di parametrare a quest’ultimo (e dunque al valore d’uso del bene) l’entità del tasso di interesse concretamente applicabile [59], con l’ovvia conseguenza che quando il saggio di sostituzione intertemporale risulti essere pari a zero (= quando il bene non abbia valore d’uso) non è dovuta alcuna prestazione di interessi.
Trattando adesso il pregiudizio consistente nella perdita o nel mancato acquisto di una somma di denaro, in via preliminare — e sulla scorta di quest’ultima osservazione — si può anzitutto rilevare come un danno da mancata disponibilità eccedente quello « coperto » dalla rivalutazione possa essere teoricamente configurato solo qualora il denaro perduto o non conseguito fosse destinato al risparmio o all’investimento: nulla invece è dovuto ove la somma fosse destinata al consumo, giacché in presenza di un utilizzo immediato attraverso il consumo un problema di preferenze temporali neppure si pone, sicché il saggio di sostituzione intertemporale risulta essere pari a zero.
A questa stregua si comprende pertanto come l’esistenza di un danno da mancata disponibilità può dirsi provata solo dimostrando la destinazione del denaro all’investimento o al risparmio (ovvero provando il ricorso al credito bancario reso necessario dell’evento dannoso): in mancanza, al danneggiato sembra doversi riconoscere unicamente la rivalutazione delle somme perdute o non conseguite, secondo i rilievi svolti in precedenza. Infatti, l’equivalenza nel tempo dei valori (e, per eccellenza, di una somma di denaro) risulta espressa in funzione del tasso di interesse nominale, in termini matematici la prestazione risarcitoria risulta pari a D = S (1 + I) dove D è la prestazione risarcitoria, S la somma perduta o non conseguita e I il tasso di interesse nominale. Si ricorda che I = p + r, dove p è il tasso di inflazione ed r il saggio di sostituzione intertemporale, qualora il denaro sia destinato al consumo ed il saggio di sostituzione r sia pertanto pari a zero, il tasso di interesse nominale è pari a: I = p + r = p + 0 = p. A questa stregua D = S (1 + p), equazione quest’ultima che coincide perfettamente con la formula utilizzata per la mera rivalutazione delle somme.
Come sempre in materia di pregiudizi patrimoniali consistenti nella perdita nel mancato acquisto di una somma di denaro, in questi termini il problema sostanziale finisce allora per spostarsi « inevitabilmente sul terreno della prova », dove notoriamente le difficoltà non mancano:
secondo il rilievo frequentemente avanzato in dottrina con riferimento alle « griglie presuntive » utilizzate dalla Corte Suprema in tema di danni da inadempimento di un’obbligazione pecuniaria [60], non esistono infatti soggetti che siano esclusivamente consumatori, risparmiatori o investitori,
« giacché nella realtà si confondono e si intrecciano in capo ai medesimi soggetti caratteristiche ascrivibili a più di una categoria » [61].
La corresponsione di interessi a titolo di danno da mancata disponibilità della somma perduta o non conseguita rimane pertanto subordinata alla prova indiziaria (soprattutto attraverso il riferimento a qualità personali e prassi precedente) della destinazione del denaro all’investimento o al risparmio. In tal caso, il tasso a cui commisurare gli interessi (= il saggio di sostituzione intertemporale r) risulta pari alla differenza fra il tasso di inflazione ed il rendimento che nel singolo caso il denaro avrebbe prodotto.
Note
[1] Trib Torino n. 7737/08 del 24.11.2008. In tal senso Trib Cagliari 18.01.2007
[2] Cass. 10598/2005.
[3] Appello Bologna 14 maggio 2015
[4] Cass. 7283/2013
[5] Tribunale Verbania 23 luglio 2015
[6] Tribunale Firenze 31 maggio 2013
[7] Tribunale Reggio Emilia 16 settembre 2013
[8] Tribunale Terni 17 novembre 2014
[9] Tribunale Torino 25 giugno 2014
[10] Cass. S.U. 19.12.2007 nn. 26724 In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
[11] Cass. S.U. 19.12.2007 nn. 26724 La violazione dei doveri di informazione del cliente che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazione riguardante le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria.
[12] In tale direzione sono andate le comunicazioni CONSOB n. DI/98080595 del 14 ottobre 1998 e n. 98088209 del 1 novembre 1998, con cui la Commissione ha individuato, nella valutazione di adeguatezza delle operazioni, alla luce del complesso di informazioni date al cliente e dallo stesso ricevute, un «momento essenziale» nello svolgimento diligente e corretto dei servizi di investimento nei confronti degli investitori.
[13] La consegna del documento deve precedere l’avvio della prestazione dei servizi e non, di contro, la stipulazione di ogni singolo contratto; in altri termini, se un medesimo cliente stipula, nel corso del tempo, con lo stesso intermediario diversi contratti, la consegna del c.d. risk disclosure statement deve avvenire prima dell’inizio della prestazione relativa al primo contratto e non deve – necessariamente – essere reiterata.
[14] Sul punto è interessante richiamare un passo particolarmente significativo delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia (tit. X, cap. I, sez. I). Sebbene, infatti, il documento si riferisca alla normativa in tema di trasparenza bancaria, le stesse conclusioni possono essere ripetute mutatis mutandis in subjecta materia. “La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari persegue l’obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, quale mezzo di promozione e salvaguardia del regolare esplicarsi della concorrenza nei mercati bancari e finanziari nonché di tutela dei “contraenti deboli”, senza limitare sostanzialmente l’autonomia negoziale delle parti del rapporto. (…) La disciplina sulla trasparenza stabilisce principi e regole minimali. Essa diviene strumento efficace di concorrenza e di tutela della clientela col concorso di un comportamento degli operatori informato al corretto svolgimento dei rapporti con la clientela. A tal fine non è sufficiente, soprattutto nei confronti della clientela meno consapevole, la formale adesione alle prescrizioni normative, ma occorre il rispetto di regole deontologiche fondate su criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. Questo comportamento, connaturato al carattere fiduciario del rapporto banca-cliente, consente nel lungo termine alla banca di fronteggiare le sollecitazioni provenienti dalla concorrenza e di rafforzare il grado di fidelizzazione della clientela, con benefici per la banca in termini di reputazione sul mercato”.
[15] Cass. S.U. 19.12.2007 n.26724; Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26725; Trib. Milano 24.09.2008 n. 11247; Trib. Forlì 10.06.2008 n. 544; Trib. Monza 4.06.2008 n. 1649; Trib. Chiavari 3.03.2008 n. 121; Trib Ancona 20.02.2008 n. 246; Trib. Benevento 6.02.2008 n. 47; Trib. Parma 22.01.2008 n. 120; Trib. Forlì 16.01.2008 n. 47; Trib. Rovigo 16.01.2008 n. 25 Trib. Parma 9.01.2008 n. 6; Trib. Livorno 21.11.2007 n. 1180; Trib. Alba 5.10.2007 n. 417; App. Brescia 24.09.2007 n. 739; App. Torini 30.07.2007 n. 1245; Trib. Napoli 19.07.2007 n. 8362; Trib. Milano 10.07.2007 n. 8602; Trib. Firenza 6.07.2007 n. 2970; Trib Oristano 12.06.2007 n. 268; Trib Ivrea 6.06.2007 n. 310; Trib Rimini 6.06.2007 n.564; Trib. Venezia 30.05.2007 n. 1114; Trib. Parma 24.05.2007 n. 696; Trib. Chiavari 17.05.2007 n. 268; Trib. Prato11.05.2007 n. 395; Trib Milano 18.04.2007 n.4680; Trib. Catania 8.02.2007 n.518; Trib. Lodi 12.01.2007 n. 54.
[16] Cass. S.U. 4.12.1992 n. 12942.
[17] Cass. S.U. 19.12.2007 n.26724; Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26725; Trib Ferrara 28.09.2007; Trib Firenze 6.07.2007 n. 2970; Trib Firenze 23.10.2006 n. 3778; Trib Firenze 21.06.2006 n. 2419.
[18] Il documento è scaricabile all’indirizzo web del CESR: http://www.europefesco.org; cfr. anche il documento integrativo “A European Regime of Investor Protection. The Professional and the Counterparty Regimes”, luglio 2002, (Ref. CESR/02-098b).
[19] AA.VV., Capital Market in the Age of the Euro – Cross Border Transactions, Listed Companies and Regulation, Ferrarini, Hopt, Wymeersch (Editors), Dordrecht, 2002
[20] Cfr. in particolare, l’art. 18. Come si legge nella relazione accompagnatoria alla direttiva: “Qualora l’impresa abbia tentato di gestire i conflitti di interesse predisponendo meccanismi organizzativi senza però riuscire ad acquisire la ragionevole certeza che questi conflitti non presentino più alcun pregiudizio potenziale per gli interessi dei clienti, l’impresa è tenuta ad informare il cliente dell’esistenza di conflitti di interesse residui. Se opportuno o necessario, la comunicazione al cliente può avere cartattere generale”.
[21] In materia, cfr. F. ANNUNZIATA, Regole di comportamento degli intermediari e riforme dei mercati mobiliari, Milano, 1993, pagg. 127 e ss.; M. GRAZIADEI, Diritti nell’interesse altrui- Undisclosed agency e trust nell’esperienza giuridica inglese, Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche, Trento, 1995, pagg. 352 e ss.; AA.VV., Encyclopedia of Financial Services Law, Lomnicka, Powell (a cura di), I-IV, London, 1987.
[22] Sul punto, i principi IOSCO stabiliscono che “Un intermediario deve cercare di evitare l’insorgere di qualsiasi conflitto di interessi, ma qualora ciò non sia possibile deve assicurare a tutti i clienti un trattamento equo, mediante una adeguata informazione, attraverso regole organizzative interne e, financo, evitando di operare qualora il conflitto non possa essere neutralizzato. In ogni caso l’intermediario non deve mai anteporre il proprio interesse a quello dei clienti”.
[23] Tribunale di Mantova 18 marzo 2004.
[24] Andrea Perrone Debiti di valore, in Banca Borsa e Titoli di Credito pag. 600
[25] Cass., 21 febbraio 1995, n. 1889; Corte Conti, 6 giugno 1994, n. 9; Cass., 12 febbraio 1993, n. 1784; Trib. Milano, 2 maggio 1996. DI MAJO, voce Obbligazioni pecuniarie, in Enc. del dir., XXIX, Milano, 1979, p. 2632; BIANCA, Diritto civile 4. L’obbligazione, Milano, 1990, p. 147
[26] DI STASO, voce Somma di denaro (debito di), in Nss. Dig. it., XXII, Torino, 1970, p. 870
[27] Cass., 20 gennaio 1995, n. 634
[28] SALARIS, Le azioni a difesa della proprietà, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VII, Torino, 1982, p. 682.
[29] BRECCIA, La ripetizione dell’indebito, Milano, 1974, p. 411 (« il riferimento al rimborso del valore del bene … costituisce un’applicazione del principio secondo cui la ripetizione è diretta a ripristinare, almeno per equivalente, la situazione che abbia preceduto il pagamento »)
[30] DI MAJO, voce Obbligazioni pecuniarie, in Enc. del dir., XXIX, Milano, 1979, p. 2632
[31] MODUGNO, voce Antinomie e lacune, in Enc. giur. it., II, Roma, 1988, p. 1
[32] GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1998, p. 220 s.
[33] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie. Art. 1277-1284, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1959, sub artt. 1277-1281, p. 448
[34] BIANCA, L’obbligazione, cit., p. 149, il quale, pur senza motivare, identifica l’ambito di applicazione del principio nominalistico nelle « obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto fin dall’origine la prestazione di un importo nominale di denaro che può essere determinato o determinabile mediante il riferimento a parametri fissi ».
[35] GIORGIANNI, Credito e creditore, in Noviss. Digesto it., IV, Torino, 1959, p. 1111: sul punto, da ultimo, DOLMETTA, voce Cessione dei crediti, in Digesto IV. Disc. priv. Sez. civ., II, Torino, 1988, p. 288
[36] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 449.
[37] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 456, DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, cit., p. 92.
[38] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 457 ss.
[39] LAMBO-LANOTTE, Debiti di valore: in cerca di un criterio per la quantificazione degli interessi, in Danno e resp., 1999, p. 799 ss.
[40] QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, cit., p. 470.
[41] DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, cit., p. 92
[42] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 522.
[43] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 517 ss.
[44] Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712
[45] G. FERRI jr., Danno extracontrattuale e valori di mercato, in Riv. dir. comm., 1992, I, p. 764 s.
[46] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 517 ss.
[47] App. Salerno, 28 marzo 1999, in Danno e resp., 1999, p. 802: « se si conduce, ad es., un monitoraggio sui prezzi di scambio dei beni, si nota che quelli appartenenti al settore dell’elettronica, nel corso di pochi anni, subiscono forti abbattimenti, mentre i prezzi di altre categorie di beni, come quelli delle autovetture, dei natanti o altri beni c.d. di lusso, nello stesso arco di tempo si accrescono, addirittura, in alcuni casi, si raddoppiano ».
[48] BIANCA, Diritto civile 5. La responsabilità, Milano, 1994, p.134
[49] Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712
[50] Cass., 1o dicembre 1992, n. 12839
[51] LIBERTINI, voce Interessi, in Enc. del dir., XXII, Milano, 1972, p. 118¸ Cass., 19 maggio 1995, n. 5525.
[52] Cass., 28 novembre 1998, n. 12089; Cass., 24 luglio 1998, n. 7298; Cass., 27 gennaio 1996, n. 637
[53] CHIANALE, Diritto soggettivo e tutela in forma specifica, Milano, 1993, p. 37
[54] Cass., 6 maggio 1992, n. 5423.
[55] M. TRIMARCHI, Svalutazione monetaria e ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie, Milano, 1983, p. 104 s.
[56] Trib. Crema 14 settembre 1995.
[57] Cass., 5 giugno 1985, n. 3356
[58] Trib. Reggio Emilia, 7 aprile 1995
[59] Cass. sez. un. 5 aprile 1986, n. 2368; Cass. sez. un., 4 luglio 1979, n. 3776
[60] PARDOLESI, Le sezioni unite su debiti di valuta e inflazione: orgoglio (teorico) e pregiudizio (economico), in Foro it., 1986, I, c. 1270 ss..
[61] App. Salerno, 28 marzo 1999

















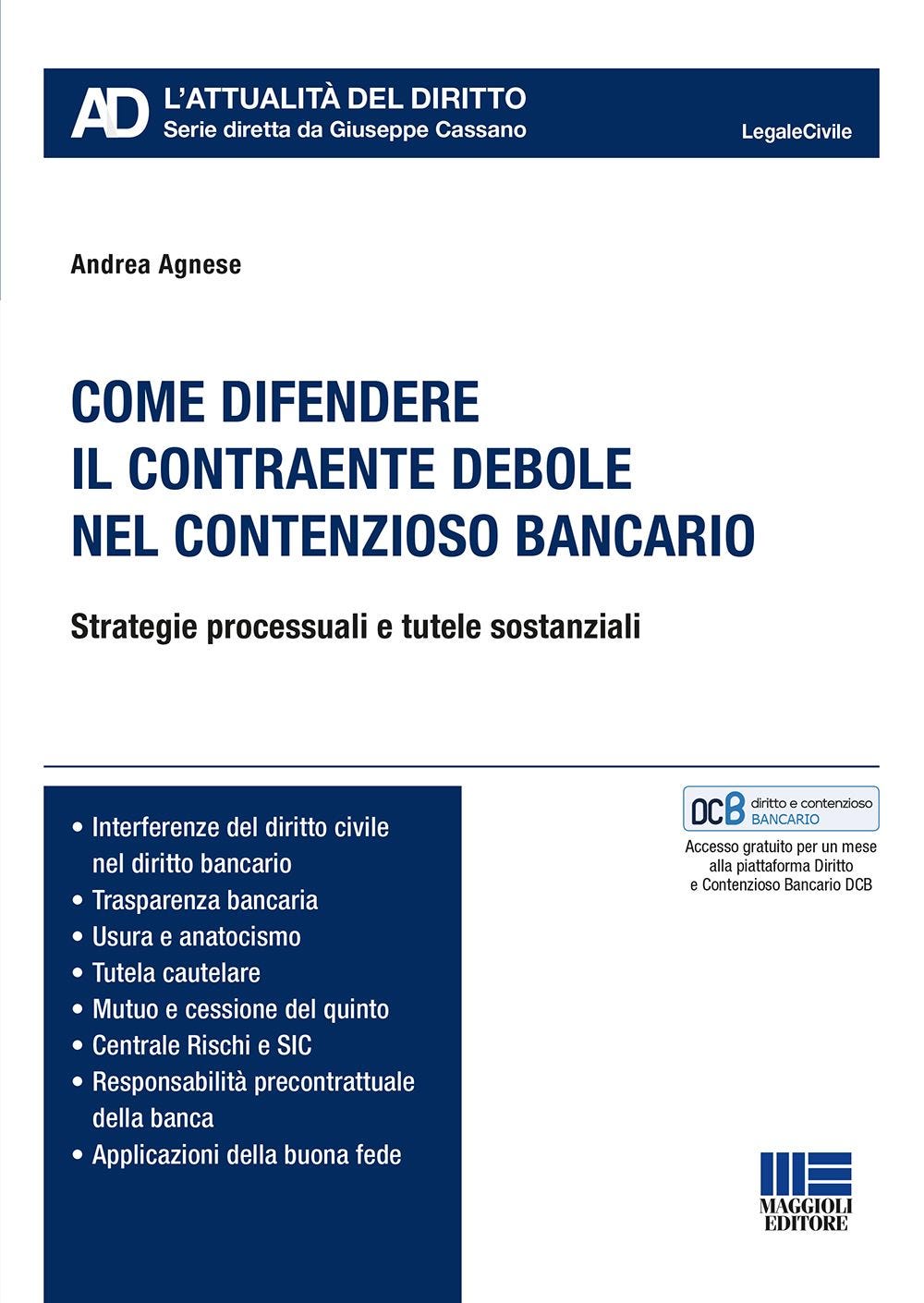




Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento