Poter dire ciò che si vuole, in un’epoca in cui, attraverso i social network, commentare una notizia o pubblicare un “post” al vetriolo è questione di pochi secondi, presenta però due problematiche essenziali.
In primo luogo, la frase che viene spesso percepita alla stregua di una scritta sul muro è visibile a una platea potenzialmente sterminata. Il numero dei potenziali passanti davanti all’ipotetico muro imbrattato non è lontanamente paragonabile a quello degli utenti di internet (o almeno di quel determinato social media).
In secondo luogo, il “post” è praticamente indelebile, visto che anche la sua cancellazione da parte dell’autore o dal gestore della piattaforma non garantisce certo il diritto all’oblio. Una passata di vernice sopra la scritta sul muro imbrattato può essere invece risolutiva.
Sotto altro profilo, le fake news possono riguardare questioni generali, come nel caso del dibattito sul green pass, oppure riguardare un singolo soggetto, di cui viene lesa la reputazione personale.
Quest’ultima ipotesi è il campo di scontro tra interesse pubblico (“a poter dire ciò che si vuole”) e necessità di tutelare i diritti individuali (non vedersi attribuiti comportamenti mai tenuti e non essere oggetto di insulto).
Qualche premessa
Esiste un argine, nel nostro sistema giuridico, all’esercizio della libertà espressiva, rappresentato dall’art. 595 del Codice Penale, che punisce “chiunque offende l’altrui reputazione, comunicando con più persone” con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro.
Tale norma è inserita nel Codice Penale italiano (cd Codice Rocco), che risale al 1930 e conserva inevitabilmente un’impostazione autoritaria.
Basti pensare che il reato di diffamazione precede la Carta Costituzionale, adottata solo nel 1948, e quindi ignora l’introduzione del fondamentale articolo 21, norma cardine della libertà espressiva, che proclama , al primo comma, “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Ciò nonostante, l’articolo 595 c.p. è reso compatibile con l’articolo 21 della Costituzione dall’articolo 51 c.p., che rende non punibile chiunque commetta un reato “nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”: il legislatore fascista non aveva dubbi sulla prevalenza del valore dell’ordine pubblico su quello di libera espressione del pensiero, tuttavia l’indubbia buona qualità della tecnica redazionale che caratterizza il Codice Rocco (e che giustifica il fatto che sia tutt’oggi in vigore) emerge proprio nella scelta di usare una forma flessibile: la generica menzione dell’esercizio di un diritto tiene in considerazione il fatto che il concetto stesso di “diritto” è mutevole.
Nel 1930, per esempio, criticare il Governo non era certo considerato un diritto. Nell’Italia repubblicana, invece, certamente lo è. Di conseguenza, oggi l’articolo 51 c.p. si riferisce essenzialmente (ma non solo) al diritto di cronaca e di critica.
Fatta questa premessa, è interessante osservare che il reato di diffamazione conserva nel Codice Penale alcune peculiari caratteristiche, per esempio la collocazione tra i “delitti contro l’onore” e di conseguenza può essere integrato anche diffondendo una notizia vera: per esempio, chi in un piccolo paese divulghi attraverso il quotidiano locale la notizia che un concittadino frequenta prostitute sarà punito per diffamazione, anche se provi che la notizia è vera. Ciò in quanto non trova applicazione la scriminante del diritto di cronaca, che invece si applicherebbe, per esempio, se il concittadino fosse un esponente politico conosciuto per le sue posizioni conservatrici, perché in quel casola notizia avrebbe profili di interesse pubblico.
Altra interessante nota sulla “tensione” tra diffamazione e diritto di cronaca è che la Corte Costituzionale, con la recentissima Sentenza 150/2021 ha stabilito l’illegittimità della legge italiana laddove obbliga il giudice a punire con il carcere la diffamazione a mezzo stampa o radiotelevisivo: tale pronuncia, in verità, interviene sull’art. 13 della Legge sulla stampa n. 47 del 1948, che stabiliva appunto il carcere obbligatorio per il giornalista che attribuisse falsamente un fatto determinato, lasciando invece intatto l’art. 595 c.p.; il Codice Rocco, infatti, come detto, prevede in via alternativa la pena detentiva ovvero quella pecuniaria.
Curiosamente, quindi, la pronuncia della Consulta – adempiendo peraltro alle indicazioni della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che chiedeva un miglior bilanciamento tra la tutela della reputazione individuale e il ruolo di guardiano della democrazia del giornalista – ha abrogato una norma introdotta dal regime repubblicano, considerando invece compatibile un reato concepito in epoca fascista.
Cronaca e critica
Si noti che cronaca e critica sono concetti vicini ma distinti e conseguentemente la giurisprudenza ha elaborato diversi e peculiari “limiti” entro i quali tali diritti (il cui esercizio, lo ricordiamo, rende non punibile il reato ai sensi dell’art. 51 c.p.) possono essere esercitati.
Il diritto di cronaca, secondo una celebre sentenza della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984 (detta “Sentenza decalogo del giornalista”) deve rispettare tre fondamentali canoni per potersi dire correttamente esercitato: verità, pertinenza e continenza.
La verità consiste, ovviamente, nell’oggettiva esistenza del fatto che viene riferito, mentre la pertinenza si riferisce al necessario interesse pubblico della notizia: il diritto di cronaca giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. Come si è detto nell’esempio prima citato, le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini.
Quanto alla continenza, questo criterio esige che le modalità espressive siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’’informazione, e non trasmodino in espressioni inutilmente volgari, umilianti o dileggianti.
Per quanto riguarda il diritto di critica (politica o meno) questo pone il peculiare problema di non essere vincolato dal criterio della “verità” in quanto un’opinione non è suscettibile di un giudizio vero/falso.
La giurisprudenza tuttavia ha in più occasioni chiarito che il diritto di critica, pur non essendo suscettibile di un giudizio di esattezza, presuppone comunque un contenuto minimo di veridicità, limitato all’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (da ultimo, da Cass. Sez. V, n. 31263/2020).
La crescita del fenomeno e la risposta dell’Autorità Giudiziaria
Come è evidente dal fiume di inchiostro versato fin dal secolo scorso per redigere norme e sentenze in tema di diffamazione, il problema è antico, tuttavia nuovi orizzonti si sono recentemente aperti.
Da un lato ciò è determinato dall’esistenza di uno strumento onnipresente e pervasivo come i social media, che hanno caratteristiche profondamente diverse, in termini di accessibilità, rispetto ai giornali di carta stampata o anche ai blog settoriali della “prima era” di internet.
Un altro elemento decisivo, meno legato al “mezzo” e più al “contenuto” , è rappresentato dalle sistematiche e studiate campagne di disinformazione che sono in grado di influenzare e indirizzare le opinioni, le scelte e le tendenze di una considerevole quantità di persone. In altre parole, il fenomeno noto con il termine assai di moda di “fake news”.
È di qualche giorno fa la notizia che un blogger ha pubblicato su un sito la falsa notizia che due noti cantanti della scena rap milanese sarebbero stati “arrestati con 28 grammi di cocaina in macchina” e che il Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo aperto a seguito della querela per diffamazione ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari di archiviare la notizia di reato.
Secondo il PM, benché il reato sia “oggettivamente configurabile”, il comportamento dell’autore si collocherebbe “nel contesto della disinformazione che spesso caratterizza l’ambito delle notizie dedicate al cosiddetto gossip con la spettacolarizzazione del pettegolezzo”, e quindi sarebbe non punibile.
In sostanza, secondo il magistrato inquirente, ricorrerebbero gli estremi della menzionata scriminante di cui all’art. 51 c.p., apparentemente richiamando il diritto a fare “satira” su due personaggi noti appartenenti al “jet set”.
Come giustamente argomentato dagli avvocati Minniti e Pietrolucci nella loro opposizione alla richiesta di archiviazione, tuttavia, la “storia” era confezionata in modo da sembrare verosimile e non con toni iperbolici e assurdi, quindi veniva offerta al lettore come una vera e propria “notizia”, trovando applicazione il “decalogo” in tema di diritto di cronaca per godere della scriminante, e dunque il limite di minima veridicità del fatto riportato.
Questo è solo l’ultimo episodio di mancata tutela dinanzi a fenomeni chiaramente riconducibili al reato di diffamazione.
La tendenza delle Procure e dei Tribunali a sottovalutare la rilevanza e l’offensività di questo reato è evidente dalle richieste di archiviazione e dai conseguenti provvedimenti, di cui si intende qui offrire una piccola casistica.
In particolare i provvedimenti citati si riferiscono a diffamazioni rivolte a personaggi pubblici, vuoi perché magistrati noti, vuoi perché amministratori locali, che proprio per la loro posizione sembrano essere considerati oggetto “naturale” di attacchi diffamatori e che sembrano chiamati a sopportare tali aggressioni come se questo fosse lo scotto dovuto alla scelta di partecipare alla vita pubblica.
Richiesta di archiviazione del 23.7.2019 nell’ambito del P.P. 1733/18 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Il procedimento prendeva le mosse da un articolo pubblicato da una nota testata giornalistica, in cui l’articolista rappresentava ai lettori una notizia totalmente falsa, secondo cui un noto magistrato avrebbe voluto “buttarsi in politica” e “fare fuori” dall’agone politico il leader di un partito dell’allora maggioranza, aggiungendo come notizia certa che si sarebbero svolti alcuni incontri tra detto magistrato e il leader di un partito dell’allora minoranza.
Tale articolo è stato oggetto di una denuncia-querela, sfociata in un accordo transattivo con la testata giornalistica, che ha risarcito il danno causato e presentato una lettera di scuse, smentendo le notizie false.
Oggetto di una diversa e autonoma denuncia-querela sono stati i commenti insultanti e le semplici contumelie di cui il magistrato vittima di diffamazione è stato coperto dai lettori del giornale, che hanno “intasato” lo spazio dedicato ai commenti del sito della testata giornalistica.
Celandosi dietro “nicknames” tali soggetti hanno “postato” una serie di improperi (il magistrato veniva per esempio definito “mentalmente instabile”, “orrido paranoico”, “corrotto e marcio”, “nazistello da strapazzo” e simili) che senza ombra di dubbio rientravano nella diffamazione, trattandosi di affermazioni lesive dell’onore altrui, chiaramente esorbitanti da ogni diritto di critica, che non consente il puro e semplice insulto.
Tale premessa, condivisa dal Pubblico Ministero chiamato a svolgere le indagini a seguito della querela, è stata oscurata da considerazioni più “pratiche” e francamente poco condivisibili, da cui discenderebbe l’incoerente conclusione secondo cui la notizia di reato sarebbe “infondata”, “in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.
Scrive il magistrato nella propria richiesta di archiviazione: Non appare certa la attribuibilità dei fatti contestati agli odierni indagati, dal momento che appare arduo conoscere l’esatta identità di coloro i quali si celano dietro i cosiddetti nickname o pseudonimi utilizzati dagli autori dei commenti asseritamente diffamatori, che risultano così essere sostanzialmente e fatalmente commenti anonimi (e dunque, a fortiori, privi di idoneità a condizionare o orientare l’opinione pubblica). Infatti le indagini espletate hanno consentito di risalire agli odierni indagati quali intestatari delle utenze telefoniche dalle quali è stata generata, di volta in volta, la connessione internet utilizzata per postare il commento in esame.
Tuttavia, non è dato sapere se terzi, di cui allo stato risulta impossibile la identificazione, abbia fatto un uso indebito della connessione, eventualmente sfruttando reti cd “aperte”.
In altre parole, il PM argomenta che aver rintracciato gli IP (e i conseguenti nominativi dei titolari, i cui nomi, in massima parte, avevano analogie con i “nickname” utilizzati) non era sufficiente a identificare gli autori dei “post”.
E ancora si legge: peraltro, le invettive compendiate in querela appaiono chiaramente grossolane e di infimo livello e i fatti attribuiti alla p.o. palesemente infondati, al punto da apparire le condotte inidonee a provocare reale lesione della reputazione e dell’onore del querelante. Va invero osservato che nell’attuale panorama della rete internet, l’esposizione di soggetti celebri a commenti e ingiurie più o meno espliciti appare un portato inevitabile; il tutto acuito da registri espressivi spiccatamente aggressivi ( ma generalmente accettati, almeno sul piano della politica criminale, come dimostra l’intervento legislativo di depenalizzazione del delitto di ingiuria). In altre parole, alla crescente maleducazione degli utenti della rete non consegue una eguale crescita dei fatti penalmente rilevanti.
Questo secondo passaggio lascia particolarmente perplessi, laddove afferma, in sostanza:
- che più l’insulto è grossolano e di infimo livello, minore sarebbe la lesione dell’onore derivante alla persona offesa (confondendo così l’idoneità dei commenti a influenzare l’opinione altrui con l’idoneità a offendere);
- che nell’attuale panorama della rete internet l’esposizione di soggetti celebri a commenti e ingiurie appare un “portato inevitabile” e quindi, se ne conclude, la persona offesa dovrebbe rassegnarcisi;
- che il legislatore, depenalizzando il reato di ingiuria (che si distingue dalla diffamazione per il fatto che la persona offesa è presente, e quindi può replicare) avrebbe inteso esprimere una generale accettazione di registri espressivi platealmente insultanti come quelli utilizzati in questo caso.
Inutile dire che queste posizioni del Pm sembrano esulare da argomenti giuridici, mascherando piuttosto una resa de facto a un fenomeno che, benché evidentemente illecito, è percepito come talmente diffuso da non essere più arginabile con le risorse in dotazione alle Procure.
Un punto di vista, quest’ultimo, non totalmente irragionevole, ma che si risolve in una mancata tutela giuridica del cittadino, alle cui legittime doglianze l’Autorità Giudiziaria risponde con un provvedimento che equivale a una desolata stretta di spalle.
Per completezza si aggiunge che, nel caso citato, la persona offesa ha ritenuto di non proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, anche in considerazione dell’avvenuto risarcimento da parte della testata giornalistica che, con la sua pubblicazione, aveva istigato gli insulti. La testata ha inoltre provveduto a rimuovere i commenti dei lettori dal sito e a richiedere al motore di ricerca Google la deindicizzazione dell’articolo.
Richiesta di archiviazione del 16.7.2020 nell’ambito del P.P. 1347/20 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese
Il procedimento prendeva le mosse dalla pubblicazione sul social network Facebook di un lungo post, comparso sul profilo Facebook di una consigliera di minoranza di un piccolo Comune in provincia di Varese, che attaccava l’amministrazione Comunale accusandola di aver commesso gravi illeciti, “pienamente ammessi dal Sindaco”, ed in particolare di aver creato una “discarica abusiva”, scaricando rifiuti in prossimità del torrente cittadino, “vicino ai pozzi dell’acquedotto pubblico”.
Subito dopo la pubblicazione su Facebook, erano comparsi in paese dei volantini anonimi, di contenuto analogo a quelli contenuti nel “post”.
Il Sindaco, anche a nome dell’intera Amministrazione Comunale, aveva presentato denuncia-querela per diffamazione, in quanto (come riconosciuto anche all’esito delle indagini) non esisteva alcuna discarica abusiva, e certamente il Sindaco non aveva fatto alcuna ammissione in tal senso.
La querela era stata presentata contro ignoti, rappresentando tuttavia che i volantini avevano un contenuto analogo al post della consigliera comunale e infatti le indagini hanno rivelato che essa stessa era l’autrice dei volantini anonimi.
In sostanza, quindi, dalle indagini è emerso che la consigliera comunale aveva distorto una circostanza reale (una ditta privata, che svolgeva dei lavori nel territorio comunale, aveva temporaneamente depositato dei materiali inerti in un prato, comunque lontano dall’acquedotto e non certo su mandato del Sindaco) attribuendo al primo cittadino un reato, attraverso pubblicazioni su social network e volantini anonimi.
La Procura competente, tuttavia, ha richiesto l’archiviazione argomentando: l’indagata rimarcava il fatto che la contestazione esercitata attraverso la divulgazione dei volantini era sostanzialmente di natura politica in ordine a una mancata vigilanza da parte dell’amministrazione comunale sull’esecuzione dei lavori, con il relativo smaltimento degli inerti.
La diffusione dei volantini in argomento va dunque inserita in un contesto di dibattito politico che ha prevaricato i limiti del Consiglio comunale dando origine ad una diffusione più capillare sul territorio a scopo informativo.
Seppur non sembrano possano emergere responsabilità penali dirette da parte del Comune di – omissis – nello smaltimento degli inerti, questo Pubblico Ministero non ravvisa condotte lesive dell’onore e del decoro dell’amministrazione Comunale, rappresentata dal proprio Sindaco – omissis -, infatti,le affermazioni riportate sui volantini stessi risultano essere per lo più imprecise e grossolane, ma non del tutto in veritiere se inquadrate in un’ottica di dibattito politico, tipico delle amministrazioni comunali in particolar modo nei piccoli centri.
In sostanza, quindi, secondo il Pm, nei piccoli centri il dibattito politico giustificherebbe una polemica anche attraverso “affermazioni imprecise e grossolane” e quindi, se ne deduce, la condotta sarebbe scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica.
Quello che appare criticabile, a parere di chi scrive, è la sottovalutazione del mezzo utilizzato, ossia i social network, che certo non consente un’equiparazione a una discussione sulla piazza cittadina, svalutando una condotta che, non lo si può dimenticare, consiste pur sempre nell’attribuzione di un reato tramite una piattaforma virtuale frequentata da milioni di persone in Italia.
Affermazioni “imprecise e grossolane” (ma sarebbe meglio dire false) possono essere tollerate in una discussione da bar, ma assumono contorni assai diversi se vengono divulgate per iscritto, da una consigliera comunale (e non da un quisque de populo) attraverso un mezzo anonimo (i volantini) e attraverso un mezzo con una diffusione enorme (Facebook).
Quanto alla circostanza che la “critica politica” fosse esercitata attraverso volantini anonimi, la giurisprudenza sembra escludere in nuce la possibilità di invocare, in un caso simile, della scriminante ex art. 51 c.p. (tra le altre, Cass. n. 11004/2011).
È stata formulata opposizione alla richiesta di archiviazione sulla quale, ad oggi il Giudice per le indagini preliminari deve ancora pronunciarsi.
Decreto di archiviazione dell’11.10.2021 nell’ambito del P.P. 3918/20 – Tribunale di Pavia – sez. Gip
Anche quest’ultimo procedimento riguardava un’ipotesi di diffamazione tramite Facebook nell’ambito di una polemica politica interna a un piccolo Comune di una provincia lombarda.
Sulla pagina Facebook intitolata a un’associazione culturale, poi risultata costituita da una consigliera di minoranza del Comune in questione, era apparso un “post” che rappresentava la commissione di una serie di illeciti da parte dell’amministrazione comunale nell’ambito dell’esecuzione di una Convenzione Urbanistica, affermando che sarebbero stati favoriti alcuni privati “a scapito dell’interesse pubblico”.
Il Sindaco, anche a nome dell’intera Amministrazione Comunale, aveva presentato denuncia-querela per diffamazione, in quanto nessun illecito era stato commesso e l’insinuazione di aver commesso gravi abusi, anche di rilevanza penale, rappresentava certamente un vulnus per gli amministratori di un piccolo centro, dove la politica locale è basata in gran parte sulla reputazione personale.
Ancora una volta la querela era stata presentata contro ignoti, dato che il post non era firmato, riferendo tuttavia che la pagina Facebook dove era collocata la pubblicazione diffamatoria rendeva facilmente individuabile l’autore.
Il Pubblico Ministero, tuttavia, richiedeva l’archiviazione del procedimento, affermando che la pagina Facebook “era di libero accesso a tutti gli appartenenti del tempo alla omonima associazione, che avevano la possibilità di pubblicare post, per cui risultava impossibile risalire ai responsabili o comunque imputare specifiche responsabilità di merito”.
La persona offesa presentava opposizione alla richiesta di archiviazione, chiedendo che le indagini, costituite fino ad allora esclusivamente dal tracciamento dell’IP di provenienza del “post”, venissero integrate dall’audizione degli appartenenti all’associazione di cui alla pagina Facebook.
Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che ha accolto l’istanza di archiviazione del PM, si segnala non tanto per il passaggio in cui (come di consueto) si aderisce alla tesi secondo cui l’individuazione del reo non sarebbe possibile (tra le righe pare di leggere che, in realtà, il punto è che non ne varrebbe la pena), quanto per un aspetto “sostanziale”:
passando al merito, è pacifico che quando una pagina Facebook pubblica sulla propria bacheca un certo contenuto,e questo non risulta autografato da persona nota, è del tutto impossibile identificare l’autore, non potendosi imputare ad alcuno, sotto il profilo penalistico, la paternità del post incriminato.
In sostanza, secondo il Giudice di Pavia, chiunque pubblichi su Facebook un contenuto offensivo o denigratorio, e non lo firmi in calce con il proprio nome e cognome, renderebbe con ciò in nuce non punibile la diffamazione.
Anche senza considerare il fatto che il Giudice sembra confondere un aspetto di procedibilità (la possibile identificazione dell’autore del post) con una questione di merito (la punibilità astratta o meno della condotta), l’argomentazione viene formulata in modo talmente icastico da suggerire che , al di là delle argomentazioni giuridiche, il fenomeno della diffamazione tramite social network non sia tale da meritare l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.
Conclusioni
Dagli esempi sopra riportati, raccolti nel corso degli ultimi anni, e fino all’ultimo, recentissimo, provvedimento citato, con i quali Procure e Tribunali hanno sostanzialmente respinto le istanze punitive di persone offese da fenomeni di diffamazione tramite social network, possono trarsi alcune considerazioni.
La diffamazione, attraverso gli strumenti telematici che praticamente ogni persona ha a disposizione, è diventato un reato allo stesso tempo più facile da commettere e dal quale è più difficile tutelarsi.
Ciò è determinato da due tendenze.
Da un lato, soprattutto quando la diffamazione riguarda persone note e titolari di cariche pubbliche, sembra che la “soglia di tolleranza” rappresentata dal diritto di critica sia enormemente dilatato: accusare un amministratore pubblico di aver commesso gravi reati è considerato alla stregua di una legittima arma nel dibattito politico.
Così come il “vip” dovrebbe considerare un “portato inevitabile” della propria notorietà la diffusione della notizia che è stato arrestato per possesso di droga, il pubblico amministratore dovrebbe accettare le accuse di essere corrotto o di aver commesso abusi perché “fa parte delle regole del gioco”.
La causa (e purtroppo anche l’effetto) di ciò, è che il medio utente di internet, che certo esiterebbe a utilizzare certe espressioni e a diffondere certe “notizie” se si trattasse di una pubblicazione su un giornale, considera i post sui social network come scritte sull’acqua, laddove, come detto, è esattamente il contrario.
Sotto altro aspetto, gli uffici preposti alla repressione di questo genere di reati ricorrono sempre più spesso a un argomento non tanto giuridico quanto pratico, ossia la presunta impossibilità di identificare gli autori di un “post” su internet.
Si è visto come gli inquirenti tendono spesso a spingere questo argomento ai confini dell’incoerenza (per esempio laddove si affermi che pubblicare sulla propria bacheca di Facebook un contenuto offensivo senza firmarlo in calce basterebbe a rendere il fatto non attribuibile a nessuno).
Ciò rende particolarmente evidente come la logica sottesa a tali prese di posizione sia, in realtà, scoraggiare la persona offesa ad avvalersi del diritto penale per tutelarsi da questo genere di condotte.
Come ha recentemente scritto a tal proposito un noto editorialista, non ci si ferma a discutere con un cane che abbaia dietro un cancello, si passa oltre ignorandolo.
La domanda se sia opportuno o meno utilizzare il diritto penale come strumento per responsabilizzare i cittadini non è certo peregrina, tuttavia la sistematica archiviazione delle denunce in materia rischia di tradursi in mancata tutela di un fenomeno del quale non sembra essere pienamente percepita la portata lesiva.
Volume consigliato
La responsabilità nei nuovi reati informatici
L’opera si pone quale strumento di analisi dei nuovi reati informatici e delle metodologie investigative, analizzando i diversi mezzi di ricerca e di acquisizione della prova informatica.Attraverso un’analisi sistematica, il volume affronta le singole fattispecie, ponendo l’attenzione sulle modalità di ricerca della prova e aiutando il professionista nell’individuazione degli elementi che costituiscono la responsabilità penale dell’autore del reato.Lo spazio fluido, tipico del web, richiede un’attenzione particolare: quest’opera nasce proprio dall’esigenza di fornire nozioni e azioni di riferimento, che possano guidare l’operatore nel costruire la propria linea difensiva, alla luce delle nuove figure criminose, quali l’hate speech, il sexting, il revenge porn, il cyber terrorismo e il cyberlaundering.A completamento della trattazione, nella seconda parte, il volume affronta le diverse metodologie investigative, nonché le tecniche forensi di acquisizione e conservazione della prova informatica.In tal modo, il testo si pone quale valido strumento per il professionista che debba fornire la prova della consumazione di reati informatici.Flaviano PelusoAvvocato in Roma. È Professore a contratto di scienze giuridiche medico-legali, presso la facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza, di abilità informatiche presso le facoltà di Economia, Psicologia e Lettere dell’Università La Sapienza, nonché d’informatica ed elaborazione dati e di idoneità informatica presso l’Università della Tuscia. È autore di libri, articoli e note a sentenza nonché curatore di libri in materia di diritto dell’informatica e di informatica forense.Cecilia CavaceppiGiudice del Tribunale di Latina applicata attualmente al Tribunale di Napoli. È dottore di ricerca in diritto amministrativo presso la Luiss Guido Carli.Francesco Saverio CavaceppiAvvocato del Foro di Roma, Professore a contratto di informatica ed elaborazione dati presso l’Università della Tuscia e docente di informatica giuridica presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Migliorini” dell’Università di Perugia.Daniela CavallaroAvvocato del Foro di Velletri e Data Protection Officer presso l’Agenzia di Stampa Nazionale; ha conseguito il master in Diritto dell’informatica presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha conseguito i certificati di European Privacy Expert, Valutatore Privacy (UNI 11697:2017) e Auditor ISDP 10003.Raissa ColettiConsulente in Institutional & Corporate Communication. Ha conseguito il master in Human Resource management & Digital Skills.Alfonso ContaldoProfessore a contratto di diritto dell’informazione e della comunicazione digitale nell’Accademia delle Belle Arti di Roma, dottore di ricerca in informatica giuridica presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. È autore di monografie, articoli, note e contributi in collettanei in materia di diritto dell’informazione e dell’informatica e di informatica giudiziaria.Alessandra CorteseAssistente Giudiziario presso la Procura Generale della Repubblica di Venezia, è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Messina, ha conseguito il master di 2° livello in Diritto dell’informatica presso l’Università La Sapienza, è abilitata all’esercizio della professione forense, è socia ANORC, è iscritta nel registro dei Professionisti della Privacy. È autrice di alcuni articoli di diritto dell’informatica.
Alfonso Contaldo, Flaviano Peluso (a cura di), Cecilia Cavaceppi, Francesco Saverio Cavaceppi, Daniela Cavallaro, Raissa Coletti, Alessandra Cortese | 2020 Maggioli Editore

















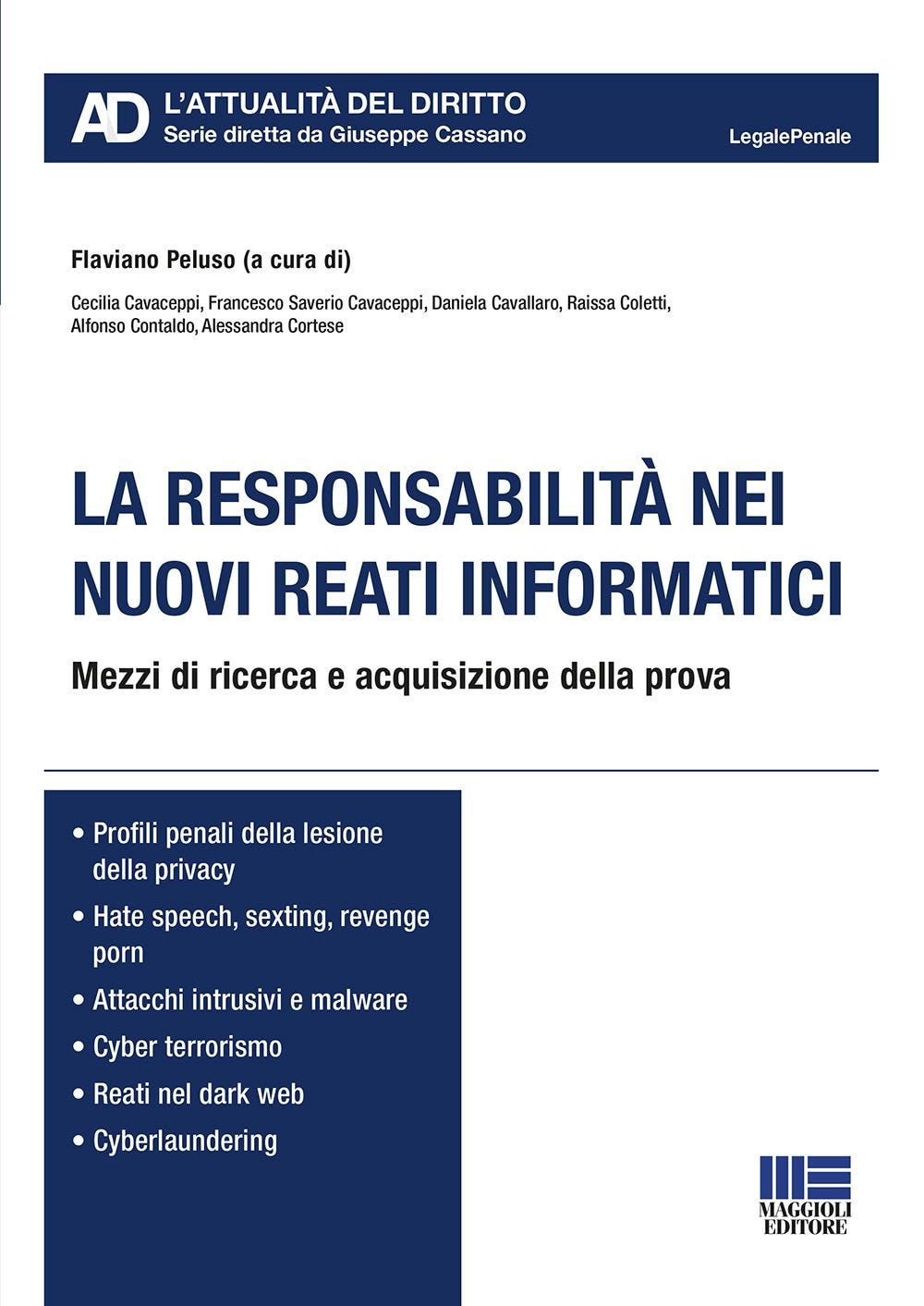


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento