Due recenti sentenze della Cassazione 28/09/2016 n° 19180 e 24/10/2016 n° 21378, ripropongono il tema del mobbing in ambito lavorativo, in fattispecie in cui si discuteva se il demansionamento od un rilevante mutamento delle mansioni potesse configurare un comportamento del datore di lavoro mobbizzante, idoneo a sostanziare il diritto del lavoratore al risarcimento danni.
È bene subito chiarire che il c.d. mobbing è un fenomeno che si è sempre più sviluppato in ambito giuslavoristico, a partire dalla ormai nota sentenza del Tribunale di Torino del 16/09/1999 (in Resp. Civ. e Prev. 2000, 725) che ha avuto il merito di riconoscere per primo la sussistenza “di un’ipotesi di mobbing allorché il dipendente è oggetto di soprusi da parte dei superiori ed in particolare allorché vengano poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro e nei casi più gravi ad espellerlo, pratiche il cui effetto è di intaccare l’equilibrio psichico del prestatore”. Una decisione, questa, poi seguita da diverse sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità che in pratica hanno fornito definizioni simili.
Precisa appare, al riguardo, una recente pronuncia del Tribunale di Milano 03/05/2016 n° 1329 (il Sole 24 ore Mass. Rep. Lex 24, 2016) il quale ha testualmente ritenuto quanto segue: “Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il mobbing si sostanzia in una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concretizza, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, garantita dall’art. 2087 CC. Trattasi di un comportamento illecito che costituisce una violazione dell’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e che può realizzarsi con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
Ai fini della configurabilità del mobbing, rilevano, dunque:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l’evento lesivo della salute e della personalità e dignità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore o il superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore, la prova dell’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio.
In altro senso il mobbing è caratterizzato da una condotta del datore di lavoro o superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro, consistente in reiterati e sistemici atti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica determinanti la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente con effetti lesivi dell’equilibrio psico-fisico e della personalità del medesimo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è, per così dire, granitica nel ritenere necessaria la sussistenza di tali elementi ai fini della configurabilità del c.d. mobbing nella condotta del datore di lavoro le due ultime sentenze della Corte Regolatrice confermano il trend interpretativo che segue pedissequamente altre decisioni di poco precedenti.
Nello stesso senso, si segnalano Cass. 08/01/2016 n° 158 e Cass. 03/03/2016 n° 4222 e, meno recentemente, Cass. 06/08/2014 n° 18698 e Cass. 23/07/2012 n° 12270, solo per citarne alcune.
È, in definitiva, un dato acquisito che il mobbing, per assumere rilevanza giuridica, implica la esistenza di plurimi elementi di natura oggettiva e soggettiva, la cui prova compete, ex art. 2697 CC, al prestatore di lavoro, almeno per quanto attiene agli atti vessatori, potendo avvalersi delle presunzioni, invece, con riferimento alle finalità di detti atti (es. ottenimento dimissioni). E, tra questi, l’emergere di un intento persecutorio che, non solo deve assistere le singole condotte poste in esser in danno del lavoratore, ma anche comprenderle in un disegno comune ed unitario, in una strategia di attacco ripetuto e duraturo posto in essere con lo scopo specifico di isolare od espellere il lavoratore.
Come emerge dalla lettura delle decisioni della giurisprudenza, il principale indicatore per l’individuazione dell’intento persecutorio, è la pretestuosità dell’atto o del comportamento che può anche disvelare una intenzione meramente emulativa.
La necessità che la condotta mobbizzante sia posta in essere nel contesto di una strategia vessatoria nei confronti del lavoratore, porta ad escludere che possa identificarsi l’intento persecutorio nei normali conflitti interpersonali tra datore e prestatore di lavoro appartenenti piuttosto alle normali dinamiche di detto rapporto.
In tale contesto è stata ad esempio esclusa (Cass. 04/06/2015 n° 11547) “la sussistenza di una condotta persecutoria nella contestazione di una serie di addebiti al lavoratore (rientro in azienda in ritardo, dopo le festività di fine anno, abbandono del posto di lavoro, assenza ingiustificata, non corretta esecuzione delle prestazioni lavorative, disordine nella postazione di lavoro) allorché, in nessuno dei casi specificamente presi in considerazione, risulti il difetto degli addebiti l’evidente sproporzione dei richiami, od altro sintomo che consenta di ravvisarvi un carattere meramente pretestuoso o discriminatorio, non potendo l’intento persecutorio del datore di lavoro ricavarsi dalle iniziative disciplinari poste in essere dal medesimo, avverso le quali è pur sempre consentito al lavoratore tutelare le proprie ragioni attraverso i rimedi specifici apprestati dalla legge”.
Se il mobbing, in definitiva, può anche definirsi riassuntivamente come un agire irrazionale, tuttavia va segnalato che l’unicità del disegno persecutorio potrebbe non emergere nella fattispecie concreta, perché il lavoratore non è riuscito a provarne la sussistenza.
In tale ipotesi, la Corte Regolatrice ha ritenuto, mitigando per così dire, il rigore probatorio suddetto, che il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere dei singoli episodi di vessazione nei confronti del dipendente anche se privi della dedotta strategia vessatoria, laddove lesivi della dignità e della salute della parte lesa.
In questo senso vedasi Cass. 05/11/2012 n° 18927 la quale ha precisato che alla base della responsabilità per mobbing si pone l’art. 2087 CC negando che possa configurarsi, al riguardo, una ipotesi di responsabilità oggettiva. Anche Cass. 03/03/2016 n° 4222 sottolinea come il c.d. danno da mobbing appartiene alla categoria della responsabilità contrattuale, dovendo ritenersi, sulla base dell’art 2087 CC che tra le obbligazioni contrattuali poste a carico del datore, durante un rapporto di lavoro, vi è anche quella di garantire la integrità psico-fisica del lavoratore con la conseguenza che questi non possa rispondere delle condotte persecutorie perpetuate dai colleghi della vittima o dai suoi superiori qualora riesca a dimostrare la non imputabilità del danno.
Con riguardo, in particolare, al demansionamento ( o dequalificazione), che consiste nell’assegnazione del lavoratore a compiti e mansioni inferiori a quelli che gli spetterebbero in base al suo inquadramento, abbiamo già detto come trattasi di un atto che normalmente viene utilizzato all’interno delle pratiche di mobbing dal momento che il lavoratore viene ad essere deprezzato professionalmente.
La più recente giurisprudenza (v. soprattutto da ultimo Cass. 13/10/2016 n° 20677), è orientata comunque a salvaguardare il lavoratore in presenza di condotte vessatorie che pur essendo inidonee a sostanziare un danno da mobbing, possono venire in considerazione ai fini risarcitori attraverso l’art. 2087 CC, considerato norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile d’interpretazione estensiva, in ragione del rilievo costituzionale del diritto alla salute nonché dei principio di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi la svolgimento del rapporto di lavoro e che impongono al datore di lavoro da astenersi da iniziative che possono ledere i diritti fondamentali del dipendente (v. Cass. 19/02/2016 n° 3291).
Dunque, qualora la dequalificazione non può configurarsi come mobbing perché il lavoratore non riesce a dimostrare l’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, nulla vieta che il prestatore di lavoro possa aver diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e professionali.
In tal senso Consiglio di Stato 12/01/2015 n° 28 ma già la Cassazione a S.U. 22/02/2010 n° 4063 ha avuto modo di affermare che nella ipotesi di demansionamento “il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing), alla durata di reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente nonché all’inerzia del datore di lavoro alle istanze del lavoratore”.
Esiste, in conclusione, un danno da demansionamento che prescinde da quella condotta sistematica e protratta nel tempo, connotata degli specifici caratteri di cui si è detto e che può dar luogo ad una ipotesi risarcitoria conseguente ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro (per violazione degli artt. 2087 CC – danno alla personalità – e 2103 CC– danno alla professionalità –).
Con l’avvertenza, purtuttavia, che non ”tutti i casi di inadempimento determinano, come conseguenza automatica, il verificarsi di un concreto pregiudizio, in relazione al quale grava sul danneggiato l’onere di provare, in virtù della regola dell’art. 2697 CC, non solo il verificarsi del danno, ma anche il nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (così Cass. 23/11/2011 n° 24718).
È appena il caso di ricordare, a tal riguardo, che detto onere probatorio, riferito al danno da demansionamento, fermo restando la necessità di allegazione da parte di chi lo lamenti, può ricavarsi anche in via presuntiva o mediante ricorso a massime di comune esperienza ex art. 115 c.p.c. (v. da ultimo Cass. 13/10/2016 n° 20677).
Nel caso di specie, del danno in questione sono state riscontrate la allegazione e la prova, sia pur ricavata, quest’ultima, mediante presunzione, considerata la dequalificazione (oltre tre anni e mezzo), la mortificazione dell’immagine professionale e delle esperienze lavorative già acquisite, la marginalizzazione della posizione del dipendente e la conseguente perdita di contatto con i settori più qualificati della attività bancaria (ndr nel cui ambito operava il prestatore d’opera).



















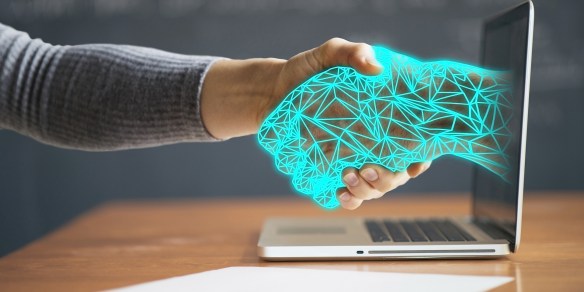

Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento