INDICE
1.1.La diffusione del matrimoni precoce nel mondo
1.2 Le cause principali
1.3 L’infanzia negata: l’obbligo al fatidico “sì”
1.4. La tutela del genere femminile : La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna
Volume consigliato
Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
Fabio Piccioni | 2021 Maggioli Editore
22.00 € 20.90 €
-
La diffusione del matrimoni precoce nel mondo
Negli ultimi decenni l’arrivo e lo stanziamento nei territori europei di individui provenienti da altre aree geografiche ha posto in forme sempre più complesse e pressanti il problema della convivenza tra differenti sistemi di norme e valori.
Le difficoltà di integrazione sono riconducibili generalmente alle condizioni economiche e sociali degli immigrati, ma in alcuni casi anche alle differenze di religione, di organizzazione sociale e, più genericamente, di cultura.
Tra le nuove sfide che il diritto degli Stati occidentali si trova a fronteggiare vi sono, ormai indiscusse, quelle originate dalla cosiddetta società multietnica, a cui si risponde sia attraverso l’emanazione di legislazioni ad hoc sia attraverso adeguamenti nell’ambito dell’attività giudiziaria corrente.
Anche in Italia come è già avvenuto in altri Paesi europei, l’immigrazione si va progressivamente trasformando da individuale a comunitaria: l’individuo si inserisce in una rete di relazioni familiari, etniche e sociali molto strette. Molte comunità di immigrati tendono a conservare le istituzioni, le gerarchie della comunità d’origine, cercando di riprodurle in terra straniera e continuando a seguire gli usi e le norme della società di provenienza.
Pluralismo culturale significa dunque anche pluralismo giuridico. Le teorie del pluralismo giuridico nelle loro varie versioni, assumono l’esistenza accanto a quello statale di altri ordinamenti, più o meno formalizzati e studiano le interazioni tra questi ordinamenti[1].
Usi e norme, di cui non è sempre facile dire se religiose, consuetudinarie, giuridiche, si estendono anche in ambiti regolati dal diritto dello Stato di accoglienza e si pongono verso di esso in rapporti complessi che possono essere di complementarietà, di sovrapposizione, ma talvolta anche di conflitto. L’ambito più interessato è evidentemente quello del diritto internazionale privato, ma si possono verificare anche casi di rilevanza penale. Il conflitto con le norme penali può verificarsi con comportamenti permessi dagli ordinamenti degli stranieri: basti pensare al reato di bigamia contestato ad un musulmano, ma anche con comportamenti prescritti dagli ordinamenti religiosi o sociali di provenienza.
Alcune prescrizioni religiose o tradizionali possono infatti tradursi in illeciti penalmente perseguibili negli ordinamenti degli Stati europei. Questi sono evidentemente i casi più difficili da affrontare, poiché in essi si fronteggiano ordinamenti contrapposti con differenti gradi di vincolatività e differenti sanzioni.
I “matrimoni precoci” sono le unioni (formalizzate o meno) tra minori di 18 anni, una realtà che tocca milioni di giovanissimi nel mondo.
Si conta che nel mondo circa 700 milioni di ragazze si siano sposate in età minorile. Oltre un terzo di esse, circa 250 milioni, hanno contratto matrimonio addirittura prima del compimento dei quindici anni di età.
I tassi più elevati di diffusione dei matrimoni precoci si registrano nell’Asia meridionale (46%) e nell’Africa subsahariana, non a caso le medesime regioni del globo in cui sono massimamente diffusi altri fenomeni, come la mortalità materna e infantile, la malnutrizione, l’analfabetismo ecc.
Sposarsi in età precoce comporta una serie di conseguenze negative, che incidono sia sulla salute che sullo sviluppo degli individui. Inoltre, al matrimonio precoce segue, quasi inevitabilmente, l’abbandono scolastico e una gravidanza altrettanto precoce, e dunque pericolosa sia per la neo-mamma che per il suo bambino.
Analizziamo alcuni dati.
Le gravidanze precoci provocano ogni anno 70.000 morti fra le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni, e costituiscono una quota rilevante della mortalità materna complessiva. A sua volta, un bambino che nasce da una madre minorenne ha il 60% delle probabilità in più di morire in età neonatale, rispetto a un bambino che nasce da una donna di età superiore a 19 anni. E anche quando sopravvive, sono molto più alte le possibilità che debba soffrire di denutrizione e di ritardi cognitivi o fisici[2].
Le “spose bambine”, dunque, sono innanzitutto ragazze alle quali sono negati diritti umani fondamentali: sono più soggette, rispetto alle spose maggiorenni, a violenze, abusi e sfruttamento. Inoltre, esse vengono precocemente sottratte all’ambiente protettivo della famiglia di origine e alla rete di amicizie con i coetanei e con gli altri membri della comunità, con conseguenze pesanti sulla sfera affettiva, sociale e culturale.
Se ne deduce che i matrimoni precoci contravvengano ai principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,l a quale sancisce il diritto, per ogni essere umano sotto i 18 anni, ad esprimere liberamente la propria opinione (art. 12) e il diritto a essere protetti da violenze e sfruttamento (art. 19), e alle disposizioni di altri importanti strumenti del diritto internazionale.
Occorre essere consapevoli che le radici di questo fenomeno risiedono in norme culturali e sociali legate sia a pregiudizi di genere che a strategie sociali proprie delle economie di sussistenza, in primo luogo l’esigenza di “liberarsi” prima possibile del peso rappresentato dalle figlie femmine, ritenute meno produttive per l’economia familiare.
Di conseguenza, l’UNICEF basa le proprie strategie per prevenire i matrimoni precoci sulla sensibilizzazione delle comunità sui diritti delle bambine e delle ragazze, attraverso campagne nazionali e una fitta e paziente attività di dialogo a livello locale, finalizzata a conquistare il consenso dei genitori e dei leader religiosi e comunitari. L’UNICEF affianca anche i governi dei Paesi coinvolti nel fenomeno per migliorare le leggi, le politiche e i servizi sociali.
-
Le cause principali
A livello globale, ormai tutti gli Stati del mondo si sono dotati di leggi atte a combattere la pratica dei matrimoni precoci. Occorre precisare, però, che le leggi non bastano ad arginare il fenomeno. Le cause dei matrimoni precoci variano da Paese a Paese. Ma nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale, le due grandi zone del pianeta dove questo problema è ancora presente, i fattori che le determinano sono essenzialmente tre.
Disparità di genere, poichè le società sono fortemente patriarcali. Pertanto, gli uomini si aspettano che le donne diventino soltanto mogli e madri, e per tale motivo a loro viene spesso negata l’opportunità di studiare e/o di lavorare. Si pensa che le giovani spose siano molto più “disposte” all’obbedienza. Inoltre, data la giovane età, ci sono maggiori probabilità che la ragazza in questione sia vergine.
I matrimoni precoci sono legati, inoltre, alla prtica delle mutilazioni genitali femminili. In molte comunità, specialmente nell’Africa subsahariana, le FGM sono considerate essenziali per poter contrarre in matrimonio. Chi si rifiuta di sottoporsi a esse o di praticarle viene subito isolato e stigmatizzato dall’intera comunità. Proprio la paura di essere isolati fa in modo che le mutilazioni genitali femminili continuino a essere praticate ancora oggi.
Ultimo fattore, ma determinante, è la povertà: una giovane ragazza sposata è una bocca in meno da sfamare. Basti pensare che le bambine nate nelle famiglie più povere hanno il doppio delle probabilità di sposarsi prima di aver raggiunto la maggiore età.
Scendendo nel dettaglio, in considerazione dei gravi danni che possono derivare dalle MGF, a partire almeno dai primi anni Cinquanta del secolo scorso sono state intraprese numerose iniziative di rilievo giuridico, sia a livello internazionale che a livello locale, per contrastare tali pratiche. In particolare, nel 1952 la Commissione sui Diritti Umani dell’ONU segnalava espressamente il problema costituito dalle MGF, ed avviava su di esso una serie di studi e dibattiti, col coinvolgimento, oltre che dell’OMS e dell’UNICEF, anche delle organizzazioni femminili africane, il che portava all’istituzione di un Comitato interafricano sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute delle donne e dei bambini (Dakar, 1984), il cui obiettivo principale consiste nel dar vita a campagne di sensibilizzazione e formazione per attivisti locali, levatrici e membri autorevoli delle comunità locali per contrastare le MGF[3].
E se ancora nel 1985, in occasione della Terza Conferenza dell’ONU sulle donne (Nairobi, 1985), non si poté giungere ad un’esplicita condanna di tali pratiche a causa della forte opposizione sollevata da molti rappresentanti di Paesi africani ed asiatici[4], a partire dagli anni ’90 le MGF sono oramai considerate da tutta la Comunità internazionale come una grave violazione dei diritti delle donne e delle bambine, come attestano i seguenti atti internazionali, pur privi di valore giuridico vincolante[5]: a) la risoluzione n. 48/104, adottata il 20 dicembre 1993 dall’Assemblea Generale dell’ONU, contenente la Dichiarazione sull’eliminazione delle violenze nei confronti delle donne, che all’art. 2 qualifica esplicitamente come atto di violenza le MGF, e che è stata ribadita con la successiva risoluzione n. 53/117 del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea Generale ha chiesto agli Stati di elaborare ed applicare politiche nazionali dirette ad eliminare le MGF; b) la Dichiarazione finale della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, tenutasi al Cairo nel settembre 1994, nella quale si chiede ai Governi di intervenire urgentemente per fermare le pratiche di MGF; c) la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino, adottata al termine della Quarta Conferenza dell’ONU sulle donne (4-15 settembre 1995), nella quale – dopo aver menzionato esplicitamente le MGF tra le pratiche di violenza cui sono sottoposte le bambine, accanto, tra l’altro, a pedofilia, prostituzione, vendita di organi e matrimoni precoci imposti (punto 39 della Piattaforma), e dopo aver sottolineato i gravi rischi per la salute da esse provenienti (punto 93 della Piattaforma) – si fa appello ai Governi “in cooperazione con le organizzazioni non governative, i mass media, il settore privato e le organizzazioni internazionali, compresi gli organi dell’ONU, ad avviare programmi di informazione, educazione e supporto per eliminare pratiche e abitudini dannose, comprese le MGF” (punto 107 lett. a della Piattaforma), e si impegnano i Governi ad “adottare ed applicare disposizioni normative contro gli autori di pratiche ed atti di violenza contro le donne, come le MGF” (punto 124 lett. i della Piattaforma). Tali impegni sono stati poi confermati in occasione della Quinta Conferenza dell’ONU sulle donne (New York, 28 febbraio – 11 marzo 2005); d) infine, la Carta Africana sui diritti e il benessere del fanciullo del 1990, il cui art. 21, par. 1, contiene il divieto delle MGF, e la Carta di Addis Abeba, adottata nel settembre 1997 dal summenzionato Comitato interafricano di Dakar, al termine di un convegno di giuristi tenutosi presso la locale sede dell’Organizzazione per l’Unità Africana, con cui si chiede a tutti i governi africani di adoperarsi per sradicare (o drasticamente ridurre) le MGF.
Occorre, inoltre, segnalare che alcuni Paesi Africani, in cui sono tradizionalmente diffuse le MGF, hanno adottato leggi ad hoc per vietarle del tutto (così il Ghana) o per limitarne la pratica (così la Tanzania, in cui sono vietate le MGF commesse su minorenni; ed il Sudan che punisce la sola infibulazione), anche se tali leggi presumibilmente non ricevono effettiva applicazione[6]. Nella stessa direzione si sono, altresì, mossi taluni Paesi Occidentali, destinatari di flussi immigratori provenienti dall’Africa e dall’Asia: la Svezia, con l. 1° luglio 1982 (modificata nel 1998 e nel 1999); il Regno Unito, con il Prohibition of Female Circumcision Act del 16 luglio 1985 (successivamente aggiornato con il Female Genital Mutilation Act del 2003); la Norvegia, con la l. 15 dicembre 1995, n. 74; gli Stati Uniti, con il Federal Prohibition of Female Genital Mutilation Act del 10 luglio 1995; il Canada, con un emendamento del 25.4.1997 al codice penale; la Nuova Zelanda, con l’art. 204 A del Crimes Act, versione 1999; il Belgio, con la legge 28 novembre 2000, introduttiva dell’art. 409 c.p. . Da ultimo, con la Ley orgánica 3/2005 dell’8 luglio 2005 sono state introdotte anche in Spagna apposite norme per “perseguire extraterritorialmente la pratica della mutilazione genitale femminile”[7].
Infine, anche il Consiglio d’Europa di Strasburgo e il Parlamento dell’Unione europea si sono occupati di MGF. Il primo lo ha fatto adottando due raccomandazioni: la n. 1371 del 23 aprile 1998, concernente i “Maltrattamenti inflitti ai fanciulli”, con la quale si chiede a tutti gli Stati membri di adottare efficaci disposizioni contro le MGF, vietandole nei loro ordinamenti come pratiche di tortura e prevedendo sanzioni penali severe contro i responsabili, genitori compresi; e la n. 1450 del 2000, concernente la “Violenza contro le donne in Europa”, con la quale si è ribadita la condanna di tali pratiche e si è fatto appello agli Stati membri affinché diano attuazione alla precedente raccomandazione n. 1371.
A sua volta, il Parlamento dell’Unione europea ha adottato il 20 settembre 2001 una risoluzione concernente le “Mutilazioni genitali femminili”, n. 2035 (INI)[8], con la quale si condannano fermamente tali mutilazioni, considerate una violazione dei diritti umani fondamentali (punto 1); si chiede all’Unione europea e agli Stati membri di collaborare all’armonizzazione della legislazione esistente e, qualora essa non si dimostri adeguata, all’elaborazione di una legislazione specifica in materia a tutela dei diritti della persona, della sua integrità, della libertà di coscienza e del diritto alla salute (punto 2); si sollecita il coinvolgimento e la collaborazione delle comunità interessate per l’eliminazione di tali pratiche (punto 4); ed infine si chiede agli Stati membri di “considerare qualsiasi mutilazione genitale femminile come reato” (punto 11, primo trattino).
Il legislatore italiano, con la legge in commento, ha quindi raccolto gli inviti provenienti dai predetti atti internazionali – in particolare, dalla Dichiarazione e Piattaforma d’azione di Pechino, espressamente richiamata all’art. 1 l. in commento e più volte ricordata nel corso dei relativi lavori preparatori, nonché dalla risoluzione 2001/2035 del Parlamento europeo, anch’essa più volte menzionata in tali lavori – emanando “disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” (così l’epigrafe della nuova legge). Non essendo questa la sede per l’illustrazione delle nuove norme (artt. 2-5 e 7 l. in commento), dirette alla prevenzione delle MGF (consistenti principalmente in attività di informazione e formazione, con il coinvolgimento anche delle comunità straniere presso le quali tali pratiche sono tradizionalmente diffuse)[9], ci si concentra qui sulle sole norme di divieto, contenute all’art. 6 l. in commento, il quale, come anticipato, ha introdotto nel nostro codice penale l’art. 583- bis (che contempla i due nuovi reati) e l’art. 583- ter (che prevede per essi una speciale pena accessoria).
Il nostro legislatore, quindi, al pari di quanto già avvenuto in altri Paesi Occidentali, ha scelto di ricorrere a norme incriminatrici ad hoc per punire le MGF, ritenendo, per contro, inadeguate a tale scopo le norme “generali” in tema di lesioni personali ( artt. 582-583 c.p. ), alle cui previsioni le MGF sarebbero state comunque riconducibili[10]. È presumibile che sulla scelta del nostro legislatore di creare nuove figure di reato abbiano influito non solo l’opportunità di creare una “norma-manifesto”, che potesse rendere il disvalore del fatto più evidente e, conseguentemente, più agevole la sua denuncia (soprattutto da parte di operatori dei servizi sanitari o scolastici italiani, che vengano a contatto con donne o bambine mutilate), ma anche la preoccupazione di non punire troppo lievemente le MGF: le pene comminate per le lesioni gravi o gravissime – che secondo l’opinione maggioritaria costituiscono circostanze aggravanti del delitto di lesioni di cui all’art. 582 c.p. – avrebbero, infatti, potuto subire il “bilanciamento”, ex art. 69 c.p. , di eventuali attenuanti, così producendo livelli sanzionatori relativamente modesti[11].
Va, tuttavia, rilevato che la nuova incriminazione comporta il rischio di aumentare non solo l’ emarginazione di quelle comunità di immigrati, presso le quali le MGF sono tradizionalmente praticate, ma anche la clandestinità delle condotte collegate alle MGF: a parte, infatti, gli interventi mutilativi (che, se mai effettuati in Italia, avvengono già in condizioni di clandestinità), in futuro le donne mutilate potrebbero essere più restie a rivolgersi a strutture sanitarie “ufficiali” per fronteggiare le complicanze susseguenti all’intervento mutilativo (ad es., un’emorragia) o per sottoporsi a visite ginecologiche o per assistenza al parto, nel timore che il sanitario possa inoltrare referto all’autorità giudiziaria, con conseguenti indagini penali a carico di genitori, familiari o comunque connazionali[12]. D’altro canto, come ha osservato anche il Comitato nazionale di bioetica nel sopraccitato parere sulla circoncisione, “anche se formalmente irrinunciabile, la repressione penale si rivela di ben scarsa efficacia al fine di sradicare costumi e tradizioni dotate di ascendenze profonde nella cultura “di base” di molte popolazioni”[13].
Orbene, con l’art. 583- bis c.p. sono stati introdotti due nuovi delitti: al comma 1, infatti, si punisce, con la reclusione da 4 a 12 anni, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili; al comma 2, invece, si punisce, con la reclusione da 3 a 7 anni, chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Prima di procedere all’analisi di tali nuovi reati, va sottolineato ancora una volta – come del resto emerge in modo univoco dai lavori preparatori- che il fenomeno socio-criminologico che il legislatore italiano ha tenuto sotto gli occhi e ha inteso reprimere, è quello delle MGF, così come illustrato nei paragrafi precedenti sulla scorta dei dati forniti dall’OMS e degli atti adottati in sede sovranazionale. Di ciò occorre avere piena consapevolezza per approdare ad una corretta interpretazione dell’art. 583- bis c.p., la cui formulazione si rivela, invece, per alcuni versi incapace di delineare con precisione i fatti incriminati[14].
Nei sistemi occidentali in cui viviamo il diritto si è saputo ritagliare nel corso dei secoli uno spazio autonomo tanto rispetto alla sfera politica quanto a quella religiosa[15] . Nella sistemologia contemporanea perciò la tradizione giuridica occidentale viene contrapposta ai sistemi socialisti da un lato, a quelli a matrice religiosa dall’altro. Nel primo ambito si collocano tutte quelle organizzazioni istituzionali in cui il diritto e la politica si compenetrano
creando un solo circuito di scelte pubbliche. L’ ex unione sovietica è sicuramente l’esempio più importante ma, a ben vedere, una simile caratterizzazione è tipica di tutti i sistemi totalitari siano essi di ispirazione comunista (come la Cina) ovvero fascista in senso lato (si pensi a diverse epifanie dell’organizzazione latino-americana).
Esistono poi sistemi in cui a compenetrarsi intimamente sono il circuito religioso e quello giuridico o giuspolitico. In queste ipotesi il soprannaturale permea di sé le scelte istituzionali. Il diritto musulmano e quello indù sono gli esempi più importanti. In molti sistemi tradizionali africani la situazione non è però diversa. In questi ambiti il giurista ed il sacerdote si compenetrano in modo assai intimo rendendo indistinguibili le due figure professionali[16].
Nel mondo d’oggi, peraltro, questi sistemi a modello non occidentale sono tutti contaminati in varia misura da istituzioni, suggestioni e financo figure professionali a modello occidentale. Non siamo irresistibilmente portati a salutare tali contaminazioni – portato della circolazione dei modelli giuridici e culturali – come salutari forme di progresso. Siamo in altre parole fieri della tradizione giuridica sviluppatasi nelle democrazie occidentali in cui viviamo. Abbiamo osservato con preoccupazione lo stress cui la legalità è stata sottoposta in vari momenti storici in Germania come da noi. Il ripristino della legalità è il trionfo di una cultura giuridica separata da quella politica. Ciò di cui siam fieri, ciò che ha decretato nei secoli il «successo del giurista» è la stessa essenza della tradizione giuridica occidentale. Tale essenza non è agevolmente descrittibile se non comparando la nostra tradizione con quella delle teocrazie o dei sistemi totalitari. Ciò di cui siam fieri può rendersi con l’idea della «neutralità», dell’«imparzialità» dell’«uguaglianza di fronte alla legge» della «rule of law»… o di quant’altro rende l’idea di un circuito di scelte pubbliche sottratte dall’arbitrio del potere politico e di quello religioso. Tale essenza legittima nella nostra tradizione il giurista, l’individuo in carne ed ossa cui è demandato appunto il sistema delle scelte ricadenti nella sfera del giuridico[17].
Naturalmente è appena il caso di aggiungere che è corretto parlare di giurista e non di giudice proprio perché la cultura giuridica occidentale è il patrimonio comune di diverse categorie professionali i cui rapporti di potere variano da sistema a sistema. È un tale patrimonio sapienziale e tradizionale da cui attinge in concreto il magistrato che decide una controversia[18]. Per quale motivo preferiamo che una nostra controversia sia decisa da un giurista e non da un politico o da un sacerdote? Per quale motivo invochiamo il controllo di un giudice privo di qualsiasi legittimazione democratica nei confronti dell’attività politica ed amministrativa posta in essere da uomini politici legittimati da decine di migliaia di voti? Per quale motivo quando si vuole attaccare pubblicamente un magistrato lo si indica come «politico»? Per quale motivo si è cosí perplessi di fronte al desiderio di taluni magistrati di iscriversi a partiti politici e si considera una distorsione che in Italia le varie correnti della magistratura siano agevolmente riconducibili a partiti ed ideologie politiche? La ragione è invero assai banale. Riteniamo che il giudice meglio sia capace di farsi interprete di quella imparzialità che consideriamo un valore fondamentale della nostra organizzazione istituzionale[19]. Un politico non è neutrale perché potrebbe favorire i suoi compagni di partito. Chi basi le proprie scelte su una dottrina religiosa, a sua volta, non è neutrale perché segue un procedimento necessariamente discriminatorio nei confronti di dottrine ai suoi occhi devianti.
Nei sistemi a democrazia occidentale questi due atteggiamenti di parte sono banditi, o meglio sono incanalati in circuiti diversi rispetto a quello giuridico. Dopo tutto appare ovvio che in regime di suffragio universale all’uguaglianza politica che produce la legge debba corrispondere necessariamente l’uguaglianza di fronte alla legge cosí prodotta.
In quella che possiamo stipulativamente chiamare neutralità risiede dunque la chiave di legittimazione del giurista[20]. Egli ha saputo creare e diffondere un’ideologia che legittima sul piano scientifico, culturale e sapienziale le proprie scelte pubbliche.
Dal naturalismo, all’esegesi, al formalismo, al positivismo, il giurista si autolegittima sempre come mero «applicatore» di princìpi superiori esterni al suo foro intimo radicati nella natura delle cose, nelle scelte politiche operate da altri a monte, o nella tradizione[21]. Tale suo arroccarsi dietro ad una sorta di necessità più o meno stringente che guida le sue decisioni, è stato nella storia il segreto della sua sopravvivenza nei momenti di crisi politico-istituzionale profonda.
Come tutte le ideologie anche quella della neutralità del giurista ha dato frutti importanti e ha creato mostri.
Naturalmente gli episodi storici, dalla coraggiosa resistenza all’ascesa del Nazismo agli atteggiamenti men che nobili della cultura giuridica prima della guerra di secessione in America sono troppi e troppo noti sicché non è questa la sede né per discuterli né per evocarne elenchi esaustivi.
Sta di fatto tuttavia che nell’ultimo secolo non tutti hanno creduto all’ideologia della neutralità. Seppure straordinariamente vitale, essa è oggi quanto mai sotto attacco da parte di taluni dei più interessanti filoni del pensiero e della ricerca giuridica. Alcuni di questi tentativi di delegittimazione verranno qui ripercorsi senza alcuna pretesa di completezza al solo fine di indicare talune delle sfide piú impegnative che la cultura giuridica occidentale dovrà vincere per rilegittimarsi alle porte del nuovo millennio.
-
L’infanzia negata: l’obbligo al fatidico “sì”
Stime Onu indicano che ci sono circa 60 milioni di «spose bambine» nel mondo.
La morte di Fawziya Abdullah Youssef, una bambina di 12 anni, nello Yemen, l’11 settembre scorso per emorragia durante il parto, ha riacceso le polemiche contro la pratica diffusa in molti Paesi di dare in spose delle bambine. Una terribile pratica che è adottata in molti Paesi oltre allo Yemen.
Il Niger è al primo posto seguito da Ciad, Bangladesh, Mali, Guinea, Repubblica centrafricana, Nepal, Mozambico, Egitto, Uganda, Burkina Faso, India, Etiopia, Liberia, Yemen, Camerun, Eritrea, Malawi, Nicaragua, Nigeria, Zambia, l’Arabia Saudita e in Afghanistan. Purtroppo la lista non si chiude qui, gran parte del Medio Oriente resta fuori dalle statistiche e non è censito. Figlia della povertà, dell’ignoranza e dell’analfabetismo questi matrimoni spesso distruggono le vite di queste fanciulle.
Come detto, nutrirle, vestirle e istruirle costa troppo alle famiglie che incentivate economicamente sono spinte a darle in spose presto.
Nei Paesi in cui vige l’usanza che la donna porta con se, andando in sposa, una dote, come nel Sud dell’Asia, la famiglia dello sposo è disposta ad accettarne una più ridotta se la ragazza è molto giovane e questo costituisce altro motivo a spingere le famiglie più povere a dare le loro figlie in spose ancora ragazzine.
Da una ricerca condotta in Afghanistan, dove il 52 percento delle spose sono bambine, si evince che questi matrimoni vengono praticati soprattutto per saldare debiti.
All’età di 12 anni, normalmente i bambini vanno a scuola, giocano con i loro amici.
Questa ennesima tragedia ha evidenziato ancora una volta quanto questa tradizione nega invece l’infanzia a migliaia di bambine, e che nello Yemen, specie lungo la costa yemenita del Mar Rosso, è adottata coinvolgendo prevalentemente bambine al di sotto dei 15 anni.
Il marito è spesso un uomo molto più anziano, mai incontrato prima, a volte vedovo o un divorziato.
In Africa centrale e occidentale, un terzo delle «spose bambine» dichiarano che i mariti hanno almeno 11 anni più di loro.
In tutti gli altri Paesi ci sono casi in cui la differenza d’età è anche di decenni, a volte anche di 70 anni.
Quasi in tutti i Paesi menzionati hanno fissato per legge un’età minima per il matrimonio, molti a 18 anni. Però sono molti quelli che la ritengono anti islamica e cercano di contrastarla e soprattutto di non rispettarla. Nello Yemen e in Arabia Saudita in particolare sono attive diverse organizzazioni della società civile, in particolare movimenti femministi, che si battono per farla rispettare.
Queste organizzazioni non esitano ad intervenire quando vengono avvertite di un caso di matrimonio precoce. Nello Yemen la legge è stata approvata lo scorso febbraio e fissa a 17 anni l’età minima per il matrimonio.
Fino a poco tempo fa il vuoto normativo sulla materia non consentiva nel Paese alle autorità di impedire il matrimonio di uomini con spose bambine. Purtroppo però ancora non esistono leggi che permettono di punire i genitori e i mariti per le devastanti conseguenze di unioni di questo tipo.
I matrimoni precoci violano nel modo più deplorevole i diritti dei bambini[22]. Dopo aver denunciato la pratica dei matrimoni precoci, il direttore esecutivo dell’UNICEF sottolinea come più la bambina è giovane al momento in cui resta incinta, più sono alti i rischi per la salute sua e del suo bambino.
“Tragedie come questa, ha detto il dirigente, sottolineano la necessità urgente di tutelare meglio i diritti di donne e bambini, soprattutto bambine”.
“I matrimoni precoci sono spesso conseguenza di povertà e mancanza di istruzione. Bisogna fare di più per affrontarne le cause e prevenire morti tragiche come quelle di Fawziya e del suo bebè”[23]. La bambina era nata nello Yemen, cresciuta in una famiglia povera e con il padre gravemente malato di reni, era stata costretta a lasciare la scuola e a sposarsi quando aveva 11 anni. Un anno dopo era poi rimasta incinta.
Il bambino è nato morto.
La vicenda di Fawzia mette in risalto il dramma di quelle bambine che in molti ormai chiamiamo «le spose della morte», cioè quelle ragazzine che vengono date in spose dalle famiglie con la forza e molte delle volte solo per motivi economici.
L’ennesima tragedia quindi di una «sposa bambina» privata della sua infanzia per soddisfare le esigenze della sua famiglia che era in condizioni di estrema indigenza.
Lo Yemen è un Paese con una struttura tribale molto forte.
Situato nella penisola arabica ed è considerato tra i più poveri del mondo. Nelle zone rurali, le spose sono quasi per il 50 % delle ragazzine.
Un’usanza questa che ha conseguenze drammatiche su di loro. Esse non possono lasciare il marito perché non hanno i soldi per restituire la dote, e il divorzio è spesso considerato inaccettabile. Anche se nel 2008 un’altra bambina, sempre nello Yemen, Mohammad Ali Nojoud si è ribellata a tutto questo. Ali Nojoud a 8 anni, era stata costretta a sposare un uomo di 28 anni a cui l’aveva venduto il padre disoccupato.
Ma la piccola a 10 anni ha denunciato il padre e ottenuto il divorzio dal marito.
A seguire il suo caso l’avvocato Chaza Nasser che da allora è stata contattata da altre bambine incoraggiate da questo precedente ed è riuscita ancora una volta ad aiutare un’altra ragazza di 10 anni, Arwa, che ha anch’essa ottenuto il divorzio. Anche in Arabia Saudita un’altra bambina di 8 anni era stata sposata a sua insaputa ad un uomo di 50 anni.
Sua madre però si era rivolta al tribunale e, al termine di una battaglia legale durata 8 mesi, è riuscita lo scorso aprile ad ottenere l’annullamento del matrimonio.
Per la maggior parte delle piccole spose come loro però non c’è via d’uscita.
Però il problema più forte non è solo il matrimonio precoce, ma anche il parto precoce.
Secondo stime Onu ci sono circa 60 milioni di «spose bambine» nel mondo, e i tassi di maternità e neo-natalità tra di loro sono i più alti al mondo.
Su 100mila nascite, muoiono 365 donne di parto e 41 bambini nascono morti.
Le giovani madri di età inferiore a 15 sono quelle più a rischio. Il rischio di morire per complicazioni durante il parto è almeno cinque volte superiore a quello che corrono le donne di età compresa tra 20 e i 30 anni. Questo perché le «spose bambine» non sono fisicamente pronte alla gravidanza.
Quando non subentra la morte ci sono altre complicazioni: 2 milioni di «spose bambine» sono affette da fistole vescico-vaginali o retto-vaginali, in seguito a lacerazioni prodotte dalla pressione della testa del feto. Le fistole causano incontinenza. L’odore di urina che proviene dalla fistola è così forte che le ragazze sono piene di vergogna. Alla fine sono scansate, abbandonate dall’intera comunità e restano sole.
Nell’Africa sub-sahariana, inoltre, diversi studi mostrano che le bambine sposate hanno più probabilità di contrarre l’Aids rispetto a altre single e sessualmente attive. Spesso i mariti sono malati e loro non hanno il potere di negarsi o di chiedere loro di usare il preservativo.
L’intima connessione tra riservatezza e autodeterminazione è confermata dalle istanze degli adolescenti a vivere la loro vita sessuale. Terreno questo in cui l’eterno dilemma tra diritti fondamentali dei minori e diritti dei genitori ad educare i propri figli può assumere risvolti accesi e talvolta drammatici.
Il nostro ordinamento, nel segno dell’autonomia decisionale degli interessati, ha espressamente garantito con la L. n. 194 del 1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) una protezione alla sfera di riservatezza del minore anche nei confronti dei genitori in tema di contraccezione e di interruzione della gravidanza, senza peraltro specificare un’età prestabilita.
Al riguardo il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di chiarire in modo definitivo che un genitore non può accedere alla documentazione sanitaria della figlia minorenne che si rivolge ad un consultorio per farsi prescrivere farmaci contraccettivi[24]. Si tratta di un tema attualissimo perché di questa autonomia garantita ai minori sarà necessario tenere conto in tema di Fascicolo sanitario elettronico: l’architettura informatica dovrà essere in grado di garantire la possibilità per il minore di oscurare queste scelte agli occhi dei genitori[25].
La scelta legislativa di promozione della personalità è confermata dalla capacità riconosciuta alla donna minore di chiedere l’interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, anche contro la volontà dei genitori, con l’autorizzazione del giudice tutelare.
Appare evidente che a venire in rilievo non è solo la riservatezza, intesa nella sua accezione dinamica, ma il diritto alla salute in tutta la sua complessità, affidato alle decisioni e alle iniziative dei genitori. In via generale per rendere lecita l’ingerenza dei medici è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, e quindi la funzione di cura e protezione del minore[26]. Lo strumento sostitutivo trova naturale e inesorabile applicazione per il fatto che l’ordinamento considera il minore incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi, non solo di natura economica. Va tuttavia rafforzandosi, anche grazie a studi appassionati[27], il convincimento che il paziente minorenne debba essere coinvolto nel processo deliberativo finalizzato ad individuare il suo migliore interesse, ovviamente tenendo in considerazione la sua capacità di giudizio e di discernimento.
Sempre più criticabile appare, quindi, l’assenza, in ordine ai trattamenti sanitari dei cc.dd. “grandi minori”, di una disciplina univoca e chiara del consenso, che tenga ovviamente conto dell’effettivo processo evolutivo e della maturità del ragazzo[28]. Temi di straordinaria attualità ma inaffrontabili in questa sede, di fatto rimessi alla sensibilità dei giudici, in passato chiamati a contrastare con i provvedimenti previsti all’art. 333 c.c. scelte genitoriali contrarie all’interesse dei minori in tema di trasfusioni di sangue, rifiutate per convinzioni religiose, vaccinazioni obbligatorie, cure alternative in casi di leucemie e tumori. La linea di protezione giudiziale sembra oggi coinvolgere anche le scelte alimentari (ad es. diete vegane), pregiudizievoli ai fini di una crescita sana ed equilibrata dei bambini, specie se in tenera età.
Solo in specifici settori è il legislatore a farsi carico del problema. Nella disciplina sulla tossicodipendenza (art. 120, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), ad esempio, viene espressamente previsto che, qualora si tratti di persona minore d’età, la richiesta di intervento può essere effettuata personalmente dall’interessato, titolare di diritto alla segretezza anche nei confronti dei genitori.
Il riserbo è garantito anche dalla normativa sulla prevenzione e la cura dell’Aids dal momento che l’accertamento della sieropositività deve essere comunicato esclusivamente alla persona cui gli esami sono riferiti (L. 5 giugno 1990, n. 135, Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’Aids).
Di fronte alla complessità delle relazioni familiari e sociali la trama degli aspetti della personalità dei fanciulli meritevoli di considerazione giuridica diventa sempre più fitta. Il pensiero corre al diritto dei figli di autodeterminarsi sul piano spirituale e religioso e alla libertà di professare qualsiasi credo o di non avere credo alcuno (art. 14 Convenzione di New York)[29].
Anche in questo ambito, più che mai delicato perché attinente alla dimensione interiore, potrebbe emergere un contrasto tra genitori e figli nel caso in cui questi ultimi esprimano un sentimento di fede diverso dall’orientamento familiare. Il legislatore qui è intervenuto, ma in modo molto specifico[30], riconoscendo alla studente di Scuola secondaria superiore l’autonomia di scegliere se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (l’art. 1, L. 18 luglio 1986, n. 281, Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori). Ma in una società sempre più multiculturale la questione non è certo destinata ad esaurirsi all’interno della comunità scolastica; non è difficile immaginare casi in cui un adolescente, capace di comprendere le implicazioni delle proprie scelte, decida di divenire protagonista della sua vita, distaccandosi non solo dai convincimenti religiosi e filosofici dei genitori, ma più in generale dal contesto culturale del gruppo di appartenenza[31].
È sufficiente poi soffermarsi sui diritti di libertà associativa (art. 15 Convenzione di New York) e politica per arricchire il catalogo di nuovi interrogativi: possono i genitori vietare al figlio sedicenne di partecipare ad un corteo o ad una manifestazione? Possono precludergli l’iscrizione o la militanza ad un partito?[32].
Va ovviamente evitato il ricorso a schematizzazioni rigide e a risposte precostituite, è evidente che ancora una volta si tratterà di valorizzare la maturità dei grandi minori, garantendo loro la possibilità di compiere libere scelte cognitive e l’ingresso nel mondo delle relazioni giuridiche.
Non fantasiosa è poi la possibilità di decisioni contrastanti di fronte alle scelte scolastiche. Al riguardo si è opportunamente messo in luce come le attuali modalità di iscrizione, caratterizzate dalla dematerializzazione delle procedure amministrative, finiscano inevitabilmente col rendere la posizione del minore ancora più marginale, in stridente contrasto con l’attuale formulazione dell’art. 315 bis c.c., che invece ne valorizza solennemente le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni[33].
Anche in questo ambito le esigenze di autonomia dei ragazzi potranno essere impreziosite, tenendo ovviamente in considerazione il progetto educativo dei genitori, l’organizzazione del nucleo familiare e la disponibilità economica, solo se trovano il supporto di uno dei genitori. È noto come nella prassi dei Tribunali questo di fatto emerga solo al momento della disgregazione della coppia genitoriale[34].
Al di là degli specifici e frammentati interventi legislativi, per capire quale sia in concreto il catalogo dei poteri e doveri dei genitori, dei diritti e delle capacità dei minori, i settori di sostituzione e quelli di autonomia dobbiamo necessariamente confrontarci con la nuova nozione di responsabilità genitoriale, istituto che racchiude la funzione educativa e quella sostitutiva, la cura della persona e dei beni del minore. Tramontato il mitico dogma potestà-soggezione (che poi era un principio che scaturiva da un piano squisitamente patrimoniale, negoziale)[35], archiviata per sempre l’idea di un potere privato di supremazia, è necessario chiedersi se la nuova formula, suggestiva anche per la sua elegante vaghezza, implichi anche una rinnovata concezione della funzione pedagogica[36].
Risposta per nulla scontata perché il legislatore timoroso di addentrarsi nella misteriosa e imprevedibile scienza qual è l’arte di educare, che inevitabilmente si mescola con il groviglio dei rapporti umani e familiari, ha volutamente omesso di affrontare la questione definitoria, rinviando al costume e alle convenzioni sociali.
Le idee non sono destinate a chiarirsi se approfondiamo le posizioni dottrinali: c’è chi ritiene che la nozione di responsabilità genitoriale abbia una carica innovativa che investe l’intero diritto di famiglia e chi, invece, con toni critici, afferma si sia trattato di un semplice cambiamento terminologico, che non ha ridisegnato i contorni della potestà genitoriale. Addirittura il discorso pare oggi ancora più intricato rispetto al passato perché, secondo alcuni, sembra accogliersi l’idea di una responsabilità genitoriale suscettibile di perdurare anche dopo il raggiungimento della maggiore età[37].
Non possiamo purtroppo addentrarci nell’interessante dibattito, ai fini delle nostre riflessioni è sufficiente ribadire che il compito educativo deve ineludibilmente ispirarsi ai criteri oggettivi desunti dai principi costituzionali, primi fra tutti il rispetto della dignità e la promozione dello sviluppo del minore. Come già rammentato è penetrata, non solo nel linguaggio legislativo, la consapevolezza che la discrezionalità dei genitori trova il limite nel rispetto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni dei figli[38].
È innegabile che, anche a causa di un quadro normativo poco armonioso, prevalga oggi un senso di solitudine e smarrimento di fronte a problemi educativi, intercettato dalle c.d. Scuole di genitori, che proliferano oggi in Italia in modo virtuoso, ma incontrollato[39]. Recentemente è stato presentato al Senato un Disegno di legge avente lo scopo di promuovere “attività e misure di sostegno volte ad una diffusione dei diritti, dei doveri e degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale”.
L’attuazione di servizi (anche semplicemente informativi) di supporto alla genitorialità non può essere lasciata solo alla sensibile iniziativa dei privati, soprattutto non può diventare un business, ma deve trovare un riferimento in strutture pubbliche specializzate e competenti. Di fronte al necessario coinvolgimento di un vasto arco di strutture extrafamiliari (come i servizi sociali, i consultori, le scuole, le associazioni) preziosa e ineludibile diviene allora un’opera di coordinamento, che necessariamente dovrebbe essere svolta dal Garante per l’Infanzia e l’adolescenza.
Il Garante nazionale è una figura abbastanza recente, istituita con L. 12 luglio 2011, n. 112 per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali.
Le Regioni, come noto, sono state più fattive e solerti, il Veneto aveva già previsto una figura analoga con L. R. 9 agosto 1988, n. 42, l’Emilia Romagna con L. R. 17 febbraio 2005, n. 9.
Tornando al tema della rilevanza giuridica dei vari aspetti della personalità dei minori, credo che oggi possa, anzi debba, trovare posto una concezione del rapporto educativo che ammette ipotesi di conflitto come prassi normale, senza che questo implichi necessariamente una visione conflittuale della famiglia. Il percorso di crescita è, infatti, il risultato di un rapporto dialettico tra responsabilità genitoriale e concreta libertà di autodeterminazione del minore[40]. Una proficua azione educativa deve innanzi tutto essere basata sul dialogo e sull’ascolto e deve tendere, in armonia con quanto previsto dall’art. 29 della Convenzione di New York, ad uno sviluppo della personalità dei fanciulli.
Che la partecipazione dei fanciulli nei processi decisionali sia preziosa per una crescita armoniosa è, del resto, confermato all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Come accennato, da un’interpretazione sistematica della trama normativa non è possibile ricavare la previsione di un’azione diretta del minore volta a sollevare un conflitto con i genitori. Lacuna frutto della radicata ritrosia di fronte ad ingerenze nel progetto pedagogico familiare[41]. Del resto è comprensibile il timore che intrusioni nella vita intima della famiglia finiscano inevitabilmente per sminuire il ruolo dei genitori e per minare l’unità familiare. Per far valere le sue scelte e le sue ambizioni l’adolescente dovrà trovare un adulto (un genitore o, nel caso dei provvedimenti contemplati agli artt. 330 ss. c. c., anche un parente o il P.M.) disposto a fare da tramite nell’esercizio dell’azione giudiziale.
È evidente, tuttavia, che la via da seguire, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 13 della Convenzione di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti del fanciullo, non è quella dei Tribunali, anche se è innegabile che la giurisprudenza potrebbe di volta in volta contribuire ad individuare e impreziosire momenti di autonomia del minore.
Allontanato lo spettro del paternalismo giudiziario e l’applicazione rigida di regole giuridiche, peraltro in questo campo spesso inesistenti, va individuata una sede istituzionale in cui il ragazzo potrebbe far valere le sue istanze. Anche in questo caso è auspicabile un’evoluzione delle competenze attribuite ai Garanti regionali. Non si tratterebbe di attribuire semplicemente una funzione di ascolto e consulenza nella ponderazione dei valori insiti nel rapporto educativo, l’intervento legislativo dovrebbe spingersi ad attribuire al Garante regionale il potere di intervenire per comporre il dissidio tra genitori e figli. La delicata mediazione tra esigenze di protezione di soggetti in formazione (e per questo vulnerabili) e aspirazioni di autonomia dovrà ovviamente ispirarsi alla protezione dell’interesse e della dignità del minore in vista di un suo arricchimento spirituale e personale[42].
Nella costruzione di questa alleanza educativa dovranno essere ovviamente considerate le istanze di eterovalutazione dei genitori, senza trascurare la regola risarcitoria contemplata all’art. 2048 c.c., che prevede la responsabilità solidale e, nonostante i tentennamenti della giurisprudenza, oggettiva dei genitori per i danni cagionati ai terzi da fatti illeciti di figli minori.
La tutela del genere femminile : La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna
La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, è stata adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata in Italia con l. 14 marzo 1985, n. 132: in particolare, la Convenzione, all’art. 16, impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare le discriminazioni nei confronti della donna in ogni questione derivante dal matrimonio e nei rapporti familiari, e, dunque, ad assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome[43].
Detta Convenzione, invita gli Stati membri ad eliminare ogni discriminazione fondata sul sesso nella scelta del nome della famiglia, incompatibile col principio di uguaglianza, anche attraverso l’adozione di misure appropriate per garantire parità di trattamento tra madre e padre nell’attribuzione del cognome ai figli nati sia in costanza di matrimonio sia fuori dal medesimo.
La Corte europea di Strasburgo, nelle vicende sottoposte al suo esame, rinviene il fondamento della tutela del diritto al cognome nell’art. 8 della CEDU: in quanto mezzo di identificazione personale e di correlazione con una determinata famiglia, il nome di una persona riguarda anche la sua vita privata e familiare.
In ordine alla trasmissione del cognome, la Corte europea dei diritti umani ha mantenuto un atteggiamento di estrema prudenza, riconoscendo un ampio margine di discrezionalità agli Stati e vagliando il bilanciamento di interessi individuali e statali nella regolamentazione della materia[44]. Pur sostenendo il necessario rispetto del principio di parità tra uomo e donna e la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione da parte di quelle norme che, nell’attribuzione del cognome,contengono discriminazioni fondate sul sesso, la Corte è pervenuta ad una pronuncia di condanna degli Stati soltanto in due casi relativi al cognome coniugale[45]. Viceversa, essa non ha mai censurato le disposizioni nazionali sull’assegnazione del cognome al figlio e quelle introduttive di limiti al suo mutamento, adducendo sia la sussistenza di preminenti esigenze di pubblico interesse, sia l’assenza, in questa materia, di una disciplina comune ai vari Stati contraenti. Significativa, in proposito, è la pronuncia resa nel caso Stjerna[46], in cui, appunto, si esclude la violazione dell’art. 8 della CEDU: a seguito del rifiuto opposto dalle autorità finlandesi di accettare una richiesta di cambiamento del cognome di un cittadino, fondata su oggettive difficoltà di pronuncia dello stesso, la Corte ha affermato che, mentre l’imposizione di un nome a una persona da parte delle autorità statali rappresenta sicuramente una violazione dell’art. 8 della Convenzione, il divieto di concedere un cambiamento di cognome non costituisce necessariamente un’interferenza illegittima nel rispetto della vita privata. L’art. 8, infatti, contempla un diritto il cui esercizio può essere limitato da un’ingerenza della pubblica autorità, purché questa sia prevista dalla legge e “costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
I Paesi europei, negli ultimi anni, hanno adottato delle regole di trasmissione del cognome che, per un verso, abbandonano il principio dell’automatica attribuzione assegnando rilievo alla volontà dei genitori, per altro, rendono effettivo il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna, dando così attuazione alla Convenzione di New York del 18 settembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna[47].
Nonostante non vi sia allo stato attuale omogeneità nella regolamentazione della materia, possono essere individuati sostanzialmente due modelli: uno comune a Francia, Germania e Olanda, basato sull’attribuzione ai figli di un solo cognome, denominato familiare, scelto tra quelli dei genitori; l’altro, proprio degli Stati iberici, che assegna ai figli entrambi i cognomi e disciplina la scelta dell’unico da tramandare alle successive generazioni. Nei Paesi di Common Law, l’attribuzione del cognome non è regolata da specifiche disposizioni, ma è rimessa all’autonomia dei genitori investiti della parental responsibility: nella prassi si trasmette ai figli un unico cognome, individuato fra quelli materno e paterno, benché sia ammessa l’assegnazione di entrambi, ovvero anche di uno differente. Peraltro, ciascuno, una volta raggiunta la maggiore età, può, nel rispetto dei diritti acquisiti dai terzi, modificare il proprio cognome[48].
Il code civil francese, i cui articoli 311-321 sono stati novellati[49], consente ai genitori di scegliere se attribuire al figlio il cognome paterno o quello materno, ovvero entrambi i cognomi nell’ordine da loro stabilito, purché, nel caso di doppio cognome, sia trasmesso uno solo. In mancanza di dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile che menzioni la scelta del cognome del figlio, quest’ultimo assume il cognome del genitore nei cui riguardi la filiazione è stata per prima stabilita ed il cognome del padre se la filiazione è stata stabilita simultaneamente nei riguardi di entrambi. Il cognome attribuito al primo figlio con le suddette modalità si estende obbligatoriamente a tutti i figli comuni.
In Germania, già dal 1976, il par. 1355 BGB sanciva che al figlio fosse attribuito il cognome della famiglia, scelto dai coniugi esplicitamente tra il cognome del padre e quello della madre, al momento della celebrazione del matrimonio. In mancanza di un accordo, era prevista la prevalenza del cognome paterno per i figli comuni, mentre ai coniugi veniva lasciata la possibilità di aggiungere o di posporre al cognome comune quello proprio di nascita. La norma, tacciata di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, è stata più volte modificata. I vigenti par.par. 1616-1618 BGB dispongono che i coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale adottare ed assegnare alla prole. Il cognome coniugale può comunque essere preceduto o seguito dal proprio. Se i genitori non portano alcun cognome coniugale e la potestà spetta ad entrambi congiuntamente, ai figli viene assegnato il cognome del padre o della madre su intesa dei genitori, con dichiarazione resa davanti all’ufficiale dello stato civile. Se i genitori non raggiungono un accordo entro un mese dalla nascita del figlio, il tribunale richiede ad uno dei genitori di scegliere il cognome del bambino e può stabilire un termine entro il quale il genitore può esercitare il suo diritto di determinazione; se alla scadenza del termine tale scelta non è stata effettuata, il figlio riceve il cognome del genitore cui è stato trasferito il diritto di determinazione. Qualora i genitori non portino alcun cognome coniugale e la potestà genitoriale spetti ad uno solo, il figlio riceve il cognome che porta tale genitore al momento della nascita del figlio.
In Olanda, la nuova disciplina, introdotta con legge 19 novembre 1997, applicabile anche ai cosiddetti partners registrati, stabilisce che essi, ovvero i coniugi, scelgano di comune accordo il cognome dei figli, al momento della dichiarazione di nascita o anche prima. In mancanza di accordo, prevale il cognome del padre[50].
In Spagna, l’art. 109 còdigo civil, novellato dalla l. 5 novembre 1999 n. 40, ha affermato il principio del doppio cognome, disponendo che ai figli viene trasmesso il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato, tra i rispettivi primi cognomi. In caso di disaccordo, è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre. I figli stessi, una volta raggiunta la maggiore età, possono mutare l’ordine dei cognomi, anteponendo così il cognome della madre a quello del padre. L’ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio determina, nel momento dell’iscrizione nei registri dello stato civile, l’ordine dei cognomi anche per i figli successivi nati dallo stesso vincolo.
Pare potersi concludere che, da un lato, infatti, si pongono la Convenzione di New York del 1979, le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza nazionale che, al fine di assicurare la parità tra uomo e donna anche nella scelta del cognome, depongono a favore della regola della trasmissione di entrambi i cognomi o, quantomeno, della eliminazione di ogni automatismo in materia. In altra prospettiva si collocano le pronunce della Corte di Giustizia, le quali non si esprimono sulla regola da preferire in materia di assegnazione del cognome – non essendo la materia direttamente oggetto dell’ordinamento europeo – ma, in relazione alla possibilità che i diversi sistemi nazionali di trasmissione del cognome comportino discriminazioni in base alla nazionalità per i soggetti bipolidi, vieta, in quanto contrastante con i principi comunitari, l’imposizione, contro la volontà degli interessati, della normativa interna a rettifica dell’altra normativa nazionale. La sentenza in esame non si limita, come le precedenti pronunce in materia[51], a disapplicare, in ossequio agli artt. 12 e 17 del TCE, la disposizione interna a favore di quella brasiliana, scelta concordemente dai genitori, ma, col richiamare le disposizioni e l’orientamento giurisprudenziale in materia di parità tra uomo e donna, pare evidenziare che la trasmissione del cognome paterno e materno sia in ogni caso la regola preferibile. L’assegnazione del solo patronimico, al contrario, costituisce una previsione non più attuale né coerente con l’ordinamento sovranazionale e rappresenta una norma pressoché isolata rispetto alle legislazioni degli altri Stati europei.
Volume consigliato
Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
Fabio Piccioni | 2021 Maggioli Editore
22.00 € 20.90 €
Note
[1] Facchi, L’escissione: un caso giudiziario, in Contributi in tema di pluralismo giuridico, a cura di Cottino, Università degli Studi di Torino, 1992, 36-53.
[2] Faizang in AA.VV., Les mutilations du sexe des femmes aujourd’hui en France, Paris, 2014, 12.
[3] WHO, Female Genital Mutilation, Information Pack, in www.who.int/docstore/frh-whd/FGM/infopack/English/fgm_infopack.htm.
[4] D’Angelo, Documento di lavoro sulle MGF, in www.radicalparty.org/fgm/documentodilavoro.htm.
[5] WHO, op. cit., 22; Ricci, Le mutilazioni genitali femminili, in Arch. giur. 2003, 575.
[6] Come attesta il “Considerando” C della Risoluzione 2001/2035 del Parlamento europeo; Facchi, L’escissione: pratiche tradizionali e tutela delle minorenni, in Foro.it, 1996, 503.
[7] Bernardi, Minoranze culturali e diritto penale, in Foro.it, 2005, 1193.
[8] In G.U., 28 marzo 2002, n. C 77-E, 126.
[9] V’è, peraltro, da augurarsi che – una volta risolti i problemi di finanziamento di tali attività, considerati gli esigui stanziamenti predisposti dalla legge in esame – gli organi governativi italiani adottino un approccio con le comunità straniere meno etnocentrico di quanto accaduto in una precedente occasione: si veda, infatti, il cit. opuscolo in cui il Ministro per le Pari Opportunità – rivolgendosi direttamente proprio agli stranieri, presenti in Italia, provenienti da comunità all’interno delle quali le MGF sono sostenute da una tradizione plurimillenaria e da un complesso di motivazioni socio-culturali – con una certa indelicatezza definisce le MGF quali “pratiche crudeli e disumane” nonché “barbare”. Santoni, Donne e violenza: le MGF, in Meridione. Sud e nord del mondo, 2001, 71; Ricci, Mutilazioni, cit., 600.
[10] Cassano-Patrono, Il trattamento dell’infibulazione, in Dir. giust., 2003, 10, 99.
[11] A riprova di ciò, si segnala che nel d. d.l. n. 414 (successivamente accorpato al d.d.l. 414-B, che ha condotto alla legge in commento), le MGF comparivano come nuove ipotesi di lesioni gravissime (art. 583 comma 2 n. 4-bis nel d. d.l. n. 414 ), rispetto alle quali, tuttavia, per espressa previsione legislativa (art. 583 comma 3 nel d. d.l. 414 ), eventuali circostanze attenuanti non avrebbero potuto essere ritenute equivalenti o prevalenti.
[12] Pitch, Il trattamento giuridico delle MGF, in Quest. giust., 2001, 3, 508.
[13] Bernardi, Società, cit., 90, e Gargani, Libertà religiosa e precetto penale nei rapporti familiari, in Dir. eccl., 2003, 1037.
[14] Come rilevato già in sede di lavori preparatori: v. intervento Fassone, Commissioni 1° e 2° riunite, resoconto sommario n. 11 del 1° luglio 2004 (l’art. 583-bis “non fornisce alcuna definizione del concetto di mutilazione limitandosi, dopo alcune esemplificazioni, ad un’enunciazione di carattere meramente tautologico”).
[15] Berman, Law and Revolution, The Formation of the Western Legai Tradition (1983), 12.
[16] David, I grandi sistemi giuridici Contemporanei, tr. it., 1982, 52.
[17] Gambaro, Il successo del giurista, in Foro It., 1983, 121.
[18] Gambaro, op. ult. Cit.
[19] Cardozo, The Nature of The Judicial Process, 1921, 31.
[20] Barak, Judicial Discretion, 1989, 11.
[21] Stein-Shand, Legai Values in Western Society, 1973, 5 e segg.
[22] Veneman, direttore esecutivo dell’UNICEF, in www.unicef.it.
[23] Veneman, direttore esecutivo dell’UNICEF, cit.
[24] Newsletter Garante Privacy, 16 dicembre 2010, n. 344, doc. web n. 1772627.
[25] Thiene, Salute, riserbo e rimedio risarcitorio, in Riv. it. dir. med. leg., 2015, 1422.
[26] Stanzione – Sciancalepore, Minori e diritti fondamentali, Milano, 2006, 101 ss.; Lenti, Il consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni, in Rodotà – Zatti (diretto da), Trattato di Biodiritto, I diritti in medicina, Milano, 2011, 417 ss.
[27] Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, Padova, 2007, 168 ss.
[28] L’irresistibile fascino dei piercing e dei tatuaggi tra i giovani rende più che mai urgente un intervento legislativo che preveda regole generali per le marchiature artistiche del corpo riguardanti i minori. È vero che si tratta di attività non sanitarie, ma estetiche, non vanno tuttavia sottovalutati gli effetti collaterali gravemente pregiudizievoli per la salute (trasmissione di malattie infettive, pericolo di insorgenza di patologie allergiche). Il tema è approfondito da Piccinni, Il corpo artefatto: le “marchiature artistiche” tra integrità e autodeterminazione, in Rodotà – Zatti (diretto da), Trattato di Biodiritto, Il governo del corpo, Milano, 2011, 612 ss.
[29] Morozzo Della Rocca, Responsabilità genitoriale e libertà religiosa, in Dir. fam. pers., 2012, 1707 ss.
[30] Lillo, Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa, in Dir. pers. fam., 2009, 1949.
[31] Fucillo, Giustizia e religione, II, Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile, Torino, 2011, 169 ss.
[32] Moro, Manuale di diritto minorile, V ed., Bologna, 2014, 327 ss.
[33] Piccinni, La scelta della scuola, in Le relazioni tra Scuola, Famiglia e Minori nella legislazione vigente, a cura di M. Cerato – F. Turlon, Milano, 2017.
[34] Trib. Milano 4 febbraio 2015, in Foro.it, 2016, 801 ss., con nota critica di Tommaseo, Conflitti tra genitori sulla scelta della scuola: quali criteri ha il giudice per valutare l’interesse del minore?, che lamenta la mancata audizione del minore; Trib. min. Trieste 18 luglio 2011, in Dir. fam. pers., 2012, 765.
[35] Piccinni, I minori d’età, cit., 399.
[36] Bianca, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, I, 1 ss.; Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti nelle relazioni familiari, in Foro.it, 2013, 231 ss.; Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, 525 ss.; Graziosi, Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno uguali diritti dinanzi al tribunale ordinario, in Foro.it, 2013, 263 ss.
[37] Dosi, L’avvocato del minore, Torino, 2015, 94 ss.
[38] Senigaglia, Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013, 175.
[39] Dogliotti, I diritti del minore e la convenzione dell’ONU, in Dir. fam. pers., 1992, 301 ss.
[40] Zatti (diretto da), Trattato di Biodiritto, I diritti in medicina, Milano, 2011, 417 ss.
[41] Ruscello, Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento “pubblico”, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 717 ss.
[42] Piccinni, I minori d’età, cit., 415 ss. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, in Riv. dir. civ., 2016, 86 ss.
[43] cfr. il Patto adottato dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Esso, all’art. 3, prevede che gli Stati firmatari debbano garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel Patto e, all’art. 23, comma 4, impegna gli Stati parti del Patto a prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante lo stesso e al momento del suo scioglimento.
[44] Rossolillo, L’identità personale tra diritto internazionale privato e diritti dell’uomo, in Riv. dir. int., 2007, 1040 ss.
[45] Corte Eur. Dir. Uomo 16 febbraio 2005, Unal Teseli c. Turquie; Corte Eur. Dir. Uomo 24 gennaio 1994, Burghartz c. Suisse. Nella prima, la Corte si pronuncia nel senso dell’incompatibilità con gli articoli 8 e 14 della Convenzione delle disposizioni svizzere che, in caso di scelta del cognome del marito come cognome coniugale, consentivano alla moglie di aggiungere a questo il proprio cognome, mentre non prevedevano una simile possibilità per il marito, nel caso in cui il cognome coniugale scelto fosse stato quello della moglie. Nella seconda, la Corte ha dichiarato priva di qualsiasi giustificazione oggettiva e ragionevole, in quanto non necessaria per soddisfare esigenze di salvaguardia dell’unità familiare, la norma che imponeva alla donna, in caso di matrimonio, la perdita del cognome d’origine, e quella che, a seguito di recenti modifiche della legislazione turca, consente solo l’aggiunta di tale cognome a quello del marito.
[46] Corte Eur. Dir. Uomo, 24 novembre 1994 Stjerna v. Finland. Cfr. in senso analogo, 17 giugno 2003, Mustafa v.France.
[47] Autorino Stanzione, Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa – Il diritto comunitario ed il doppio cognome: un primato in espansione? in Corr. giur., 2009, 499 ss.: l’autrice afferma che le tendenze degli ultimi anni alla eliminazione di ogni tipo di discriminazione in ragione del sesso hanno condotto la maggior parte degli ordinamenti dell’area comunitaria a ribaltare il precedente modello, pressoché uniforme, con le eccezioni di Spagna e Portogallo, che vedeva rispettata la consuetudine della trasmissione ai figli del patronimico. De Cicco, La normativa sul cognome e l’eguaglianza tra genitori, in Rass. dir. civ., 1985, 968 ss.
[48] Bilò, I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in Familia, 2004, 831.
[49] La novella, entrata in vigore il 1° gennaio 2005 ed attuata con leggi del 4 marzo 2002, n. 304 e del 18 giugno 2003, n. 516, elimina la previgente trasmissione automatica del patronimico. La facoltà di aggiungere a quest’ultimo il cognome materno era prevista esclusivamente a titolo d’uso e senza alterazione alcuna dei meccanismi di acquisizione del nome legale. Furgiuele, Della recente novella al Code Civil in tema di eguaglianza fra coniugi, in Riv. dir. civ., 1986, I, 413 ss.
[50] Autorino Stanzione, Autonomia familiare cit., 503 ss.
[51] Trib. Napoli, 19 marzo 2008; Trib. Bologna 19 luglio 2005; Trib. Cagliari, 18 maggio 2005; Trib. Roma 15 ottobre 2004, in Corr. Giur., 2005, 677 ss., con nota di Barone-Calò, Il cognome dei soggetti bipolidinell’ordinamento comunitario; Trib. Bologna 9 giugno 2004, in Foro.it, 2004, 437 ss.



















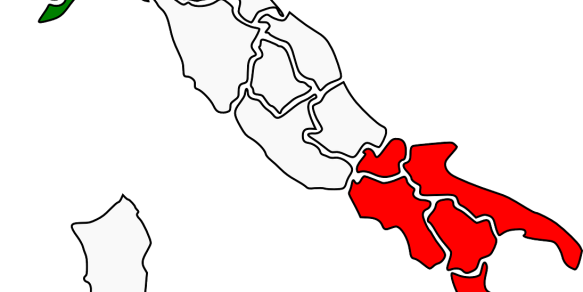


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento