(rigetto)
(Riferimento normativo: art. 2041 c.c. – art. 230 bis c.c. – art. 89 L. 19 maggio 1975 n. 151)
La vicenda
A seguito di ricorso promosso da una lavoratrice che assumeva aver prestato la propria attività lavorativa presso una società di capitali (srl) gestita dalla propria famiglia al fine di ottenere il relativo riconoscimento economico ex art. 230 bis c.c., il Giudice di Appello condannava la stessa società al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento della società e di ulteriori differenze retributive “non ricorrendo i presupposti dell’impresa familiare come dedotti in ricorso ma risultando comprovato, in base all’istruttoria esperita, il godimento, da parte della società stessa, dell’attività svolta dall’appellante nonché dell’arricchimento conseguente” per cui la società soccombente proponeva ricorso per Cassazione sollevando sul punto la contrarietà di tale decisione all’art. 2041 c.c. in tema di azione di arricchimento senza causa.
Volume consigliato
La prova nel processo del lavoro
L’opera, mediante un approccio pratico e operativo, affronta le diverse tipologie di prova all’interno del processo del lavoro.In particolare, i singoli mezzi vengono analizzati in relazione ai diversi tipi di procedimento nei quali possono essere utilizzati: dal primo grado, passando per l’appello, giungendo poi in Cassazione, nonché nell’ambito dei procedimenti sommari di cognizione.L’analisi della casistica, nonché delle concrete applicazioni degli strumenti probatori rende il volume un valido supporto al professionista che debba scegliere quali strumenti utilizzare e come impiegarli nel costruire la propria strategia difensiva.Particolare attenzione è dedicata alla consulenza tecnica d’ufficio, quale mezzo di prova sempre più largamente utilizzato nell’ambito lavoristico, specialmente con riguardo alle condotte discriminatorie del datore ai danni dei propri dipendenti.Massimo MarascaAttualmente magistrato fuori ruolo presso il MIT, già magistrato presso il Tribunale del Riesame di Roma, giudice del Tribunale di Civitavecchia e giudice del Tribunale di Sulmona.Manuela RinaldiAvvocato Cassazionista, dottore di ricerca in diritto del lavoro, docente d’area e tutor diritto del lavoro università telematica internazionale Uninettuno Facoltà di Economia e docente tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro università di Teramo Fac. Giurisprudenza – relatore in corsi e convegni- autore di pubblicazioni monografiche e collettanee.
Massimo Marasca, Manuela Rinaldi (a cura di) | 2021 Maggioli Editore
30.00 € 28.50 €
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte Suprema
La Corte di Cassazione, sul presupposto che nel caso di specie l’azione ex art. 230 bis c.c. come proposta originariamente dalla ricorrente non fosse praticabile “in considerazione dell’incompatibilità strutturale e normativa fra l’esercizio dell’impresa familiare e lo svolgimento di attività imprenditoriale nella forma della società di capitali”, riconosceva corretta e legittima la ricostruzione, anche in fatto, della vicenda processuale come operata dal Giudice di Appello ed ammetteva la configurabilità dell’azione di indebito arricchimento con riconoscimento del relativo indennizzo per l’attività prestata ed il vantaggio ricavatone dalla società ricorrente in una a delle differenze retributive, rigettandone pertanto il ricorso come proposto su questo specifico motivo.
Le riflessioni conclusive e gli spunti critici di riflessione
La conclusione di diritto enunciata da questa interessante ordinanza della Corte Suprema ci appare immediatamente in tutta la sua evidente perentorietà giuridica, oltretutto giunta a conferma di un processo evolutivo della giurisprudenza di legittimità che ha visto persino pronunciarsi, in senso conforme al presente orientamento, le Sezioni Unite della stessa Corte (1).
In definitiva, dunque, nel caso oggi esaminato a fronte, come abbiamo visto, di una azione esperita dalla “ lavoratrice” al fine di ottenere il giusto ristoro per l’apporto evidentemente prestato all’impresa di famiglia strutturata nella forma societaria di capitali, in sede di merito viene esclusa la configurabilità dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c. in presenza di una attività imprenditoriale svolta mediante società di capitali ed in applicazione del più generale principio del potere-dovere officioso del Giudice di adeguare la domanda proposta alla fattispecie di diritto effettivamente applicabile è stata ritenuta configurabile l’ipotesi dell’indebito arricchimento in capo alla medesima società con conseguente riconoscimento, in favore della ricorrente, del relativo indennizzo e di ulteriori “differenze retributive”.
Preliminarmente ad ogni altra considerazione, dobbiamo rilevare come la non diretta e completa conoscenza dei fatti e degli atti di causa ci impedisca, oggettivamente, di comprendere a fondo alcuni passaggi ed alcuni elementi della decisione adottata dai Giudici di merito, con particolare riguardo, ad esempio, alle modalità di “introduzione” nel petitum giudiziale della fattispecie, appunto, dell’arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., probabilmente riconducibile all’iniziativa della “lavoratrice” ovvero rimessa al potere officioso del Giudicante, nonché in ordine alle motivazioni poste a base del riconoscimento, in favore di quest’ultima, di quelle ulteriori “differenze retributive” di cui vi è menzione nella sentenza in commento.
Quanto al primo dubbio, sebbene la Cassazione faccia riferimento ad una esplicita richiesta della originaria ricorrente al riguardo, degna di nota è comunque l’affermazione esplicita secondo la quale presupposto per la proposizione dell’azione di arricchimento senza causa sia “la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un’azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie, determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall’arricchito (sul, punto, Cass. n. 843 del 17/01/2020)”.
Con riguardo, invece, al secondo dubbio, qualche perplessità effettivamente ci sorge in merito al fatto che, nonostante nella sentenza in commento vi sia una chiara esclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al punto che si è pervenuti ad una declaratoria di condanna al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c., vi sia stato comunque il riconoscimento, in favore della originaria ricorrente, di somme a titolo, come detto, di ulteriori “differenze retributive” così facendo apparire a chi legge che si riporti in qualche modo la fattispecie de qua nell’alveo, non del tutto chiaro, del rapporto di lavoro subordinato, peraltro confermato anche dal fatto che la pronuncia di legittimità sia stata emessa dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema.
L’incertezza in questione ci deriva anche e soprattutto dal fatto che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (2), oltretutto anche datato, l’istituto dell’impresa familiare è stato sempre visto come di natura residuale o suppletiva, proprio in quanto diretto ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgano nell’ambito di aggregati familiari e, dunque, dalla labile e non sempre facile individuazione effettiva, al punto che esso non possa configurarsi nell’ipotesi in cui il rapporto tra familiari sia riconducibile ad uno specifico rapporto giuridico quale è, appunto, quello di lavoro subordinato.
Ecco dunque perché il contemporaneo riconoscimento, in favore della “lavoratrice”, di un indennizzo ex art. 230 c.c. e di ulteriori “differenze retributive” di cui vi è testuale menzione nell’ordinanza in esame ci appare una evidente contraddizione in termini, salvo che la predetta espressione, che non a caso non compare in alcun modo nella medesima disposizione codicistica, non sia stata utilizzata dai Giudici in un significato semantico più ampio e generalizzato e non direttamente riconducibile al rapporto di lavoro propriamente inteso.
Superati, però, questi tentennamenti interpretativi, più che altro riconducibili ad un eccesso di approfondimento da parte nostra, il punto centrale della presente disamina risiede certamente nel principio di diritto ancora una volta ribadito dai Giudici di legittimità secondo il quale, come detto, “le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che l’esercizio dell’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria attesa non solo l’assenza nell’art. 230 bis c.c. di ogni previsione in tal senso, ma, soprattutto, l’irriducibilità ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario”.
In definitiva, dunque, la Corte sottolinea ancora come la strutturazione, personalistica e chiaramente ristretta, dell’impresa familiare propriamente detta mal si presti ad una sua gestione in forma delle società di capitali con conseguente e naturale incidenza di questo principio di fondo anche sugli aspetti economici e patrimoniali conseguenti, come nel caso che ci occupa, all’effettiva partecipazione di un soggetto, estraneo alla compagine sociale, allo svolgimento dell’attività imprenditoriale con il suo apporto lavorativo.
Naturalmente nel caso in commento la particolarità deriva dal fatto che il soggetto lavoratore sia legato evidentemente ai soci della srl da stretti rapporti familiari, sì da aver indotto le parti ad includere nella controversia le tematiche afferenti, appunto, l’impresa familiare, ma il problema in parola è molto più ampio e generalizzato e di fatto può riguardare anche tutti i casi in cui vi sia una prestazione lavorativa non sussumibile in un rapporto di lavoro subordinato per mancanza dei relativi presupposti e si debba comunque procedere alla quantificazione economica di tale apporto lavorativo e/o di collaborazione, non altrimenti determinabile in sede giudiziale se non proprio con l’azione generale e residuale dell’arricchimento per indebito o senza causa.
Il primo caposaldo cui la Corte riconduce il sopradetto suo principio è quello della mancanza nella disposizione normativa di cui all’art. 230 c.c. di qualsivoglia riferimento alla possibilità di espletare l’impresa familiare nelle forme della società di capitali, ma a nostro avviso, come giustamente rilevato sempre dalla Corte Suprema in altre pronunce (3) il divieto in questione prescinde dalla natura societaria per andare a colpire, più genericamente, il fatto stesso che un “lavoro familiare”, di per sé applicabile alle sole imprese individuali proprio per la rilevanza che in esso assume l’apporto personalistico del congiunto, sia incompatibile in assoluto con l’impresa collettiva in genere, e principalmente con quella societaria, essendo stata sempre esclusa la possibilità di una coesistenza, nell’ambito della medesima compagine, di due diversi rapporti, uno fondato su un contratto di società, qualunque forma questa assuma, e l’altro derivante da un vincolo familiare o di affinità.
Peraltro la Corte sul tema in passato è stata ancora più esplicita poiché ha affermato che “a prescindere dal problema più in generale relativo alla natura in sé societaria o meno dell’impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all’esterno come un rapporto societario…..manifestando palesemente, nei rapporti esterni, lo ”affectio societatis”, si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall’art. 230 bis c.c., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna…” (4).
Non si tratta, del resto, di distinzione di poco conto poiché si pensi soltanto all’effetto differente che determina il considerare sussistente una società di fatto in luogo dell’impresa familiare, in relazione, ad esempio, alle procedure concorsuali per la conseguente assoggettabilità a queste di tutti i soggetti individuati come facenti parte della prima.
E’ altresì significativo e determinante il fatto che nella pronuncia in commento la Corte Suprema abbia tenuto a precisare come “tale soluzione, inoltre, è coerente con una interpretazione teleologica della norma – introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 89) – che, come si evince dall’”incipit” dell’art. 230 bis c.c. (“salvo sia configurabile un diverso rapporto”), prefigura l’istituto dell’impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile” (5).
Non dobbiamo, infatti, mai tralasciare la stretta connessione esistente tra la disciplina codicistica dell’impresa familiare e la normativa speciale regolante il diritto di famiglia, poiché la Sezione VI del Titolo Sesto di cui fa parte la prima non a caso è stata introdotta proprio da detta ultima normativa speciale, come opportunamente ci ricordano anche i Giudici di legittimità.
Volume consigliato
La prova nel processo del lavoro
L’opera, mediante un approccio pratico e operativo, affronta le diverse tipologie di prova all’interno del processo del lavoro.In particolare, i singoli mezzi vengono analizzati in relazione ai diversi tipi di procedimento nei quali possono essere utilizzati: dal primo grado, passando per l’appello, giungendo poi in Cassazione, nonché nell’ambito dei procedimenti sommari di cognizione.L’analisi della casistica, nonché delle concrete applicazioni degli strumenti probatori rende il volume un valido supporto al professionista che debba scegliere quali strumenti utilizzare e come impiegarli nel costruire la propria strategia difensiva.Particolare attenzione è dedicata alla consulenza tecnica d’ufficio, quale mezzo di prova sempre più largamente utilizzato nell’ambito lavoristico, specialmente con riguardo alle condotte discriminatorie del datore ai danni dei propri dipendenti.Massimo MarascaAttualmente magistrato fuori ruolo presso il MIT, già magistrato presso il Tribunale del Riesame di Roma, giudice del Tribunale di Civitavecchia e giudice del Tribunale di Sulmona.Manuela RinaldiAvvocato Cassazionista, dottore di ricerca in diritto del lavoro, docente d’area e tutor diritto del lavoro università telematica internazionale Uninettuno Facoltà di Economia e docente tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro università di Teramo Fac. Giurisprudenza – relatore in corsi e convegni- autore di pubblicazioni monografiche e collettanee.
Massimo Marasca, Manuela Rinaldi (a cura di) | 2021 Maggioli Editore
30.00 € 28.50 €
Note
1- vedi Cassazione Civile – Sezioni Unite – sentenza n. n. 23676 del 06 novembre 2014
2- vedi Cassazione Civile – sentenza n. 7438 del 09 agosto 1997
3- vedi per tutte Cassazione Civile – Sezione Lavoro – sentenza n. 11881 del 06 agosto 2003 e, contra, Cassazione Civile – Sezione Lavoro – n. 19116 del 23 settembre 2004 e n. 13861 del 19 ottobre 2000
4- vedi Cassazione Civile – sentenza n. 3520 del 24 marzo 2000
5- sul carattere residuale dell’impresa familiare rispetto al rapporto di lavoro subordinato vedi anche Cassazione Civile – Sezione Lavoro – sentenza n. 19925 del 22 settembre 2014

















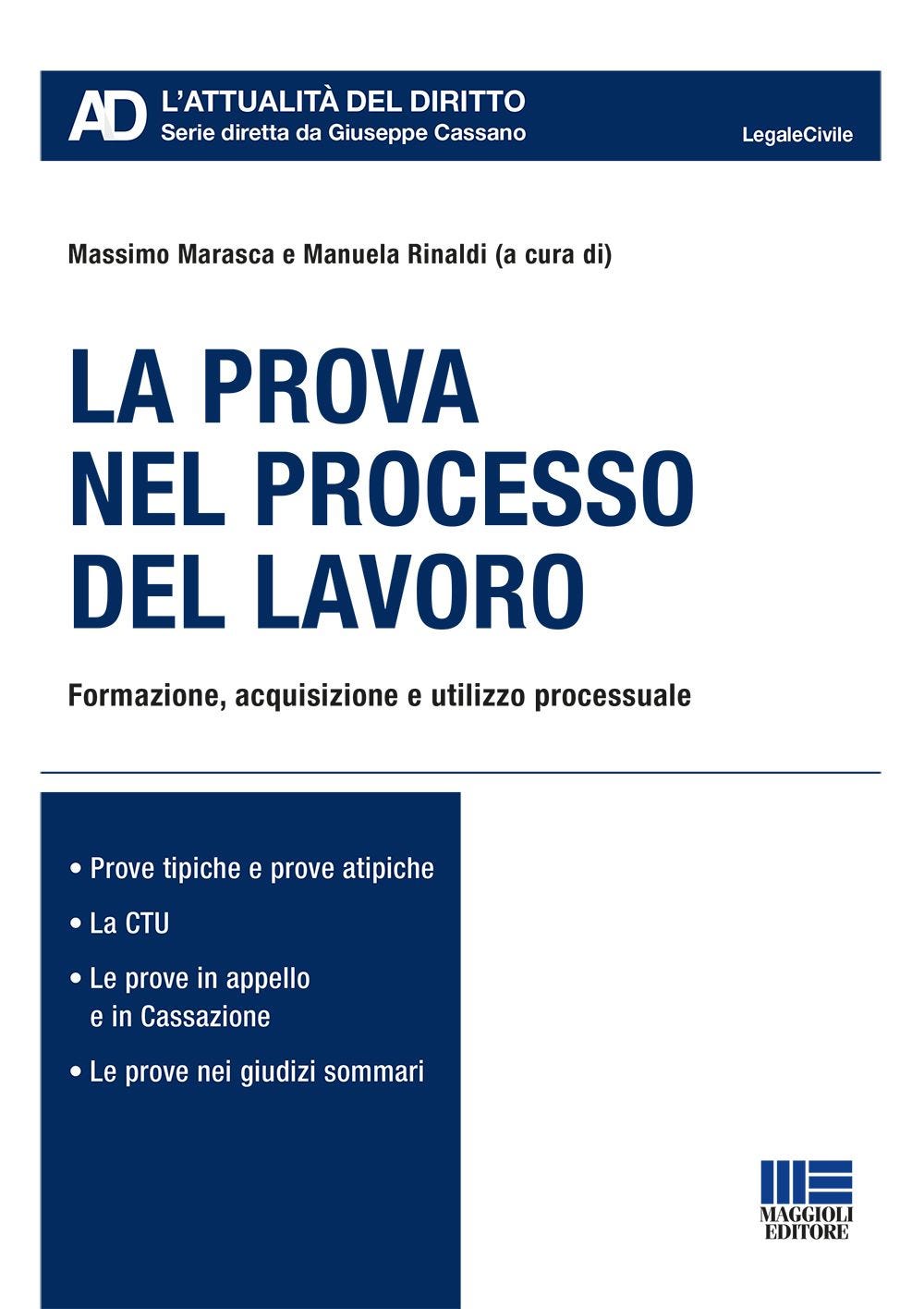




Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento