Il presente contributo è tratto da
I requisiti della legittima difesa
Pertanto, “la legittima difesa esige che il fatto sia commesso per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta” (8) e dunque la reazione legittima “deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (tra le altre, sez. I, n. 45425 del 25 ottobre 2005, dep. 15 dicembre 2005, omissis, Rv. 233352)” (9) ossia detta reazione: a) deve essere necessaria in quanto l’unica possibile, perché “non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto (proprio o altrui) aggredito” (10) e non ricorre quando lo stato di pericolo sia stato volontariamente determinato dall’aggredito (11); b) non è sostituibile “da altra meno dannosa ma ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell’aggredito” (12) fermo restando che “colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione” (13); c) deve essere proporzionata all’offesa e a questo proposito va rilevato che, fermo restando che il ricorso a questa scriminante non è giustificabile “quando l’offensiva si è esaurita” (14), “il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso (…) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (…), ed il danno inflitto con l’azione difensiva (…) abbia un’intensità e un’incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (…)” (15) (su come deve operare questa valutazione di proporzionalità, si rinvia a quanto verrà esposto nel paragrafo successivo). Invece, “non è configurabile l’esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa” (16) atteso che, come appena visto poco prima, “è configurabile l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione” (17) a nulla invece rileva “la prefigurazione in via ipotetica e congetturale di un’aggressione futura quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l’allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito” (18).
Il pericolo attuale, come visto anche prima nel paragrafo 2 del capitolo II, infatti, “costituisce l’elemento caratterizzante della difesa legittima, che consente di distinguerla sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa, sia dalla vendetta privata, sicché con la locuzione «pericolo attuale» si deve intendere un pericolo «presente», «in atto», «in corso», «incombente», con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora futuro (sez. I, n. 2771 del 19 gennaio 1984, omissis, Rv. 16333201)” (19) o quello immaginario (20).
Va rilevato al contempo che, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 62 c.p., comma 1, n. 2 (21) per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, è stato fatto presente, in sede di legittimità ordinaria, che “lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui, richiesto per la configurabilità della provocazione, consiste in un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non deve essere in rapporto di necessaria immediatezza col fatto ingiusto (sez. I n. 47840 del 14 novembre 2013, Rv. 258454): il dato temporale della provocazione, dunque, deve essere interpretato con elasticità (sez. I n. 16790 dell’8 aprile 2008, Rv. 240283), e l’immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, con riguardo alla situazione concreta, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell’attenuante e di frustarne la ratio (sez. V n. 8097 dell’11 gennaio 2007, Rv. 236541)” (22).
Sul punto:”Riforma della legittima difesa, cosa cambia?”
L’attenuante della provocazione
Tal che ne discende “che l’attenuante della provocazione può essere concretamente riconosciuta anche quando la reazione iraconda esploda a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante (anche, apparentemente, minore), quale effetto di un accumulo di rancore sedimentato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti (sez. I n. 51041 dell’8 ottobre 2013, Rv. 257877), configurando la provocazione c.d. «per accumulo»” (23). Pertanto, ove la difesa consegua non contestualmente all’offesa, ossia “laddove la reazione non abbia rappresentato un seguito immediato dell’offesa” (24), può comunque ricorrere questo elemento accidentale fermo restando che detta attenuante “pur non richiedendo un’esatta proporzione tra offesa e reazione postula l’esistenza di un nesso causale tra la prima e la seconda, di talché quando manca ogni rapporto di adeguatezza tra l’offesa e la reazione non è ravvisabile il predetto nesso (ex plurimis, Cass., sez. I, n. 1305 del 15 novembre 1993, omissis, rv. 197245).


















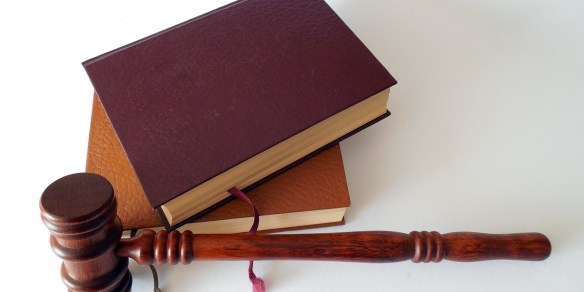


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento