Una recente pronuncia del Tribunale di Roma, XIII Sezione, del 29/03/2007, ha riportato all’attenzione degli operatori del diritto una questione che sembrava essere stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione e che può essere così formulata: nel rito del lavoro le parti sono tenute a citare i testimoni di cui si chiede l’ammissione per l’udienza di discussione, al fine di consentirne l’immediata assunzione da parte del giudice?
Prima di analizzare la soluzione prospettata dal giudice di merito è opportuno effettuare un breve riepilogo delle disposizioni normative che devono essere prese in considerazione:
– l’art. 420, 5° comma, c.p.c. prevede che il giudice “ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione”;
– l’art. 420, 6° comma, aggiunge che “Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive”;
– gli artt. 244 e seguenti del c.p.c., che dettano la disciplina “processuale” della prova testimoniale;
– l’art. 104 delle disp. att. c.p.c. che, al 1° comma, dispone che “Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova”.
Va preliminarmente ricordato anche che il rito del lavoro è stato pensato originariamente dal legislatore al fine di assicurare una rapida tutela dei diritti del lavoratore.
Gli strumenti principali utilizzati per conseguire tale risultato sono la prevalente oralità della procedimento, il divieto per il giudice di disporre udienze di mero rinvio, e la previsione per cui tutte le attività processuali, istruttoria compresa, dovrebbero, almeno in teoria, trovare completo svolgimento nell’ambito di un’unica udienza, e cioè l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c.
Ed in effetti, sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo letto l’art. 420 c.p.c. nel senso che le parti sono obbligate a citare per l’udienza di discussione i testimoni di cui si chiede l’ammissione: la Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 12 aprile 1983, n. 2586 osserva in particolare che tale onere “deriva alla parte dall’art. 420, comma 5, c.p.c., è cioè funzionale al rendere operante il potere del giudice di ammettere la prova ed assumerla nella medesima udienza e nella stessa udienza fissata per la discussione” e conseguentemente ritiene che la parte inadempiente incorra nella decadenza di cui all’art. 104 disp. att. c.p.c.
Tale orientamento ha trovato per lungo tempo consenso all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità: si segnala in particolare la sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, 13 aprile 1987, n. 3681, in cui si è fatto applicazione di tale principio anche in un caso in cui la causa era stata rinviata dalla prima ad una successiva udienza di discussione senza che il giudice avesse provveduto sulle istanze di ammissione dei testimoni.
La soluzione ora prospettata, anche se appare conforme alla lettera dell’art. 420 c.p.c., si pone tuttavia in contrasto con un dato normativo.
L’art. 250 c.p.c., nell’ambito della disciplina processual-civilistica della prova testimoniale, consente infatti l’intimazione a comparire unicamente di testimoni che siano stati preventivamente ammessi dal giudice; tale norma non può non trovare applicazione anche nel rito del lavoro, in assenza di una disciplina specifica dettata per la prova testimoniale in tale sede.
Anche sulla base di tale osservazione la giurisprudenza di legittimità aveva recentemente rivisto il proprio orientamento, con la sentenza della Cassazione, Sez. III, 16-04-1997, n. 3275.
Con tale pronuncia la Suprema Corte osserva che, oltre che sulla base del suddetto dato normativo, la soluzione fino a quel momento prospettata dalla giurisprudenza risultava criticabile anche un piano razionale e di buon senso.
Se si accoglie l’idea per cui la parte deve citare i testimoni per l’udienza di discussione, conseguentemente ogni qual volta tale udienza subisca un rinvio si dovrebbe rinnovare tale citazione, e i testimoni sarebbero costretti a comparire per tutto l’arco del giudizio senza avere la possibilità di sapere se dovranno essere effettivamente ascoltate ascoltati e quando il giudice, ascoltandoli o dichiarandone non necessario l’interrogatorio, li liberi da tale soggezione.
In questo modo, però, sottolinea la Cassazione, una regola originariamente dettata per rendere il più rapido possibile la tutela offerta dall’ordinamento al lavoratore, si trasformerebbe in un mero formalismo “giacché essa non può non ingenerare nei testimoni la resistenza a comparire inutilmente”; formalismo a cui tuttavia conseguirebbe la grave decadenza di cui all’art. 104 disp. att. c.p.c. laddove non rispettato, con compromissione di quegli stessi diritti che la norma voleva proteggere, atteso che esso verrebbe imposto anche a soggetti che spesso non hanno la capacità economica per sopportare tali attività processuali.
Per evitare simili conseguenze è quindi opportuno procedere ad una più adeguata interpretazione dell’art. 420, 5° e 6° comma, c.p.c.
Si può allora osservare che il 5° comma dell’art. 420 c.p.c. detta la regola generale che deve essere seguita per l’assunzione di qualsiasi prova nell’ambito del rito del lavoro, mentre il 6° comma individua la regola da seguirsi nel caso in cui la prima non possa trovare applicazione: in particolare tale ultima disposizione, quando afferma che “Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima” deve intendersi riferita sia al caso in cui il mezzo di prova non possa essere ammesso, nel qual caso le parti potranno essere autorizzate dal giudice anche al deposito di memorie prima della nuova udienza, sia al caso in cui la prova si ammessa ma non possa essere assunta.
Ecco che quindi dalla lettura combinata dell’art. 420, 5° e 6° comma, e 250 c.p.c. nel corso della prima udienza del rito del lavoro la prova testimoniale, dopo che sia stata ammessa, potrà essere immediatamente assunta solo nel caso in cui i testimoni siano presenti all’udienza stessa; in caso contrario, non essendo possibile ex art. 250 c.p.c. l’intimazione di testimoni che non siano stati preventivamente ammessi, il giudice dovrà fissare una nuova udienza.
A sostegno di tale soluzione si pone anche un’ulteriore importante osservazione, offerta dalla Cassazione nella sentenza n. 3275/1997: come si ricava da più disposizioni codicistiche (art. 175, comma 1, c.p.c.; art. 88, comma 1, c.p.c.; art. 157 comma 3, c.p.c.) il processo civile deve svolgersi al tempo stesso in modo ordinato, sollecito e leale; valori, di cui deve essere assicurato un adeguato bilanciamento.
La soluzione da ultimo prospettata appare allora la più adeguata ad assicurare tale bilanciamento poiché solo parzialmente incide sul valore dello svolgimento sollecito del processo civile, che può essere comunque recuperato attraverso una corretta applicazione del 6° comma dell’art. 420 c.p.c; diversamente i valori di uno svolgimento ordinato e leale del processo appaiono irrimediabilmente compromessi dall’interpretazione inizialmente offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
Afferma la Cassazione, infatti, che ritenere che le parti debbano a pena di decadenza citare i testimoni per la prima udienza di discussione rende del tutto aleatoria la posizione delle stesse, perché essa viene a dipendere da un evento imprevedibile costituito dal complessivo svolgimento dell’udienza e dalla possibilità che il giudice abbia la disponibilità di tempo per interrogare in quell’udienza i testimoni, cosicché alla parte viene ad essere imposto di tenere un comportamento allo scopo effettivo di evitare un rischio, quella di decadenza dalla prova, e non di esercitare un diritto, quello di vederla assumere.
Il principio di diritto formulato dalla Cassazione con la sentenza n. 3275/1997 è quindi il seguente: “Nei giudizi che si svolgono secondo il rito speciale delle controversie di lavoro, il giudice che, nell’udienza fissata per la discussione, ammette la prova per testimoni ne dispone l’immediata assunzione in quanto ciò sia reso possibile dalla presenza delle persone da interrogare; diversamente fissa altra udienza a norma dell’art. 420, comma 6, c.p.c., per la quale la parte ha l’onere, sanzionato dalla decadenza preveduta dall’art. 104, comma 1, disp. trans. c.p.c., di chiedere l’intimazione dei testimoni ammessi secondo la disposizione dettata dall’art. 250 c.p.c.”.
Con la recente pronuncia della XIII Sezione del Tribunale di Roma tale soluzione, sicuramente più razionale ed ispirata ad una lettura sistematica delle norme del codice di procedura civile, è stata, dopo dieci anni, nuovamente messa in discussione, senza che di ciò se ne sentisse davvero il bisogno.
Il giudice di merito, infatti, liquida la soluzione prospettata da ultimo dalla Cassazione sulla base di due considerazioni: la prima è che se fosse consentito alle parti di omettere di intimare i testimoni per l’udienza di discussione, il rito del lavoro non potrebbe mai concludersi con la prima udienza di discussione, atteso che il giudice dovrebbe sempre rinviare per l’assunzione della prova; la seconda è che tale orientamento sarebbe in contrasto con il nuovo testo dell’art. 111 Cost., in quanto non in grado di garantire maggiore celerità al processo.
È in primo luogo evidente come tale pronuncia del Tribunale di Roma crei in coloro che concretamente operino quotidianamente nel diritto uno stato di assoluta incertezza in tutti i casi in cui ci si intenda avvalere della prova testimoniale nel rito del lavoro: è prevedibile, infatti, che si crei un contrasto giurisprudenziale non solo tra le singole Sezioni del Tribunale di Roma, ma anche, all’interno di ognuna di esse, tra i singoli Giudici.
Tutto ciò a discapito sia dell’uguaglianza tra i cittadini, sia della certezza del diritto, sia di quell’interesse che la stessa sentenza del Tribunale di Roma intenderebbe tutelare, e cioè la rapida definizione delle controversie: è evidente, infatti, che tutte le parti che verranno dichiarate decadute dalla prova testimoniale per non aver citato i testimoni per la prima udienza nel rito del lavoro ricorreranno in Cassazione, facendo valere l’orientamento da essa stessa accolta con la sentenza n. 3275/1997.
Non deve poi trascurarsi come la proposizione di tali ricorsi determinerà anche un ulteriore appesantimento del carico di lavoro della Cassazione, contribuendo a rallentare in generale i tempi di definizione delle controversie.
Si può allora affermare che pur essendo il nostro un ordinamento ispirato al principio della libera interpretazione della legge da parte del singolo giudice, che non è vincolato dal precedente come avviene nei sistemi di common law, sono sicuramente da deprecare tutte quelle pronunce con cui singoli giudici di merito si discostano da orientamenti consolidati della Corte di Cassazione, senza addurre validi motivi a giustificazione di ciò.
La sentenza del Tribunale di Roma, infatti, non fa altro che riportarsi al precedente orientamento della Cassazione in materia, abbandonato con la sentenza n. 3275/1997, dalla quale, peraltro, non si riscontrano successivi discostamenti da parte della stessa Cassazione.
Ed, infatti, le argomentazioni utilizzate dalla Cassazione nella sentenza n. 3275/1995 per abbandonare il proprio precedente orientamento, possono essere integralmente riutilizzate per criticare il contenuto della pronuncia del Tribunale di Roma XIII Sezione, del 29/03/2007.
In conclusione la speranza è che la segnalata pronuncia del Tribunale di Roma possa restare un episodio isolato e che nella giurisprudenza di merito resti fermo il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 3275/1995; in caso contrario ancora una volta ci si dovrà affidare alle Sezioni Unite per dirimere l’ennesimo contrasto giurisprudenziale.


















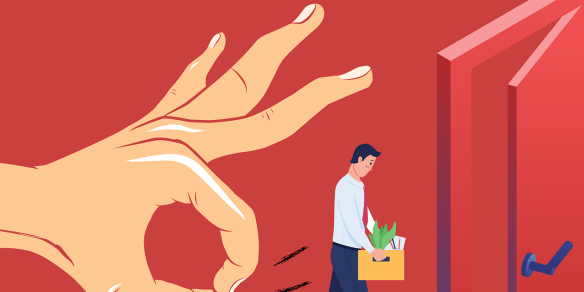
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento