I fatti di causa
Con la Sentenza n. 22375/2017 gli Ermellini sono tornati sulla questione relativa alla configurabilità del licenziamento per giusta causa in caso di denuncia da parte del lavoratore di fatti di potenziale rilievo penale. In particolare, la sentenza de qua interviene sul caso di una lavoratrice, la quale aveva fatto ricorso all’autorità giudiziaria onde ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla società datrice di lavoro, con la conseguente richiesta di reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno quantificato in misura pari alle retribuzioni (oltreché dei contributi previdenziali ed assistenziali) maturate dalla data del recesso sino a quella effettiva di riammissione in servizio.
Il licenziamento sarebbe stato invero l’effetto della denuncia presentata dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro per Maltrattamenti; Lesione personale; Violenza privata e Minaccia.
Le fasi di merito e il giudizio di legittimità
Il ricorso, originariamente accolto dal giudice di primo grado, era stato poi integralmente riformato dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto il licenziamento come giusta “reazione” alla condotta posta in essere dalla ricorrente, tale da legittimare la cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo la Corte territoriale, infatti, la condotta della lavoratrice era stata idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e tanto grave dal punto di vista oggettivo e soggettivo da far escludere che una sanzione conservativa potesse consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando che dalla condotta della lavoratrice non fosse derivato alcun danno all’immagine della società.
Volume consigliato
La Suprema Corte ha ritenuto al contrario, di dover dare continuità all’orientamento già adottato in casi analoghi, e quindi, escludere che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell’azienda potesse integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a condizione che, in primis, non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima (che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e quindi la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi) e, in secondo luogo, che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.
Va escluso, prosegue la Corte, che l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. possa estendersi al punto di imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all’interno dell’azienda, “giacchè in tal caso si correrebbe il rischio di scivolare verso non voluti, ma impliciti riconoscimenti di una sorta di dovere di omertà che non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento”.
Sulla scorta di siffatte considerazioni deve escludersi che, nell’ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all’autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti fattispecie di reato possa essere fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’iniziativa sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità dell’incolpato.
La Suprema Corte quindi, nel censurare il ragionamento logico seguito dalla Corte d’Appello hanno precisato che il Giudice di seconde cure ha tenuto conto del solo fatto che le accuse si fossero rivelate infondate e che il procedimento penale si fosse concluso con l’archiviazione della notitia criminis, omettendo di accertare e di valutare gli aspetti concreti della vicenda dedotta in giudizio, afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, all’eventuale deterioramento delle relazioni instauratesi nel tempo precedente alla presentazione della denuncia, al contesto fattuale nel quale era maturata la decisione della lavoratrice di rivolgersi al giudice penale, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni affidate alla lavoratrice, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi nonché all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo, il tutto tenendo conto del principio secondo il quale le disposizioni contenute nei contratti collettivi in punto di tipizzazioni degli illeciti disciplinari non possono essere disattese dal giudice.
Osservazioni
In relazione alla fattispecie sopra esaminata si fa osservare che la decisione in esame è coerente non solo con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma altresì si porrebbe in linea di continuità con la legge, recentemente approvata dalla Camera dei deputati e riguardante i c.d. “Whistleblower”.
Tale termine, di origine anglosassone che letteralmente significa “suonatori di fischietto”, è utilizzato per identificare da un lato il soggetto che lavora in un ente, sia pubblico che privato, che denuncia fatti penalmente rilevanti avvenuti nell’ambito lavorativo, e dall’altro le misure volte a proteggere gli autori delle suddette segnalazioni.
La protezione dei “Whistleblower” rimasta pressoché sconosciuta all’ordinamento italiano, è in realtà prevista in numerosi atti internazionali (cfr. ex multis La Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione, ratificate in Italia con le leggi 116/2009 e 112/2012).
Ciò nonostante, in Italia, prima dell’approvazione della proposta di legge dello scorso 15 novembre, una tutela dei segnalatori di illeciti era prevista solo nell’ambito bancario e degli intermediari finanziari e a grandi linee nell’ambito della pubblica amministrazione.
Invero, la Legge Severino del 2012, aveva già introdotto, sebbene limitatamente alla Pubblica Amministrazione, la norma (art. 54 bis al D. Lgs n. 165/2001 c.d. T.U. sul Pubblico Impiego) con il quale si disciplinava una generale protezione del dipendente che segnalava illeciti di cui sia venuto a conoscenza in quanto dipendente pubblico.
La legge in esame prevede, quindi, una modifica del suddetto art. 54 bis stabilendo che il dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente o all’ Autorità Nazionale Anticorruzione o denunci all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile condotte illecite o abusi conosciuti in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere soggetto a sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposto ad altre misure che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro a causa della segnalazione stessa.
Ma le novità non finiscono qui!
Invero, il nuovo testo di legge non solo amplia la definizione di dipendente pubblico – in modo tale da ricomprendere oltre che i dipendenti della P.A. anche i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e i lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere a favore della pubblica amministrazione – ma prevede altresì ulteriori garanzie, come il divieto di rivelare l’identità del segnalante e la sottrazione della segnalazione all’accesso amministrativo agli atti disciplinato dalla legge 241/1990, affidando il controllo all’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha il compito di irrogare sanzioni laddove accerti che siano adottate dalle amministrazioni misure discriminatorie nei confronti del dipendente segnalante.
L’auspicio è che, attraverso interventi mirati, sia del legislatore ma anche di ANAC e dell’Autorità Garante dei dati personali, vengano adottati gli opportuni accorgimenti sia per rendere effettive le tutele che per evitare l’abuso dello strumento così introdotto dalla nuova legge.
Leggi anche Il licenziamento del socio lavoratore


















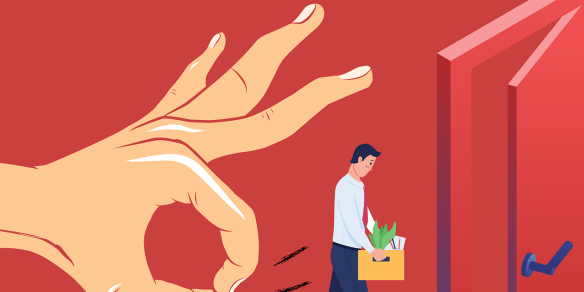


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento