(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 270)
Il fatto
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, dichiarata l’estinzione per prescrizione degli altri reati per i quali in primo grado era intervenuta condanna, confermava la condanna di uno degli imputati per i reati di peculato e di falsità ideologica e materiale in atto pubblico (capo 72: fatti commessi il 26 ottobre 2010), e dell’altro per i reati di falsità ideologica in atto pubblico (contestati come violazione dell’art. 480 cod. pen., ma qualificati nelle sentenze di merito come falsità ideologica in atti pubblici ai sensi dell’art. 479 cod. pen.).
I motivi proposti nel ricorso per Cassazione
Avverso questa decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei loro legali, adducendo i seguenti motivi.
Uno di questi formulava le seguenti doglianze: a) inosservanza degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. posto che la sentenza impugnata aveva respinto il motivo di appello con cui era stato contestato il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale di Bergamo dell’eccezione di inutilizzabilità delle captazioni sebbene i delitti contestati fossero stato oggetto di un “diverso procedimento” ex art. 270 cod. proc. pen. e, per essi, non era previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; in particolare, veniva rilevato che, per giustificare l’uso probatorio dei risultati delle captazioni, il giudice di primo grado aveva ravvisato un collegamento probatorio e investigativo tra i reati per i quali erano state autorizzate le intercettazioni e quelli di cui al capo 72) ma, nel caso di specie, non esisteva, ad esempio, alcun nesso tra il delitto di peculato ipotizzato con riferimento all’appropriazione del denaro dell’arrestato S. e le intercettazioni disposte nel procedimento relativo a V. P. per il reato di cui all’art. 326 cod. pen., anche considerando che dette intercettazioni avevano indotto a sospettare un coinvolgimento dei Carabinieri il che poteva riguardare il delitto di cui al capo 3) ma non rendeva legittimo l’uso di quelle intercettazioni in qualsiasi reato ipoteticamente ascrivibile ai Carabinieri stessi; oltre a ciò, veniva altresì rilevato che l’ulteriore argomento sviluppato dal Tribunale di Bergamo per ritenere utilizzabili le intercettazioni, secondo cui i risultati di tale mezzo di ricerca della prova avevano fornito la notitia criminis in ordine agli ulteriori fatti, permettendo una successiva autonoma attività di captazione così come non veniva considerato che le originarie intercettazioni avrebbero potuto costituire solo l’inizio di una nuova indagine laddove la Corte di appello, rigettando l’eccezione, aveva fatto erroneamente riferimento ad una mera diversa qualificazione dei fatti, mentre, nel caso di specie, non veniva in rilievo una diversa qualificazione ma fatti del tutto eterogenei rispetto a quelli per i quali erano state autorizzate le intercettazioni e dunque, alla stregua di quanto sin qui esposto, se ne faceva conseguire come l’inutilizzabilità delle intercettazioni avrebbe vanificato l’impianto accusatorio superando ogni possibile prova di resistenza; b) vizi di motivazione in quanto, a fondamento della conferma dell’affermazione di responsabilità penale per il capo in esame, la Corte di appello aveva valorizzato alcuni elementi (la sottoscrizione da parte del ricorrente dei verbali di arresto, perquisizione e sequestro; il riconoscimento nei suoi confronti di S.; la partecipazione alla perquisizione e all’arresto) relativi a circostanze non contestate e prive di valenza indiziaria; la conversazione tra G. e Q., difatti, ad avviso del ricorrente, non era dimostrativa dell’effettivo coinvolgimento di C. mentre costituiva un dato neutro la circostanza che, durante il conteggio della somma sequestrata in caserma, S. avesse timidamente tentato di contestare l’importo, senza rilievi da parte di C. fermo restando che, in ogni caso, la sentenza impugnata non aveva considerato la scarsa credibilità di S., né era stato adeguatamente valutato il fatto che un imputato accusato da S. in un diverso procedimento era stato assolto per l’inaffidabilità del dichiarante; c) vizi di motivazione poiché l’accoglimento delle doglianze relative alla condotta distruttiva avrebbe dovuto escludere qualsiasi dolosa falsità ideologica mentre, per quanto riguarda il falso materiale relativo all’apposizione, da parte di C., della firma di Q. nei verbali, la Corte di appello valorizzava una conversazione che aveva ad oggetto un fatto futuro ma che non dimostrava il suo effettivo accadimento, tanto più che non era stata disposta alcuna perizia sulla genuinità della firma di Q..
Con un secondo ricorso venivano addotti anche i seguenti motivi: 1) inosservanza dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, per l’impugnante, gli indizi valorizzati dalla Corte di appello non risultavano essere gravi, ma generici e non univoci; nel dettaglio, si faceva presente come la sottoscrizione dei verbali da parte di C. e il suo riconoscimento da parte di S. fossero stati carenti di qualsiasi valore indiziante così come la conversazione tra Q. e G., riferibile alla sola operazione di polizia giudiziaria e non accompagnata dalla prova di accordi criminosi desunti da conversazioni precedenti o successive mentre, da un lato, la partecipazione di C. alla perquisizione e all’arresto era intervenuta quando la perquisizione ed il conseguente rinvenimento del denaro erano già avvenuti, dall’altro, quanto alle domande di S. sull’ammontare del denaro sequestrato al momento del suo conteggio, la Corte di appello non aveva considerato né che S. si era limitato a riferire di una timida richiesta all’appuntato R., né l’obiettiva inattendibilità del teste, da un altro lato ancora, quanto alla conversazione tra Q. e C., la Corte di appello non aveva considerato una conversazione precedente tra il primo e R., nella quale Q. aveva formulato la stessa richiesta di firmare per lui; 2) vizi di motivazione in riferimento all’assenza di argomentazioni logiche o di massime di esperienza idonee a giustificare la valutazione del giudice di appello e a garantire l’osservanza della regola di giudizio di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; 3) inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. in riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell’ambito di un procedimento diverso, relativo ad ipotesi di reato ulteriori e diverse rispetto a quelle per le quali le intercettazioni erano state autorizzate facendo erroneamente riferimento ad un mero mutamento della qualificazione giuridica dei fatti; 4) in relazione alle imputazioni di falso, inosservanza degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen. in riferimento all’erronea affermazione che il termine di prescrizione per i fatti accaduti il 26 ottobre 2010 sarebbe decorso dopo le ore 24 del 26 aprile 2018, giorno della sentenza di appello laddove doveva aversi riguardo proprio a quel giorno in cui scadeva il termine di anni sette e mesi sei; 5) inosservanza dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. in riferimento alla declaratoria di tardività dei motivi nuovi o aggiunti (compresivi di una richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) depositati in data 11/04/2018 in vista dell’udienza del 26/04/2018.
A sua volta l’altro imputato, per mezzo del suo difensore, denunciava l’inosservanza dell’art. 547 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della sentenza di appello in punto di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado visto che, per un verso, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto l’imputata colpevole del reato di cui all’art. 479 cod. pen., a fronte della contestazione di una falsità ideologica in certificazioni ex art. 480 cod. pen., senza che di tale diversa qualificazione giuridica fosse stato dato atto nel dispositivo, per altro verso, la Corte di appello si era limitata a rilevare che, in mancanza di appello del pubblico ministero, la pena non poteva essere modificata non ponendo rimedio al contrasto tra motivazione e dispositivo mentre avrebbe dovuto dare prevalenza a quest’ultimo inquadrando il fatto nella fattispecie di cui all’art. 480 cod. pen., reato per la quale era ormai decorso il termine di prescrizione.
La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione
Investita della cognizione dei ricorsi, la Sesta Sezione penale, con ordinanza n. 11160 del 13/02/2019, li aveva rimessi alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare in questo provvedimento, dopo essere stata fatta un’accurata disamina della fattispecie concreta, ci si soffermava sul contrasto rinvenuto nella giurisprudenza di legittimità in ordine a quanto previsto dall’art. 270 c.p.p..
Difatti, secondo un primo orientamento, deve essere privilegiata una nozione di tipo strutturale e non formale di diverso procedimento e che dunque non consideri tanto l’aspetto estrinseco della separazione e del numero di iscrizione, ma quello sostanziale (Sez. 6, n. 11472 del 2/12/2009, dep. 2010) con la conseguenza che il procedimento è da considerarsi «identico quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico» (Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012).
Invece, secondo un secondo orientamento, a fronte di un provvedimento autorizzativo legittimamente emesso per uno dei reati contemplati dall’art. 266 cod. proc. pen., le operazioni di intercettazione devono considerarsi utilizzabili per tutti i reati relativi al medesimo procedimento, in tal senso dovendosi valutare quanto desumibile dall’art. 271 cod. proc. pen. che collega l’inutilizzabilità ad intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti, mentre l’art. 270 cod. proc. pen. deve ritenersi applicabile nel caso di procedimento originariamente diverso tenuto conto altresì del fatto che, nell’ambito di questo orientamento, alcune pronunce affermano che «i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 266 cod. proc. pen., sono sempre utilizzabili, ancorché lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, poiché in tal caso non trova applicazione l’art. 270 cod. proc. pen. che postula l’esistenza di più procedimenti “ab origine” tra loro distinti» (Sez. 6, n. 53418 del 4/11/2014; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014; Sez. 4, n. 29907 del 8/4/2015) mentre altre ritengono che gli esiti siano utilizzabili per tutti i reati, anche se per taluno di essi le operazioni di intercettazione non sarebbero autorizzabili (Sez. 6, n. 19496 del 21/2/2018; Sez. F., n. 35536 del 23/8/2016).
Volume consigliato
Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite
Prima di entrare nel merito della questione, le Sezioni Unite delimitavano la problematica processuale sottoposta al loro vaglio giudiziale nei seguenti termini: “se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all’art. 270 cod. proc. pen., riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione”.
Premesso ciò, gli Ermellini rilevavano altresì come l’esame della questione controversa presupponesse la ricognizione del quadro costituzionale di riferimento ossia una ricognizione che deve muovere dal richiamo all’art. 15 Cost. che a sua volta tutela due distinti interessi: «quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale» (Corte cost., sent. n. 34 del 1973).
Detto questo, veniva osservato che la stretta attinenza del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione al nucleo essenziale dei valori di personalità aveva indotto la giurisprudenza costituzionale «a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana» il che comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità: in base all’art. 2 Cost., «il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente» mentre, in base all’art. 15 Cost., «lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991).
Tal che se ne faceva discendere come l’esigenza di repressione dei reati corrisponda «a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile», interesse che giustifica «anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l’intercettazione telefonica»; d’altra parte, «le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991) e da qui la conclusione che «l’atto dell’autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche deve essere “puntualmente motivato”», ossia «deve avere una “adeguata e specifica motivazione”» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 34 del 1973).
Con particolare riferimento alla disciplina ex art. 270 cod. proc. pen. dell’utilizzazione probatoria dei risultati di un’intercettazione in altro procedimento, si notava come la giurisprudenza costituzionale avesse chiarito che la libertà della comunicazione «risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell’accertamento in giudizio di determinati reati» sicché «l’utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l’intervento del giudice richiesto dall’art. 15 della Costituzione in un’inammissibile “autorizzazione in bianco”, con conseguente lesione della “sfera privata” legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 63 del 1994).
Ciò posto, in questo quadro, si evidenziava come l’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. ponga «una norma del tutto eccezionale»: «la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell’ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all’accertamento di reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, risponde all’esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall’interesse dell’accertamento dei reati di maggiore gravità»; in altri termini, «la norma che eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalnnente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall’interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994).
Alla luce di tali pronunciamenti emessi dalla Consulta, veniva dunque rilevato come l’autorizzazione del giudice non si limiti a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova ma circoscrivi l’utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all’autorizzazione stessa risultino riconducibili posto che essa deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento, quest’ultimo, che, ad avviso della Cassazione, rende ragione della delimitazione dell’utilizzabilità probatoria dei risultati dell’intercettazione ai reati riconducibili all’autorizzazione giudiziale, delimitazione che, a sua volta, è condizione essenziale affinché l’intervento giudiziale abilitativo non si trasformi in una “autorizzazione in bianco” tenuto conto altresì del fatto che, già con riguardo al previgente codice di rito (e, come si vedrà, ad una diversa disciplina della materia in esame), la giurisprudenza costituzionale aveva chiarito che «nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante per l’imputazione di cui si discute» (Corte cost., sent. n. 34 del 1973).
Chiarito tale aspetto processuale, si osservava come l’eccezione a tale regola fosse rappresentata dall’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l’accertamento giudiziale di reati diversi da quelli riconducibili al provvedimento autorizzatorio motivato ossia per l’accertamento dei reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (ovvero, sotto il previgente codice di rito, il mandato di arresto obbligatorio) dato che, pur inviolabile, il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni può essere oggetto di bilanciamento e, dunque, conoscere restrizioni o limitazioni in relazione all’«inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante», quale, nei limiti di seguito indicati, la necessità di repressione dei reati.
La giurisprudenza della Consulta, inoltre, aveva ritenuto costituzionalmente valida la deroga alla regola della limitazione dell’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni funzionale ad assicurare che l’abilitazione giudiziale non si trasformi in un’”autorizzazione in bianco“, a condizione, tuttavia, che tale deroga risponda a due condizioni, espressione, entrambe, dell’«eccezionalità» del regime di utilizzazione per reati non riconducibili all’autorizzazione giudiziale: i casi eccezionali devono essere «tassativamente indicati dalla legge» e l’utilizzazione deve essere circoscritta «all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale», ossia per l’accertamento di «reati di maggiore gravità» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994).
Fuori da tali eccezionali casi, tassativamente previsti dalla legge ed afferenti all’accertamento di reati di maggiore gravità presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, rilevavano sempre le Sezioni Unite nella pronuncia qui in commento, l’autorizzazione del giudice si connota per una piena portata abilitativa e, dunque, costituisce non solo il fondamento di legittimazione del ricorso all’intercettazione ma anche il limite all’utilizzabilità probatoria dei relativi risultati ai soli reati riconducibili alla stessa autorizzazione: senza tale limitazione, il provvedimento autorizzatorio si trasformerebbe in un’inammissibile “autorizzazione in bianco“.
A sua volta la disciplina codicistica è in linea con questa ricostruzione della portata dell’autorizzazione giudiziale attribuendo al giudice «una funzione di controllo e di garanzia, essendogli riservato il potere di autorizzare l’atto, ovvero di convalidarlo, nel caso peculiare in cui l’urgenza non consenta un suo intervento preventivo» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp. Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 – Serie generale), e ciò anche perchè la stessa disciplina ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. dell’utilizzazione dei risultati dell’intercettazione in altri procedimenti – utilizzazione «ammessa solo se i risultati delle intercettazioni siano indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in fragranza» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, cit.) – conferma che, di regola, l’utilizzazione probatoria di detti risultati è vietata per i reati non riconducibili all’autorizzazione del giudice.
Richiamato, a grandi linee, il quadro costituzionale di riferimento, i giudici di piazza Cavour, a questo punto della disamina, ritenevano doveroso esaminare – in quanto stimato necessario ai fini dello scrutinio della questione ed anche alla luce delle indicazioni offerte dall’ordinanza di rimessione – i diversi indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Il primo, maggioritario, orientamento fa leva, nella definizione della nozione di “procedimento diverso” di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., su un criterio di natura – almeno tendenzialmente – sostanzialistica in quanto, fin dalle più risalenti pronunce, i profili essenziali dell’orientamento sono stati messi a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità: la nozione di “procedimento diverso” non coincide con quella di “diverso reato” (ex plurimis, Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997; Sez. 2, n. 9579 del 19/01/2004, Sez. 4, n. 7320 del 19/01/2010; più di recente, Sez. 3, n. 52503 del 23/09/2014; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013) essendo la prima più ampia della seconda; né la nozione di “procedimento diverso” può essere ricollegata a un dato di ordine meramente formale quale il numero di iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato (ex plurimis, Sez. 6, n. 1972 del 1997; Sez. 1, n. 46075 del 04/11/2004; Sez. 2, n. 7995 del 03/02/2006 o Sez. 3, n. 29473 del 09/05/2012; più di recente, Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013; Sez. 2, n. 27473 del 29/05/2014) posto che la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l’utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015); decisivo, invece, è il riferimento al contenuto della notizia di reato ossia al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (ex plurimis, Sez. 6, n. 5192 del 25/02/1997; Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018).
Il legame tra la notizia di reato in relazione alla quale è stata autorizzata l’intercettazione e quella emersa dai risultati dell’intercettazione che, se riconosciuto, esclude la diversità dei procedimenti e, con essa, il divieto di utilizzazione di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., è delineato dal canto suo facendo riferimento ad indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato (ex plurimis, Sez. 6, n. 2135 del 10/05/1994; Sez. 3, n. 1208 del 14/04/1998; Sez. 1, n. 2930 del 17/12/2002; Sez. 3, n. 348 del 13/11/2007; Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009; più di recente, Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012; Sez. 6, n. 20910 del 15/03/2012; Sez. 5, n. 26693 del 20/01/2015; Sez. 5, n. 32779 del 10/05/2016; Sez. 3, n. 28516 del 28/02/2018; nonché Sez. 4, n. 7320 del 2010 e Sez. 2, n. 19730 del 01/04/2015 che, peraltro, richiamano anche il principio di diritto proprio del terzo orientamento), non potendosi risolvere nell’esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale (Sez. 3, n. 2608 del 05/11/2015) ma essendo necessaria la sussistenza di una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. o di un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (ex plurimis, Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014; Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015).
Precisato ciò, si faceva al contempo presente come a questo primo orientamento avessero aderito anche le Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris: secondo Sez. U, Floris, difatt, «la, prevalente e più recente, giurisprudenza di legittimità ha ancorato la nozione di procedimento diverso ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l’esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico».
Sempre con riferimento al primo orientamento, la Suprema Corte reputava necessario fare due annotazioni.
La prima, in favore del primo orientamento (soprattutto in rapporto al terzo) e, dunque, del presupposto interpretativo che distingue, nella ricostruzione della portata del divieto probatorio ex art. 270 cod. proc. pen., la nozione di “procedimento” da quella di “reato“, consiste nel fatto che non può essere invocata la disciplina dettata dal comma 2 dell’art. 270 cit. che, lì dove prescrive il deposito presso l’autorità competente per il diverso procedimento dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni autorizzate, presuppone appunto la distinzione tra procedimento e reato per il cui accertamento i risultati sono utilizzati atteso che, in realtà, la disciplina di cui all’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. ben potrebbe essere riferita in via esclusiva ai reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza sicché, ai fini in esame, la disciplina di cui al citato comma 2 è sostanzialmente neutra.
La seconda, sempre in merito al primo orientamento, consiste nel fatto che alcune delle decisioni in linea con il principio di diritto affermato da Sez. U, Floris hanno affrontato, giungendo a conclusioni diverse, un diverso problema, rappresentato dalla necessità o meno che il reato emerso nel corso dell’intercettazione rientri nei limiti di ammissibilità dettati, in particolare, dall’art. 266 cod. proc. pen. e al quesito si è data, per un verso, risposta affermativa sostenendo, da una parte, che, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, non possono considerarsi pertinenti a “diverso procedimento” risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l’autorizzazione giudiziale e, dall’altra, che dette risultanze possono essere utilizzate solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4942 del 15/01/2004; conf. Sez. 1, n. 14595 del 17/11/1999), per altro verso, l’opposta soluzione – ma sempre nella prospettiva delineata dal primo orientamento – è stata sostenuta affermando che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati nell’art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili pure relativamente ad altri reati che emergano dall’attività di captazione anche se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite sempre che tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 45535 del 16/03/2016).
Il secondo orientamento, invece, valorizza l’inerenza delle risultanze relative a reati diversi da quelli oggetto del provvedimento autorizzativo al medesimo procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto: in questa prospettiva è stato affermato che, qualora l’intercettazione sia legittimamente autorizzata all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui emerga la conoscenza dall’attività di captazione mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l’utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall’art. 270 cod. proc. pen. e, cioè, all’indispensabilità ed all’obbligatorietà dell’arresto in flagranza (ex plurimis, Sez. 2, n. 9500 del 23/02/2016; Sez. 5, n. 26817 del 04/03/2016; Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015; Sez. 4, n. 29907 del 08/04/2015).
Pertanto, alla luce di questo approdo ermeneutico, il dato dell’unitarietà iniziale del procedimento segna, nella prospettiva del secondo orientamento, il limite dell’operatività del divieto di utilizzazione ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen.: infatti, «sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell’art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell’utilizzazione extraprocedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell’art. 266 c.p.p.» (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012) sicché «ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell’ambito dello stesso procedimento, ancorché diano luogo a distinte iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. ed alla germinazione di altri procedimenti, il richiamo all’art. 270 cod. proc. pen. è del tutto fuorviante» (Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016) fermo restando che anche nell’ambito del secondo orientamento si registra una divaricazione sul punto relativo alla necessità o meno che il reato emerso nel corso dell’intercettazione rientri nei limiti di ammissibilità dettati, in particolare, dall’art. 266 cod. proc. pen. in quanto: 1) nella prima direzione si muovono le decisioni secondo cui, qualora l’intercettazione sia legittimamente autorizzata all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento purché, in relazione ad essi, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del medesimo art. 266 (Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015; Sez. 6, n. 27820 del 17/06/2015; Sez. 6, n. 53418 del 04/11/2014); 2) nella seconda prospettiva, invece, è stato postulato, recisamente, che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati all’art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili pure relativamente ad altri reati che emergano dall’attività di captazione anche se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 19496 del 21/02/2018; Sez. 5, n. 15288 del 09/02/2018; Sez. 6, n. 31984 del 26/04/2017; Sez. F, n. 35536 del 23/08/2016; Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012; Sez. 3, n. 39761 del 22/09/2010).
Il complesso quadro degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa si completa con il riferimento ad un terzo orientamento, più risalente nel tempo e più restrittivo nel legittimare l’utilizzazione probatoria dei risultati dell’intercettazione con riguardo a reati diversi da quelli in relazione ai quali il mezzo di ricerca della prova era stato autorizzato.
Secondo tale indirizzo, al di fuori dei casi tassativamente indicati nell’art. 270 cod. proc. pen., non è consentita l’utilizzazione in un procedimento penale delle risultanze emerse da intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento neppure quando i due procedimenti siano strettamente connessi sotto il profilo oggettivo e probatorio (Sez. 3, n. 9993 del 03/07/1991): in contrapposizione al primo orientamento, si è osservato che la nozione di “diverso procedimento” ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. va ricollegata «al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quelli fatto oggetto delle indagini relativi ad altro, differente, anche se connesso, procedimento» sicché ricomprendere in essa la connessione o il collegamento dei procedimenti comporterebbe «la sostanziale elusione del divieto in detta disposizione sancito dal legislatore» (Sez. 4, n. 4169 del 11/12/2008, dep. 2009; più di recente, in analoga prospettiva, Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012).
Concludendo la disamina di questi indirizzi nomofilattici, veniva da ultimo rimarcato come il secondo e il terzo — pur così distanti negli esiti cui pervengono — rivelino un tratto comune valorizzando entrambi, anche implicitamente, la ricostruzione della nozione espressa dal sintagma “diverso procedimento“: il secondo orientamento legge detta nozione in termini formali ossia considerando “procedimento” quello, contrassegnato da un certo numero di iscrizione nel registro della notizia di reato (ossia, nel gergo giudiziario, il “fascicolo” iscritto al modello noti o ignoti) nel quale l’intercettazione era stata originariamente autorizzata; il terzo orientamento, invece, instaura un’inscindibile correlazione tra il “procedimento” e la singola notizia di reato relativa ad un determinato, specifico fatto-reato.
Ciò premesso, si reputava opportuno osservare come la questione posta all’esame delle Sezioni unite si fosse, almeno nelle sue linee essenziali, già presentata sotto il previgente codice di rito.
In sintesi, il quadro normativo vide, con l’introduzione dell’art. 226-quater, cod. proc. pen. 1930 ad opera della legge 8 aprile 1974, n. 98, la previsione, nell’ottavo comma, di un generalizzato divieto probatorio di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali erano state raccolte.
Il divieto in questione conobbe un sensibile ridimensionamento con le modifiche introdotte dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 che, con l’art. 8, sostituì l’art. 226-quater, cit, il cui nuovo sesto comma stabiliva l’utilizzabilità delle notizie tratte dalle intercettazioni nei procedimenti relativi a reati per i quali era obbligatorio il mandato di cattura.
La dottrina dell’epoca non mancò a questo proposito di rimarcare come il legislatore avesse “rotto” il collegamento, presente nel testo anteriore alla novella, tra motivazione del provvedimento ed impiego processuale di quanto acquisito con l’intercettazione.
Veniva dunque in rilievo quella deroga alla regola della limitazione dell’utilizzabilità probatoria dei risultati dell’intercettazione ai reati riconducibili all’autorizzazione giudiziale che la più recente giurisprudenza costituzionale formatasi sull’art. 270 cod. proc. pen. aveva ritenuto eccezionalmente valida alla duplice condizione della tassativa previsione legislativa dei reati per i quali il risultato del mezzo di ricerca della prova è utilizzabile e della riconducibilità di tali reati alla categoria predeterminata dei reati di maggiore gravità presuntivamente idonei a destare particolare allarme sociale.
In un quadro normativo caratterizzato da significative similitudini rispetto a quello oggi vigente, si manifestò un contrasto nella giurisprudenza di legittimità tra un indirizzo secondo cui le intercettazioni telefoniche, legittimamente eseguite, potevano essere utilizzate non come prove in procedimenti diversi da quelli per i quali furono autorizzate (Sez. 2, n. 2451 del 06/12/1978) ma solo come notitia criminis (Sez. 6, n. 4913 del 09/03/1983) e un altro secondo cui la circostanza che le intercettazioni telefoniche ab initio risultassero legittimamente richieste, validamente autorizzate e regolarmente eseguite comportava la loro piena utilizzabilità nei confronti di qualsiasi soggetto a carico del quale esse avessero consentito l’accertamento di elementi di responsabilità indipendentemente dal fatto che fossero state «richieste ed autorizzate per fatti-reati diversi da quelli che hanno dato luogo al presente procedimento» (Sez. 1, n. 10827 del 23/06/1986).
Pur a fronte di una disciplina in relazione alla quale si erano registrate divergenze interpretative nella giurisprudenza di legittimità, il legislatore del nuovo codice di rito non aveva affrontato espressamente la questione delineando la disciplina in esame in termini del tutto simili a quella anteriore e, ad avviso della Corte, tale rilievo giovava a mettere in luce, da un primo punto di vista, la necessità, anche per questo tema, di affiancare, alla ricostruzione del significato del dato letterale delle disposizioni in questione, le indicazioni offerte dall’interpretazione sistematica valorizzando la ratio del divieto probatorio di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. e i principi costituzionali di cui è espressione.
Ciò posto, allo scopo di definire con chiarezza il perimetro della questione controversa e il principio di diritto che, in relazione ad essa, doveva (ed è stato) enunciato nel caso di specie, per il Supremo Consesso, si rendeva necessaria una duplice puntualizzazione ossia come non fosse in discussione per la Cassazione l’orientamento, del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche, in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (Sez. 2, n. 17759 del 13/12/2016; conf. Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010; Sez. 4, n. 2596 del 03/10/2006, dep. 2007; Sez. 5, n. 23894 del 02/05/2003; Sez. 6, n. 31 del 26/11/2002): orientamento, questo, del tutto in linea con le indicazioni del giudice delle leggi secondo cui «il divieto disposto dall’art. 270 cod. proc. pen. è estraneo al tema della possibilità di dedurre “notizie di reato” dalle intercettazioni legittimamente disposte nell’ambito di altro procedimento» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991) così come non venisse in rilievo, nel caso in esame, l’ipotesi della conversazione intercettata che costituisca corpo del reato [al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte avevano affermato che, in tema di intercettazioni, «la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale» (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014)].
Chiariti tali aspetti processuali, gli Ermellini stimavano opportuno, prima di approfondire l’esame dei tre orientamenti richiamati, affrontare un problema che contribuiva, ad avviso della Corte, a definire la stessa portata della questione controversa rimessa alla cognizione delle Sezioni unite ossia il problema della necessità o meno che il reato accertato sulla base dell’intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova.
Orbene, a tale quesito la Cassazione dava risposta affermativa in quanto, attraverso l’individuazione dei reati in relazione ai quali l’intercettazione può essere autorizzata, i limiti di ammissibilità definiscono il perimetro legale all’interno del quale il giudice deve operare le valutazioni relative alla sussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti dell’autorizzazione (in ordine, ad esempio, al presupposto indiziario di cui all’art. 267 cod. proc. pen.) e, pertanto, la previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati in particolare per le intercettazioni “ordinarie” dall’art. 266 cod. proc. pen. attraverso il riferimento alla comminatoria edittale del reato e/o l’indicazione di tipologie generali o specifiche di fattispecie incriminatrici in relazione alle quali viene chiesta l’autorizzazione) è espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta di legge ex art. 15 Cost., che governa la materia delle intercettazioni, e dell’istanza di rigorosa – e inderogabile – tassatività che da essa discende (cfr. Corte cost., sent. n. 63 del 1994) riconnettendosi alla «natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione)» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991).
Invero, consentire, in caso di connessione dei reati (primo orientamento) o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto (secondo orientamento), l’utilizzazione probatoria dell’intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge, ad avviso della Suprema Corte, si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, «con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’art. 266 cod. proc. pen. che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all’art. 15 della Costituzione» (Sez. 6, n. 4942 del 2004; conf., nella prospettiva del secondo orientamento, Sez. 1, n. 24819 del 12/07/2016).
Del resto, l’indiscriminato, in quanto svincolato dall’osservanza dei limiti di ammissibilità previsti dalla legge, allargamento dell’area dei reati per i quali – in presenza delle condizioni delineate, rispettivamente, dal primo e dal secondo orientamento – sarebbero utilizzabili i risultati delle intercettazioni incrinerebbe il bilanciamento tra i valori costituzionali contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, da una parte; dall’altra, l’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire i loro autori) che è assicurato dall’art. 270 cod. proc. pen.: bilanciamento garantito, prima di tutto, dalla riserva assoluta di legge, che, da un lato, comporta la fissazione di limiti di ammissibilità per l’autorizzazione del mezzo di ricerca della prova e, dall’altro, impone al legislatore di individuare i reati “ulteriori” rispetto ai quali riconoscere
l’utilizzabilità probatoria dei risultati dell’intercettazione in un ambito ben definito ossia «limitatamente all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994).
Tal che se ne faceva discendere come l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell’ambito di un “medesimo procedimento” (nell’accezione di seguito delineata all’esito dell’esame degli orientamenti sulla questione controversa) presupponga che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge.
Chiarito questo, venendo all’esame più specifico dei diversi indirizzi, esigenze di linearità nell’esposizione suggerivano, secondo il parere della Corte, di muovere dallo scrutinio del secondo orientamento, che si riteneva non potere essere seguito posto che detto orientamento fa leva su una nozione formale di “procedimento” in quanto connotato da un determinato numero di iscrizione nei registri delle notizie di reato e, di conseguenza, la diversità del procedimento ex art. 270 cod. proc. pen. viene «ricollegata a dati meramente formali, quali la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato» (Sez. 3, n. 1208 del 14/04/1998; conf. Sez. 1, n. 2930 del 17/12/2002) mentre, nel lessico del codice di procedura penale, il riferimento al “procedimento” si presenta tutt’altro che univoco: in termini generali, esso, come è noto, viene giustapposto al “processo” così delineando «una netta scansione tra il procedimento, che si articola nelle indagini preliminari, e il processo, che nasce quando il pubblico ministero imbocca la strada della formulazione dell’accusa rendendo ineludibile la pronuncia giurisdizionale» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, cit.); tuttavia, nella stessa terminologia codicistica, il termine “procedimento” allude anche al singolo reato commesso da una persona (art. 12).
Pertanto, ai fini della definizione della portata del divieto probatorio di cui all’art. 270 cod. proc. pen., la nozione di “procedimento“, ove intesa nell’accezione formale presupposta dall’indirizzo in esame (ossia, secondo un’efficace espressione dottrinale, come «contenitore dell’attività di indagine»), è, in realtà, affermazione che, ad avviso del Supremo Consesso, proprio per la plurivocità semantica del termine “procedimento“, richiede una specifica giustificazione senza la quale si risolve, in buona sostanza, in una petizione di principio: specifica giustificazione che va ricercata sul terreno dell’interpretazione sistematica e guardando alla ratio del divieto e ai principi costituzionali di cui è espressione.
In effetti, fuori dei casi di utilizzazione probatoria dei risultati dell’intercettazione in quanto indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (art. 270, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.), nella prospettiva del secondo orientamento, la circostanza che l’intercettazione sia stata disposta «all’interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex art. 266 c.p.p.» fa sì che i suoi risultati «siano utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna» (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012) ma, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, «la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l’utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015): in altri termini, svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l’ulteriore reato emerso dai risultati dell’intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. viene, in buona sostanza, schiacciata sul «contenitore dell’attività di indagine» e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla “sede” procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali – e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina – o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l’autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlata.
Invero, il criterio formale dell’inerenza del “nuovo” reato al medesimo «contenitore dell’attività di indagine» sul quale fa leva il secondo orientamento ne mette in luce l’incompatibilità con la portata dell’autorizzazione giudiziale delineata dall’art. 15 Cost., che investe l’utilizzazione probatoria dei risultati dell’intercettazione e, di regola, non solo l’impiego del mezzo di ricerca della prova tenuto conto altresì del fatto che, ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale, fuori dalle ipotesi in cui «eccezionalmente» e nei «casi tassativamente indicati dalla legge» è consentita «l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994).
La configurazione del provvedimento autorizzatorio prescritto dall’art. 15 Cost., dunque, esige l’effettività e il saldo ancoraggio alla fattispecie concreta dell’autorizzazione del giudice che deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991).
Di conseguenza, ritenere, sulla scorta del secondo orientamento, utilizzabili i risultati dell’intercettazione disposta per uno dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. pen. anche per gli altri reati di cui è emersa la conoscenza grazie all’intercettazione stessa e ciò indipendentemente da qualsiasi legame sostanziale tra il primo e i secondi, ad avviso della Cassazione, significherebbe imprimere all’autorizzazione del giudice quella connotazione di “autorizzazione in bianco” messa al bando dalla giurisprudenza costituzionale.
Enunciate le ragioni sul perché non poteva essere condiviso il secondo orientamento interpretativo analizzato in precedenza, si procedeva al confronto tra il primo e il terzo orientamento rilevandosi prima di tutto come quest’ultimo, in buona sostanza, muova da una considerazione della nozione di “procedimento” come sinonimo di “reato” restando così inidoneo ad inibire l’operatività del divieto probatorio qualsiasi legame sostanziale tra il reato in relazione al quale l’intercettazione è stata autorizzata e il reato accertato grazie ai risultati della stessa: il concetto di “diverso procedimento“, secondo questo terzo indirizzo, deve dunque essere collegato «al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quelli fatto oggetto delle indagini relative ad altro, differente, anche se connesso, procedimento» (Sez. 4, n. 4169 del 2008) rilevandosi al contempo come, a sostegno di tale indirizzo – e dell’equazione procedimento/reato sul quale si fonda – era stata richiamata, nel dibattito dottrinale, la disciplina dettata dall’art. 335 cod. proc. pen. ritenuta idonea ad offrire, anche ai fini in esame, una definizione di “procedimento” integrata dai criteri relativi al reato indicato, alla persona cui è attribuito, nonché alla data e al numero progressivo di iscrizione.
Pur tuttavia questa tesi veniva ritenuta non condivisibile dalle Sezioni Unite nei seguenti termini: “anche a voler prescindere dal rilievo sopra proposto in ordine al carattere tutt’altro che univoco del riferimento al “procedimento” nel lessico generale del codice di rito, non può essere sottaciuta la considerazione che, correlando la nozione di “procedimento” all’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., dovrebbe essere considerato “diverso procedimento” quello iscritto nei confronti di una persona nota per un certo reato a seguito delle intercettazioni disposte in un procedimento contro ignoti per quel medesimo fatto-reato: esito, questo, all’evidenza disallineato rispetto alla disciplina codicistica (che, per le intercettazioni “ordinarie”, richiede, ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen., solo la sussistenza di «gravi indizi di reato»), essendo del tutto pacifico che se un’intercettazione telefonica è validamente autorizzata, essa può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale faccia emergere elementi di responsabilità per quel reato (Sez. 6, n. 9822 del 01/07/1992, omissis, Rv. 192008). Del resto, sarebbe all’evidenza irrazionale una disciplina che consentisse il ricorso all’intercettazione in un procedimento contro ignoti e ne precludesse poi l’utilizzabilità nel confronti dell’autore del reato scoperto grazie all’intercettazione stessa. Inoltre, dovrebbe essere considerato “diverso procedimento” anche quello nuovamente iscritto a seguito di riapertura delle indagini ex art. 414, comma 2, cod. proc. pen., laddove, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, in tale ipotesi non si instaura un procedimento diverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indagini già svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni (Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995, dep. 1996, omissis, Rv. 203741). Ad abundantiam, può inoltre osservarsi che la stessa equazione procedimento/reato è smentita, proprio sullo specifico terreno della disciplina delle intercettazioni, dal comma 1-bis dell’art. 270 cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 4, d. Igs. 29 dicembre 2017, n. 216, ma oggetto di vari differimenti quanto all’entrata in vigore), lì dove (cosi come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) stabilisce che i risultati delle intercettazioni operate con un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile «non possono essere utilizzati come prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione» (salvo, anche qui, che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza). Di per sé solo non decisivo, il dato normativo appena richiamato – relativo alla specifica disciplina delle intercettazioni e non già ad una “onnicomprensiva” definizione della nozione di “procedimento” preclusa, come si è detto, dalle non univoche indicazioni codicistiche – assume significativa pregnanza nel quadro delle considerazioni di ordine sistematico appena svolte e, soprattutto, di quelle di seguito proposte circa il dirimente criterio incentrato sulla connessione ex art. 12 cod. proc. pen.. In questa prospettiva, il significato normativo del riferimento al “reato” e non già al “procedimento” è volto a distinguere il regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Solo per il captatore informatico – e, dunque, non per le intercettazioni, per così dire, “tradizionali” – tale regime viene (a parte i casi di reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza) delineato con riguardo al “reato” per il quale è intervenuto il provvedimento autorizzatorio: distinzione, questa, che, smentisce il presupposto sul quale si basa il terzo orientamento. Invero, nelle more del deposito della presente sentenza, l’art. 2, comma 1, lett. g), n. 1) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 ha sostituito il comma 1-bis dell’art. 270 cod. proc. pen.: resta, sul piano interpretativo, comunque valida l’indicazione offerta dal medesimo comma 1-bis, nella formulazione alla data della deliberazione della presente sentenza, in ordine alla distinzione, nella terminologia del legislatore relativa alla specifica disciplina delle intercettazioni, tra “reato” e “procedimento””.
Ciò posto, le Sezioni unite aderivano all’impostazione di fondo del primo orientamento pur con alcune ulteriori puntualizzazioni.
Rilevata, sia pure in termini generali, la coerenza di tale orientamento con il dettato legislativo, diveniva, infatti, per la Corte, decisiva la valutazione circa la sua tenuta rispetto alla portata dell’autorizzazione giudiziale più volte ricordata: si tratta, in altri termini, ad avviso della Corte, di verificare quale “legame sostanziale” tra il reato in relazione al quale l’autorizzazione all’intercettazione è stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest’ultimo reato riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in linea con l’art. 15 Cost., che vieta “autorizzazioni in bianco“.
Detto questo – una volta fatto presente che tale legame sostanziale è individuato dalla giurisprudenza di legittimità richiamando ora l’esistenza di una connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto dell’originaria notizia di reato per la quale sono state disposte le intercettazioni e i reati per i quali si procede, ora – ma in termini sostanzialmente sovrapponibili – la sussistenza, tra i due fatti-reato pur storicamente differenti, di ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. o, comunque, di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen. sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico – si evidenziava come i due criteri di individuazione del legame sostanziale si prestassero, però, a valutazioni diverse.
La connessione ex art. 12 cod. proc. pen., difatti, riguarda – per riprendere la definizione offerta da un insegnamento dottrinale – procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta, come è noto, di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013).
Il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende dunque ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett. c) dell’art. 12 cit., in particolare, è stato rilevato come esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017) e, dunque, un legame indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale – prima ancora che processuale – sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso per la cui integrazione è necessario «che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017).
In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., di conseguenza, il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione e, pertanto, la parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato, consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvediménto autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l’autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un’”autorizzazione in bianco“.
Del resto, operandosi in tal guisa, ad avviso delle Sezioni Unite, si offre una soluzione che, d’altra parte, consente di attribuire al sintagma “procedimenti diversi” un significato coerente con i differenti riferimenti normativi ora, appunto, ai procedimenti (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.), ora ai reati (art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., cosi come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) impiegati dal legislatore nella specifica disciplina delle intercettazioni.
A diverse conclusioni, invece, secondo la Corte, deve giungersi con riferimento all’altro criterio valorizzato dal primo orientamento ossia a quello basato sul collegamento investigativo di cui all’art. 371 cod. proc. pen. (fuori dei casi di connessione, naturalmente) dato che, anche nelle ipotesi delineate dalla lett. b) del comma 2, dell’art. 371 cod. proc. pen., il collegamento, così come configurato dal legislatore codicistico, risponde ad esigenze di efficace conduzione delle indagini ma le relazioni tra i reati alla base dell’istituto non presuppongono quel necessario legame originario e sostanziale che consente invece di ricondurre anche il reato oggetto del procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. all’originaria autorizzazione; infatti, con specifico riguardo alle prime due ipotesi della disposizione, si tratta di relazioni intercorrenti non già tra il reato in riferimento al quale è stata emessa l’autorizzazione e quello messo in luce dall’intercettazione ma tra le “conseguenze” del primo e il secondo ovvero di relazioni che si risolvono in una mera “occasionalità” tra la commissione dell’uno e dell’altro: si tratta, dunque, di relazioni “deboli” che il legislatore del 2001 (legge 1 marzo 2001, n. 63) ha espunto dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 12 cod. proc. pen. per ripristinare, in larga misura, l’originaria configurazione codicistica della connessione, che era stata modificata nel 1991 (decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con la legge 20 gennaio 1992, n. 8) così recependo le preoccupazioni di chi aveva visto nella novella dei primi anni ’90 un grave pregiudizio alla coerenza della costruzione della connessione come criterio direttamente attributivo di competenza, ossia come criterio autonomo e originario. L’intrinseca natura delle relazioni presupposte dalle figure di collegamento in esame e le univoche indicazioni sistematiche offerte da quello che è stato definito il “ritorno alle origini” sancito dal legislatore del 2001, secondo il Supremo Consesso, convergono nell’escludere che dette figure diano corpo a quel «legame oggettivo» tra i reati necessario per assicurare la riconducibilità del “nuovo” reato all’autorizzazione giudiziale così da non eludere la garanzia costituzionale della motivazione del provvedimento autorizzatorio e tale rilievo è valido a fortiori anche per le altre figure di collegamento delineate dalla lett. b) del comma 2 dell’art. 271 cod. proc. pen., considerate fin dalla formulazione originaria della disposizione codicistica nella sola prospettiva dell’efficace conduzione delle indagini mentre a nulla rileva evocare la disciplina della riunione di processi che richiama sia i casi di connessione, sia quelli di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., posto che l’istituto di cui all’art. 17 cod. proc. pen. si risolve in un «criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario» (Corte cost., ord. n. 247 del 1998; conf. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013): criterio, di per sé solo, senz’altro inidoneo ad esprimere il legame sostanziale tra i diversi reati indispensabile per considerare “non diverso” il procedimento ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen.
D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità, espressiva del primo orientamento, aveva avvertito le difficoltà sottese all’assunzione del collegamento ex art. 371 cod. proc. pen. quale «criterio di valutazione sostanzialistico» ai fini in esame e, quanto alla lett. c) del comma 2, ne aveva limitato la portata, sul piano dell’utilizzabilità, alle intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento posto che, diversamente ragionando, e presupponendosi sempre e comunque come “stessa fonte” l’intercettazione eseguita in un procedimento ed utilizzandola quindi indiscriminatamente nei diversi procedimenti, sarebbe eluso il divieto di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., rendendo sempre possibile l’utilizzo delle captazioni nel diverso procedimento fondato sulle risultanze delle medesime intercettazioni (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 29856 del 2018).
La soluzione prospettata in questi termini, tuttavia, ad avviso delle Sezioni Unite, non poteva essere condivisa in quanto, oltre ad innestare nell’assetto incentrato su un criterio di valutazione sostanzialistico un diverso criterio eminentemente formale (l’identità di procedimento) con tutte le insuperabili aporie già evidenziate in precedenza in questa stessa pronuncia, la limitazione indicata non risolve il problema decisivo ossia l’individuazione di un criterio che assicuri la sussistenza di un legame sostanziale e “forte” tra i reati così da poterne escludere la riferibilità, ai fini della disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen., a “procedimenti diversi“.
Da ciò se ne faceva conseguire come il divieto probatorio dell’utilizzo di intercettazioni in relazione a reati diversi da quelli in relazione ai quali l’autorizzazione del giudice è stata adottata sia destinato ad operare in presenza di un rapporto tra i reati riconducibile – fuori dai casi di connessione – alle ipotesi di collegamento tra indagini così come alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo al criterio dell’identità del “filone investigativo” valorizzato, sempre nel solco del primo orientamento, da alcune pronunce; difatti, nel far leva sulla «concatenazione inferenziale tra i risultati a mano a mano acquisiti» (Sez. 6, 17698 del 23/03/2016) anche tale criterio, in buona sostanza, valorizza un collegamento di tipo probatorio tra reato a quo, per il quale è stata disposta l’intercettazione, e reato ad quem accertato grazie ai risultati di tale intercettazione, e non su quel legame originario e sostanziale necessario a ricondurre anche il secondo al provvedimento autorizzatorio e, quindi, ad escludere l’operatività del divieto probatorio di cui all’art. 270 cod. proc. pen.
Alla luce della nozione di “procedimenti diversi” delineata nei termini sin qui esposti, gli Ermellini concludevano nel senso che – ferma restando l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non rientrano nella sfera del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate solo i reati, accertati in virtù dei risultati delle intercettazioni, connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta: quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono “diversi” a norma dell’art. 270 cod. proc. pen..
Le Sezioni Unite, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formulavano il seguente principio di diritto: “Il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge”.
Conclusioni
La decisione in questione desta notevole interesse in quanto chiarisce la portata applicativa dell’art. 270, c. 1, c.p.p. che, come è noto, dispone che i “risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”.
Difatti, in questo arresto giurisprudenziale, viene affermato che siffatto divieto non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
Tal che ne discende che il divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza non è configurabile: I) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; II) se i reati siano stati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; III) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri; IV) per i reati in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
Volume consigliato




















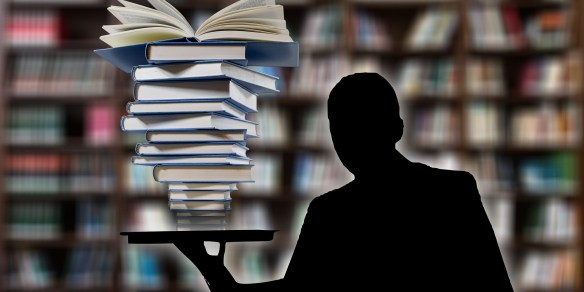
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento